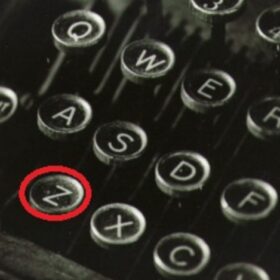Figli della stessa rabbia. Lo scontro di piazza nell’Italia repubblicana
L’insorgenza del movimento dei movimenti, fin dal suo battesimo a Seattle nel novembre-dicembre 1999, ha, fra le mille questioni sollevate, riportato al centro dell’attenzione il tema della gestione della piazza da parte dei movimenti conflittuali e delle forze dell’ordine costituito. La spirale di violenza crescente con la quale le polizie di differenti paesi hanno reagito al conflitto sociale e alla disubbedienza attiva dei movimenti fino al criminale assassinio di Carlo Giuliani durante le giornate di Genova 2001, ha fatto da contraltare alla crescita di una conflittualità che spesso ha scelto di rappresentarsi con una forte disponibilità all’azione violenta – esplicitata sia in forme nuove e innovative che con una sostanziale riproposizione di consolidati cliché.
Da questo punto di vista Genova sembra segnare una sorta di spartiacque all’interno del movimento dei movimenti; da un lato il rischio di ripetere pedissequamente un percorso già noto e sperimentato negli anni ’70, con l’avvitamento nelle dinamiche della repressione – reazione alla repressione – nuova repressione; dall’altro la consapevolezza che la scelta diretta della violenza di piazza, per un movimento composito e dalle molte anime, regalerebbe una completa egemonia, anche a livello di autorappresentazione, a quei settori che tendono a ridurre il conflitto alla sua rappresentazione in azioni dirette violente, più o meno teatrali.
Parallelamente, dal punto di vista dell’ordine costituito, la tragedia dell’11 settembre 2001 ha in parte legittimato nell’opinione pubblica occidentale l’isteria repressiva, dando nuova linfa allo sviluppo di concetti come quello di “guerra asimmetrica”, nei quali il confine fra nemico esterno e interno appare labile, con una forte spinta alla riduzione del conflitto sociale a un problema di ordine militare più che politico.
Il drammatico esito delle giornate genovesi del luglio 2001, pur se interno alla dimensione internazionale di un conflitto contro i nuovi poteri imperiali da parte di un movimento sovranazionale, per essere avvenuto nel nostro paese e per aver visto come protagonisti “negativi” gli apparati repressivi dello stato italiano, può essere in qualche modo letto anche all’interno di una vicenda di lungo periodo, specificamente nazionale, che riguarda la gestione delle piazze e dell’ordine pubblico in situazioni conflittuali nella storia dell’Italia repubblicana. Questo saggio è una prima riflessione sul tema, con il tentativo di individuare alcune continuità, ma anche le evidenti cesure intervenute nel corso di circa 60 anni di storia nazionale. Continuità nel ricorso, assai frequente – e non solo per il periodo repubblicano[ref](1) Da Bava Beccaris nel 1898 a Roatta nel 1943, la scelta di sparare sui manifestanti che chiedono pane, lavoro o la fine della guerra, è un’abitudine alla quale la gestione dell’ordine pubblico repubblicano si adegua in una sostanziale continuità.[/ref] -, all’uso della forza da parte dei poteri costituiti, con un’impressionante – oltre che completamente rimossa dalla memoria collettiva – lista di vittime uccise dalle forze dell’ordine in scontri di piazza; ma allo stesso tempo le evidenti cesure riscontrabili sia riguardo ai protagonisti in campo – e ai loro comportamenti – che al contesto storico-politico, nazionale e internazionale, nel quale le vicende avvennero.
Un’analisi attenta, per esempio, al differente ruolo che nella storia repubblicana hanno giocato la polizia di stato e i carabinieri non può perdere di vista il fatto che in momenti diversi uno dei due corpi addetti al mantenimento dell’ordine pubblico ha svolto un ruolo più centrale nell’esercizio della forza in piazza rispetto all’altro, così come non è da sottovalutare il fatto che, nei momenti di collaborazione e compresenza, i compiti, l’esposizione pubblica e a volte la pratica concreta di polizia e carabinieri non possano essere del tutto accomunati[ref](2) Si pensi a questo proposito ancora alle giornate di Genova 2001, con i carabinieri che si assumono la responsabilità di attaccare in piazza i cortei pacifici e la polizia che si espone maggiormente sia dal punto di vista teatrale, con le marce ritmate battendo i manganelli sugli scudi, in una sorta di contro canto rispetto alle ridicole parate dei black blok, sia nel “lavoro sporco” dell’irruzione alla scuola Diaz e delle “torture” nella caserma Bolzaneto.[/ref]. Allo stesso modo, dall’altra parte della barricata – per rimanere in tema -, cambiano profondamente le caratteristiche, la composizione sociale e le finalità stesse dei movimenti che rompono la pace sociale e portano anche nelle strade e nelle piazze, il conflitto.
È chiaro che la scelta di manifestare pubblicamente con cortei, comizi, sit-in o altro, non significa di per sé ricercare lo scontro di piazza e le differenti azioni non possono essere disinvoltamente mescolate in una sorta di reazionario principio di causa-effetto; resta il fatto che la manifestazione di piazza è sicuramente un “atto perturbante” rispetto al normale svolgersi della vita quotidiana[ref](3) L’odioso tran-tran che gli studenti francesi irridevano con lo slogan contro una vita metro-boulot-dodo.[/ref], ma anche un qualcosa di più nel quadro del conflitto sociale, la sua rappresentazione pubblica che intende esportare un conflitto esistente dal suo contesto, per generalizzarlo e in qualche modo pubblicizzarlo. La scelta dell’opzione voice rispetto al possibile exit, per riprendere la coppia di concetti utilizzata da Albert Hirschmann[ref](4) Albert O. Hirschman, Lealtà, defezione, protesta, Bompiani, 1982.[/ref], rimanda a un coinvolgimento personale in azioni di protesta che racchiude sia una dimensione ricca di simbologie che una disponibilità a esporsi in situazioni di potenziale pericolo.
A tal proposito, scriveva Eric Hobsbwan in un suo lontano studio sul passaggio dalle antiche forme di ribellismo all’organizzazione del movimento operaio:
Le dimostrazioni, il cui scopo originario era, nei movimenti operai, quello utilitaristico di dimostrare agli avversari la forza della coesione delle masse lavoratrici e di incoraggiare con questo mezzo i loro sostenitori, divennero cerimonie di solidarietà il cui valore, dal punto di vista di molti partecipanti, sta tanto nell’esperimentare la propria unità quanto in qualsiasi fine pratico che si possa cercare di ottenere. Sorge così una complessa strumentazione rituale: stendardi, bandiere, inni corali e così via[ref](5) Eric J. Hobsbawn, I ribelli. Forme primitive di rivolta sociale, Einaudi, 1966, pp. 192-193.[/ref].
La manifestazione di piazza è quindi al tempo stesso, sia una “prova di forza”, nel quadro di un conflitto sociale e politico in atto, sia un momento rituale, una sorta di “rito di passaggio” all’interno della vicenda personale della militanza politica. Questo doppio binario tende a rafforzarsi sempre di più in una società dominata dall’informazione e nella quale la capacità da parte del conflitto di “bucare il video” diviene spesso la conditio sine qua non dell’esistenza stessa – e della comunicabilità – del conflitto.
Nella vicenda storica dell’Italia repubblicana i due elementi, quello direttamente politico e quello simbolico-comunicativo, si intrecciano continuamente con esiti profondamente – e anche drammaticamente – diversi, fortemente legati alle modalità di risposta scelte dall’oppositore in campo, le forze dell’ordine.
Anche in questo caso nella scelta da parte dei poteri costituiti di privilegiare una risposta dialogante al conflitto di piazza, oppure l’opzione repressiva, coesistono necessità direttamente politiche, con una volontà di rappresentazione, a forte valenza simbolica, del potere, della sua cultura, della percezione che esso ha del soggetto in conflitto. Il tutto in una situazione inevitabilmente condizionata, sia dal quadro politico nazionale che dagli equilibri internazionali.
Con queste premesse possiamo cercare di leggere le vicende del periodo repubblicano nel quadro di una periodizzazione che, con un grado minimo di semplificazione, individua due grandi periodi: il primo, immediatamente successivo alla fine del conflitto mondiale, vede come antagonista principale dell’ordine costituito nelle piazze italiane il movimento operaio ufficiale con le organizzazioni sindacali e politiche della sinistra storica (Pci, Psi e Cgil); il secondo, a partire dalla fine degli anni ’60, vede una sorta di passaggio del testimone tra la sinistra storica e tutta una serie di movimenti sociali che per un periodo preciso possiamo definire come “nuova sinistra”, ma che in seguito risulta più corretto definire come forme di conflittualità antagonista sostanzialmente esterne al quadro politico nazionale (sia di governo che di opposizione).
Contrariamente a quello che molti possono pensare, il primo periodo è, se è possibile fare una classifica su un argomento talmente drammatico, quello più sanguinoso, con un’incredibile quantità di operai e contadini uccisi in scontri con le forze dell’ordine.
Gli anni del centrismo, che coprono le prime due legislature dell’Italia repubblicana (1948-1958), sono anni sanguinanti, in una sorta di tragica continuità con gli anni di guerra. Questo periodo deve però, a sua volta, essere distinto in due fasi: una prima immediatamente successiva alle elezioni del 1948 e che va fino al 1950 (una cinquantina di manifestanti uccisi dalle forze dell’ordine); una seconda nella quale il numero delle vittime scende considerevolmente (18 manifestanti uccisi[ref](6) «Negli anni cinquanta la violenza repressiva si attenuò in parte, ma almeno altri 18 lavoratori caddero tra il 1951 e il 1958» (Mario G. Rossi, Una democrazia a rischio, in Storia dell’Italia repubblicana, vol. I, La costruzione della democrazia, Einaudi, 1994, p.917).[/ref]). Le cifre riportate da numerosi storici non concordano in maniera esatta, ma in tutti i casi siamo di fronte a numeri impressionanti. Afferma Giovanni De Luna:
Le cifre della repressione contro il movimento operaio (tra il gennaio del 1948 e il settembre 1954 si contarono 75 uccisi, 5.104 feriti, 148.269 arrestati, 61.243 condanne in relazione a manifestazioni sindacali e di piazza) e il mondo della Resistenza (tra il 1945 e il 1953 furono 1.697 i partigiani arrestati, di cui 1.439 comunisti, con condanne che comportarono la distribuzione di 5.806 anni di carcere) attribuiscono una dimensione quantitativamente rilevante a questo scenario[ref](7) Giovanni De Luna, Partiti e società negli anni della ricostruzione, in Storia dell’Italia repubblicana, vol. I, cit., p. 768.[/ref].
Più analitico, ma su un arco cronologico differente, è il calcolo di Aurelio Lepre.
Nel 1947 erano caduti 14 lavoratori, 16 nel 1948 e 15 nel 1949. Nel 1950 ne furono uccisi altri diciassette. I feriti furono 3.126, i fermati 92.169. I quattro quinti dei caduti, feriti e arrestati erano comunisti[ref](8) Aurelio Lepre, Storia della prima Repubblica, il Mulino, 1993, pp. 128-129.[/ref].
Il dopoguerra, terminata nel 1947 la fase della collaborazione governativa tra le forze politiche antifasciste con l’allontanamento dal governo, sia in Italia che in Francia, dei partiti di sinistra, rappresenta il momento di massimo scontro tra la Democrazia cristiana e il Partito comunista, scontro non riducibile solamente all’aspetto direttamente politico, ma in qualche modo totale, fra due tipi antropologicamente diversi, il comunista e l’anticomunista. La rappresentazione a livello nazionale di quel confronto assoluto tra democrazie occidentali e comunismo, sintetizzato dall’espressione “guerra fredda”[ref](9) Si ricordi che la tensione internazionale non fa che aumentare negli anni immediatamente successivi alla fine del conflitto mondiale, fino a raggiungere il suo apice nel 1950 con lo scoppio della guerra di Corea.[/ref], si riflette in Italia non solo con l’idea di una contrapposizione totale, politica, sindacale, culturale, tra Democrazia cristiana e sinistre, ma nell’idea che, in una sorta di guerra strisciante e non dichiarata, ci si trovi di fronte a dei potenziali “nemici interni” con i quali non è possibile utilizzare il galateo della democrazia costituzionale: sono gli anni in cui a una Costituzione formale antifascista si sovrappone una Costituzione materiale anticomunista.
Nella difficile realtà economica del dopoguerra manifestazioni operaie e contadine guidate dai partiti di sinistra e dalla Cgil si susseguono: ondate di occupazioni delle terre incolte dei grandi latifondi meridionali vedono i braccianti reclamare la possibilità di lavorare la terra e spingere per una profonda riforma agraria che metta in discussione gli equilibri di potere consolidati da secoli; allo stesso tempo numerosi scioperi vengono proclamati contro l’ondata di licenziamenti che colpisce, nelle grandi fabbriche centro settentrionali, soprattutto gli operai sindacalizzati, mirando a recuperare il pieno controllo della mano d’opera che, nei caotici anni della guerra e della Resistenza, era parzialmente sfuggito agli imprenditori. Contro scioperi, occupazioni delle terre e manifestazioni nelle piazze è schierata la polizia, in particolar modo la “celere”, il nuovo corpo, fiore all’occhiello della riorganizzazione della polizia di stato voluta dal ministro dell’Interno Mario Scelba, che ricoprirà questa carica per tutta la prima legislatura, nei cinque governi centristi guidati da Alcide De Gasperi. Sono gli anni dello scelbismo, cioè dell’utilizzazione sistematica della polizia nel conflitto sociale e sindacale in chiave anticomunista.
Uno dei primi provvedimenti presi dal nuovo ministro dell’Interno fu proprio la riorganizzazione e, soprattutto, la vera e propria epurazione della polizia dalla presenza di ex partigiani.
Con un decreto straordinario emanato subito dopo la liberazione del Nord, circa ottomila partigiani, quasi tutti comunisti, erano stati inquadrati nella Pubblica Sicurezza […]. Perciò presentai subito un altro decreto al l° Consiglio dei ministri per liberare la polizia dal precedente decreto. Fu un avvenimento di sicuro effetto politico e psicologico. La maggioranza dei partigiani abbandonò la polizia […]. Per quelli rimasti, pensai di trasferirli nelle lontane isole. Anche questo trasferimento indusse molti partigiani che erano del Nord ad abbandonare la polizia[ref](10) Mario Scelba, Per l’Italia e per l’Europa, Cinque Lune, 1990, p. 56.[/ref].
L’idea, a più riprese affermata dallo stesso Scelba, di dover affiancare alla vittoria elettorale un “18 aprile sindacale”, trova la sua applicazione concreta nella scelta di utilizzare normalmente la polizia nei conflitti sociali e sindacali con la propensione, e il sostanziale avallo, all’utilizzo delle armi da fuoco. Di fronte al ruolo centrale assunto dalla polizia nella funzione del mantenimento dell’ordine pubblico, i carabinieri, l’altro corpo addetto a questa funzione, tendono ad assumere un ruolo meno diretto nella gestione della piazza in occasione di scioperi e manifestazioni. Si tratta di quello che Giorgio Boatti definisce l’accordo Carcaterra, dal nome dell’allora capo della polizia.
I carabinieri prendono atto dei sempre nuovi compiti, sul fronte dell’ordine pubblico, che il ministero dell’interno affida alla polizia, in particolare modo ai battaglioni mobili della pubblica sicurezza. L’arma risponde trincerandosi nelle stazioni disseminate nelle campagne, nelle cittadine di provincia, lontano dalle metropoli. Pur continuando a realizzare le operazioni nelle quali esplica il suo ruolo di “polizia militare”, i rastrellamenti, le schedature per il casellario politico centrale e per la difesa, l’arma ritorna ad essere il corpo militare radicato soprattutto nelle campagne, meno utilizzabile dei reparti della PS nei compiti di ordine pubblico[ref](11) Giorgio Boatti, L’arma. I carabinieri da De Lorenzo a Mino 1962-1977, Feltrinelli, 1978, pp. 37-38.[/ref].
Di fronte alla polizia di Scelba ci sono spesso militanti comunisti, cresciuti negli anni della dura repressione fascista e in quelli della guerra di liberazione, con una cultura politica che unisce alcuni aspetti tipici del militante rivoluzionario a una sostanziale disponibilità alla pratica della violenza, retaggio di una antica tradizione di rivolte contadine, ma anche della quotidianità degli anni di guerra e della Resistenza.
Nel corso del biennio ’43-45 con la violenza si era realizzato un nesso comportamentale più che teorico. Per la generazione che scoprì la politica nella Resistenza, le formazioni partigiane furono ambiti organizzativi privilegiati; la prospettiva insurrezionale, l’unica linea politica vissuta concretamente e attivamente […]. Il riaffiorare di comportamenti di tipo insurrezionale (dal 14 luglio del 1948 al luglio 1960) in tutte le principali scansioni della nostra storia repubblicana testimonia le loro radici profonde all’interno della tradizione della sinistra italiana anche dopo la Resistenza. A queste esperienze il Pci adattò un modello del tutto difensivo dell’uso della violenza come risorsa per la lotta politica, legandovi l’unica strategia contro l’eventualità di un colpo di stato […]. Era un modello che legittimava ampiamente la sopravvivenza di una mentalità da “doppio binario” e che tuttavia tra il 1945 e il 1948, funzionò come un formidabile elemento di stabilizzazione e di contenimento nei confronti delle spinte che venivano non solo dalla base entrata nel Pci con la “leva dell’insurrezione”, ma anche e soprattutto dalla continuità con i codici di comportamento che caratterizzavano le tradizioni di lungo periodo delle nostre classi subalterne[ref](12) G. De Luna, Partiti e società negli anni della ricostruzione, cit., pp. 761-762.[/ref].
“Morti e feriti Modena urge vostra presenza”; con questo drammatico telegramma delle 14,30 del 9 gennaio 1950, la Camera del lavoro di Bologna avvisa Roma di un nuovo eccidio di lavoratori[ref](13) Archivio storico Cgil, Atti e corrispondenza, 1950, b. 9, f. 136.[/ref]. In quella giornata di sangue sei manifestanti vengono uccisi dalle forze dell’ordine in uno degli eventi che possiamo prendere come paradigmatici della situazione ora descritta[ref](14) Solamente pochi mesi prima di Modena una lunga catena di violenze poliziesche aveva insanguinato il Meridione: il 30 ottobre del ’49, a Melissa in Calabria, la Celere aveva aperto il fuoco sugli occupanti di un fondo del marchese Berlingieri, proprietario di 2l mila ettari di terra, uccidendo due braccianti. Nelle settimane successive, a Torremaggiore (Puglia), una manifestazione di braccianti che si opponevano alla decisione di ridurre l’imponibile di mano d’opera a carico dei proprietari terrieri, veniva caricata provocando altri due morti. Pochi giorni dopo, a Montescaglioso in provincia di Matera, di nuovo era stato aperto il fuoco sui braccianti che avevano occupato un latifondo: altri due morti.[/ref].
Il 9 gennaio 1950, nel corso di una manifestazione di protesta davanti alle Fonderie Riunite di Modena, che, dopo venticinque giorni di serrata, riaprivano quel giorno con la riduzione del numero degli operai da seicentocinquanta a duecentocinquanta, la polizia sparò sulla folla e tra i dimostranti ci furono sei morti. La posizione del governo fu che i comunisti avevano cercato lo scontro o, quanto meno, avevano voluto dare una prova di forza, mobilitando tutti i loro militanti della provincia: il fatto che tra i morti non ci fossero operai delle fonderie (erano stati uccisi uno spazzino, un meccanico, un calzolaio, un bracciante e due muratori) fu portato come prova di questa affermazione (tra i feriti ci fu, però, una maggioranza di operai). Si sostenne anche che erano stati i dimostranti a sparare per primi, ma era, questa, una tesi difficilmente sostenibile: nel 1971, in un’intervista, Scelba avrebbe parlato di “incidente tecnico” e avrebbe definito “incidenti tecnici” anche gli altri scontri conclusisi con l’uccisione di qualche dimostrante (nelle sue memorie, pubblicate nel 1990, avrebbe invece parlato di “dolorosi episodi”). L’eccidio di Modena provocò una profonda impressione, anche nell’opinione pubblica moderata. I parlamentari dell’opposizione si convocarono tutti a Modena, per una riunione che fu chiamata “dieta rossa”[ref](15) Aurelio Lepre, Storia della prima Repubblica, cit., pp. 127-128.[/ref].
La dinamica dell’eccidio di Modena, nella sua efferata brutalità, replica un copione abituale per quegli anni: le forze dell’ordine sono sostanzialmente autorizzate, nel fronteggiare manifestazioni di operai o di contadini, a utilizzare, a loro discrezione, anche le armi da fuoco. Come afferma Scelba nel corso della riunione del Consiglio dei ministri successiva all’eccidio,
[…] nessuno può pretendere che gli agenti dell’ordine, incaricati di una consegna, cedano il passo e le armi ai violenti ed ai sopraffattori: con ciò si creerebbero solo le premesse per una diserzione delle Forze dello Stato di fronte a tentativi di più vasta portata[ref](16) Archivio centrale dello Stato (d’ora in poi Acs), Presidenza del Consiglio dei ministri (d’ora in poi Pcm), b. 30, Verbale della riunione del Consiglio dei ministri dell’11 gennaio 1950.[/ref].
Dopo la tragedia la versione ufficiale, come sempre, accusa i manifestanti di aver aggredito, anche con l’utilizzo di armi da fuoco, le forze dell’ordine, “costrette” a difendersi[ref](17) La “coazione a ripetere” sempre la stessa versione dura fino ai giorni nostri; basta ricordare le affermazioni di Gianfranco Fini in televisione, immediatamente dopo l’assassinio di Carlo Giuliani.[/ref]. Nelle ricostruzioni ufficiali, inoltre, in un primo tempo si cerca anche di insinuare il sospetto che le vittime siano state provocate dagli stessi manifestanti che hanno fatto fuoco sulla polizia con, indiscutibilmente, una pessima mira, considerato che l’elenco dei feriti tra le forze dell’ordine si limita a segnalare contusioni di poco conto. Per i caduti non resta altro che un formale cordoglio pubblico che cela una impressionante mancanza di sensibilità umana.
I predetti [le vittime] – che non facevano parte delle maestranze dello stabilimento in questione – erano tutti conosciuti come pericolosi e fanatici attivisti comunisti. Essi erano in testa ai dimostranti e furono notati in precedenza per la loro aggressività[…][ref](18) Acs, ministero dell’Interno (d’ora in poi Mi), Gabinetto, 1950-52, f. 11249/3, nota riservata del prefetto di Modena G.B. Laura del 16 gennaio 1950.[/ref].
Indubbiamente la tesi ufficiale sulla “legittima difesa” non è facilmente difendibile.
Ed ora: cos’è un conflitto armato, come nasce e si sviluppa un urto violento tra popolo e polizia nel corso di un movimento sindacale o politico ? Noi abbiamo una larga esperienza in proposito. Il conflitto avviene quando i dimostranti entrano in collusione diretta, in contatto fisico e materiale con le forze di polizia: una massa che si scontra contro un’altra. Ognuno di noi, quando avemmo la prima notizia dei tragici avvenimenti di Modena, si è immaginato per l’appunto un tale quadro: un confuso rimescolio, un accavallarsi disordinato di agenti di polizia e di dimostranti in colluttazione fra di loro. Orbene dalle numerosissime testimonianze raccolte […], risulta con la massima precisione che a Modena, nella giornata del 9, non vi è stata alcuna presa di contatto, alcun avvicinamento fisico, materiale fra masse di dimostranti e forze di polizia. Tutti gli episodi cruenti avvenuti si possono definire in questo schema immutato: la presa di mira a lunga distanza, sovente di 60, 70 metri, con un moschetto, da parte di un agente o di un carabiniere – ed in caso specifico pare di un ufficiale dei carabinieri – di operai che o si allontanavano nella direzione ad essi indicata dalla polizia, o attendevano, fermi, incerti sul da farsi, e il loro abbattimento a freddo, con tiro di precisione. Colpiti, quindi, in genere, alle spalle o alla nuca, i caduti. Ed è questo che mi autorizza a parlarvi di una serie di omicidi premeditati. Per usare l’espressione adoperata da una persona che non appartiene a partiti di sinistra e che ricopre qui a Modena una modesta carica: non si è trattato assolutamente di una azione di polizia diretta a sciogliere assembramenti riottosi di masse operaie e a respingerne le aggressioni ostili, ma di un tiro al piccione, di un vero tiro al piccione[ref](19) Acs, Mi, Gabinetto, 1950-52, f. 11249/3, opuscolo, suppl. al n. 13 de «l’Unità», Atto d’accusa dell’opposizione. Relazione della Commissione d’inchiesta pubblicata per voto dell’Assemblea dei deputati e dei senatori dell’Opposizione.[/ref].
Nello stesso governo alcuni ministri appaiono ben poco convinti della ricostruzione ufficiale; fra questi vi è Amintore Fanfani che, dopo aver sottolineato che “qualche industriale ha tratto conclusioni assai pericolose dal mutamento della situazione”, riferisce di un colloquio, di poco precedente l’eccidio, tra Giorgio La Pira e il prefetto di Modena, Laura, nel quale il prefetto, di fronte alle preoccupazioni sulla tensione sociale montante a Modena, aveva rassicurato La Pira affermando che “per ogni sassata che le forze pubbliche avrebbero ricevuto si sarebbe risposto con il mitra, metodo infallibile”[ref](20) Acs, Pcm, b. 30, Verbale della riunione del Consiglio dei ministri dell’11 gennaio 1950.[/ref]. La ricostruzione, da parte della Cgil, della dinamica degli assassinii dei 6 lavoratori è impressionante, rafforzando quella sensazione di “tiro al piccione” fatta propria dalla commissione d’inchiesta delle forze di opposizione e, allo stesso tempo, smentendo, in questa occasione, quel carattere “defilato” dei carabinieri nella gestione della piazza negli anni dello scelbismo, a cui si era in precedenza accennato.
I sei uccisi vennero colpiti in momenti e in luoghi diversi nel corso della giornata a testimoniare che, neanche dopo i primi caduti, un qualsiasi ordine dall’alto si preoccupò di limitare lo spargimento di sangue. Sembra quasi che l’assuefazione alla violenza e alla morte, prodotta dai lunghi anni del conflitto mondiale, permetta una gestione “feroce” dell’ordine pubblico nelle piazze, con un disprezzo classista nei confronti di operai e contadini, considerati, per la loro militanza nel Pci o nella Cgil, come dei potenziali nemici della libertà nazionale in vista di un nuovo confronto bellico immaginato come probabile e, forse, anche auspicabile.
La dimensione teatrale delle manifestazioni operaie, momento di dimostrazione di forza, ma anche rituale di aggregazione sociale, perde la sua dimensione ludica per divenire una sorta di momento di passaggio nel corso del quale l’alta percentuale di rischio fisico da un lato allontana dalle piazze tutti coloro che non si sentono convinti fino in fondo delle ragioni della protesta e dall’altro cementa, in chi sfida la repressione violenta, l’adesione ai partiti e alle organizzazioni di sinistra. La fine della guerra di Corea nel 1953 e la successiva stabilizzazione del quadro internazionale hanno un riflesso anche in Italia: da un lato i partiti di sinistra confermano la loro forza e il loro radicamento con il risultato delle elezioni politiche del 1953 e la sconfitta dell’ipotesi di riforma elettorale in senso maggioritario (la famosa “legge truffa”); dall’altro la formula politica del centrismo comincia a mostrare i suoi limiti, mentre parallelamente il patto di unità di azione fra Pci e Psi, anche sulla spinta degli avvenimenti internazionali, si avvia al suo esaurimento. Inizia una lunga fase di costituzionalizzazione della sinistra, con un immediato riflesso anche nella gestione dell’ordine pubblico nelle piazze. Da questo punto di vista le drammatiche giornate del giugno-luglio 1960, con “l’insurrezione legale” contro il governo Tambroni e l’assassinio di 9 manifestanti a Reggio Emilia, Palermo, Catania e Licata, segnano il punto di svolta definitivo.
La stessa dinamica di quelle giornate sembra segnalare questo passaggio, con un comportamento delle forze dell’ordine contraddittorio. A Genova, il 30 giugno, la polizia è sostanzialmente impotente di fronte all’organizzazione militare e anche all’aggressività dei manifestanti. Vecchi partigiani tornano attivi[ref](21) Riguardo al ruolo svolto nel giornate del ’60 a Genova dai vecchi partigiani, occorre ricordare che da un punto di vista strettamente militare proprio l’insurrezione di Genova e la sua liberazione il 23 aprile 1945, segnano una delle pagine più importanti nella storia della Resistenza italiana.[/ref], affiancati dai portuali genovesi e, a sorpresa, da una massa di giovani antifascisti che portano nello scontro di piazza contro la polizia una pratica di violenza tipica delle subculture giovanili, che poi ritroveremo in maniera ancor più massiccia nei conflitti di piazza a partire dalla fine degli anni ’60. Contro questo inatteso “fronte comune” la polizia risulta sostanzialmente inadeguata.
Alcune centinaia di attivisti confluivano alla spicciolata in questa piazza De Ferrari ove sostava un reparto di polizia contro il quale lanciavano sanguinosi insulti et sputi. Forze di polizia hanno mantenuto la più assoluta calma non raccogliendo gravissime provocazioni senonché improvvisamente veniva iniziata violenta sassaiola che colpiva per primo Commissario PS Curti Eraldo et alcune guardie. Inviato immediatamente rinforzo reparto Celere Padova questo doveva impegnarsi duramente contro numero sempre crescente dimostranti che saliti su terrazze prospicienti hanno lanciato casse, pietre, bottiglie et oggetti vari che colpivano ripetutamente guardie PS mentre altri dimostranti con mattoni e spranghe di ferro attaccavano forze polizia allontanandosi nei vicoli ove non era consigliabile inseguirli data strettezza per evitare imbottigliamento. Polizia veniva attaccata anche con spranghe ferro e bastoni, travi et alcune bottiglie di benzina che incendiavano tre camionette del Reparto Celere di Padova mentre alcune guardie di predette camionette venivano scaraventate nella vasca della pubblica fontana […][ref](22) Acs, Mi, Gabinetto, Partiti politici, b. 88, f. 195/P/96/8, «Genova Movimento Sociale Italiano. Congresso nazionale», telegramma a firma del prefetto di Genova Pianese inviato alle ore 1.35 del 1 luglio 1960.[/ref].
La “celere”, e in particolare il tristemente noto battaglione di Padova, è in difficoltà. Il ministro dell’Interno, il democristiano Giuseppe Spataro, perde il controllo della piazza e il congresso del Msi, previsto a Genova, e casus belli dell’insurrezione, viene annullato.
La gestione fallimentare della piazza sembra aprire una spirale di recriminazione tra la polizia e i carabinieri. Fra le note indirizzate al Gabinetto del ministero dell’Interno emergono, infatti, alcuni rilievi rispetto al comportamento tenuto dai carabinieri, che segnalano una certa tensione fra la polizia di stato e la “benemerita”. Si tratta della relazione del comandante del 2 reparto Celere di Padova, il tenente colonnello Gaetano Genco.
[…] Riunivo nuovamente il Reparto al posto di prima e, trovandomi vicino al vice questore, udii questi che invitava il Capitano Comandante di una Compagnia CC. ad iniziare nei vicoli un’azione con i Plotoni appiedati per affiancare l’opera del Reparto Celere. Ma il Capitano dei CC. obiettava che l’azione sarebbe stata troppo pericolosa e non si mosse.
Verso le 18.30 mentre stavamo per iniziare la seconda carica in massa vedemmo con sbalordimento prima ed indignazione poi alcuni carabinieri avvicinarsi ai dimostranti che battevano le mani li abbracciavano ponendoli in mezzo a loro e avanzando sulla Piazza come in una parata[ref](23) Ibidem.[/ref].
La nota di trasmissione della relazione al capo della polizia, firmata dal Tenente generale ispettore del corpo il 3 luglio 1960, si chiude con questa affermazione: “Il dilemma è semplice: o i carabinieri faranno il loro dovere anche sulle piazze oppure si dovrà rinunziare, nei servizi di O.P., alla loro collaborazione”.
Ma lo scontro politico in atto, anche all’interno della stessa Democrazia cristiana, tra i sostenitori dell’operazione Gronchi-Tambroni e chi spinge verso l’apertura ai socialisti e l’avvio di una fase politica nuova, offre il destro alle forze dell’ordine per un’immediata “vendetta” dello smacco genovese e una ricomposizione dei dissidi interni. L’occasione sono le manifestazioni che si susseguono contro il governo Tambroni: i carabinieri a cavallo, guidati dal maggiore D’Inzeo, caricano duramente il 6 luglio i manifestanti a Roma, a Porta San Paolo, picchiando selvaggiamente anche alcuni deputati del Pci e del Psi presenti in piazza. Il giorno successivo a Reggio Emilia la polizia torna ai vecchi metodi scelbiani, aprendo il fuoco, in momenti e luoghi diversi, contro una manifestazione di operai delle Officine Reggiane in sciopero, uccidendo 5 persone. Dilaga ancor più forte la protesta in tutta Italia con la Cgil che proclama lo sciopero generale e in Sicilia di nuovo la polizia apre il fuoco sui manifestanti provocando altri 4 morti.
Il cambiamento nel comportamento della polizia tra Genova e Reggio Emilia non sembra affatto casuale. Al riguardo la lettura di una nota riassuntiva del 3 luglio sulle giornate genovesi, inviata dal prefetto Pianese al ministro dell’Interno, suona particolarmente sinistra.
[…] Sembra opportuno riaffermare che le forze di polizia, guardie di p.s. e carabinieri, hanno fatto il loro dovere comportandosi con coraggio e decisione, frustrando le intenzioni degli estremisti, ed evitando più gravi disordini. Devo però mettere nel massimo rilievo che gli estremisti dispongono di squadre di gapisti ben addestrate alla guerriglia, particolarmente idonee per rapide azioni, composte da elementi fanatici, il che fa presumere che le apposite scuole comuniste mettono una particolare cura in tale addestramento […]. Contro la vera e propria guerriglia, messa qui in atto, per avere il sopravvento non resta che colpire a distanza i singoli gruppi e snidarli, il che ovviamente non può farsi se non facendo uso delle armi, o dando alle forze di polizia nuovi mezzi idonei allo scopo. Ciò spiega il gran numero di feriti fra le forze di polizia, colpiti in grande maggioranza da sassi lanciati da una certa distanza […][ref](24) Acs, Mi, Gabinetto, Partiti politici, b. 88, f. 195/P/96/8 Genova Movimento Sociale Italiano. Congresso nazionale, telegramma a firma del prefetto di Genova Pianese inviato alle ore 1.35 del 1 luglio 1960.[/ref].
È evidente che in occasione delle manifestazioni genovesi, la polizia ha l’ordine tassativo di non sparare, ordine che scompare nei giorni successivi. D’altronde il clima all’interno del governo Tambroni, dopo la perdita del controllo della piazza successiva al grande sciopero e agli scontri del 30 giugno a Genova, emerge chiaramente all’interno della seduta del Consiglio dei ministri soprattutto nelle parole del ministro dei Lavori Pubblici, Giuseppe Togni.
[…] questa situazione di un comunismo che assume l’iniziativa in piazza è la conseguenza del rilassamento [correzione apportata in sede di verbale rispetto al termine utilizzato da Togni, “lassismo”] che ha caratterizzato la politica italiana in questi quindici anni, tanto che se possiamo affrontare la massa comunista sulle piazze ben difficile diventa cacciarla dagli ambienti della finanza, dell’economia, dell’arte, della scienza, della cultura, del cinema, della radio, della tv, etc. che sono ormai completamente permeati di quel comunismo, al quale è stato dato il riconoscimento democratico. Ritiene, quindi, che occorre trarne ammaestramento e passare finalmente ad una azione di difesa e di epurazione. Definisce deplorevole l’iniziativa di Merzagora che, fra l’altro, pone sullo stesso piano il Governo, tutore in base alla Costituzione dell’ordine e della legalità, e le forze eversive. Ritiene che non si debba valorizzare con una risposta questa iniziativa e interpretando non solo il nostro dovere, ma il desiderio unanime della pubblica opinione conferma che il Governo in piena solidarietà deve difendere decisamente la libertà e l’ordine senza tergiversazioni o debolezze e deve far conoscere chiaramente che questa è la sua ferma intenzione[…][ref](25) Acs, Pcm, Verbali 1960, b. 62, verbale della riunione del Consiglio dei ministri dell’8 luglio 1960.[/ref].
Il fallimento definitivo del governo Tambroni apre la strada all’avvio della stagione del centrosinistra. La gestione del conflitto di piazza cambia radicalmente: da un lato iniziano ad apparire dei nuovi soggetti conflittuali non più direttamente e ferreamente controllati dai partiti e dalle organizzazioni sindacali della sinistra; dall’altro l’atteggiamento di polizia e carabinieri appare profondamente diverso, con una sorta di appeasement tra forze dell’ordine e manifestanti (eccezione sarà l’uccisione del giovane Giovanni Ardizzone durante una manifestazione di sostegno a Cuba nei giorni della crisi dei missili nell’ottobre 1962[ref] (26) Ardizzone fu travolto da una jeep della polizia, lanciata in una folle carica contro i manifestanti.[/ref]), soprattutto con una maggiore cautela rispetto all’utilizzo delle armi da fuoco. Come esempio di questo cambiamento nel comportamento si pensi alla rivolta di Piazza Statuto nel 1962 a Torino e al suo esito non drammatico, confrontandolo con la scelta, quasi sistematica, di aprire il fuoco sulle manifestazioni operaie nei primi anni ’50. La costituzionalizzazione dei partiti di sinistra e l’assunzione da parte del Psi di responsabilità dirette nei governi pone un freno a un utilizzo disinvoltamente repressivo delle forze dell’ordine.
La situazione cambia però di nuovo pochi anni dopo, con l’esplosione della stagione dei movimenti alla fine degli anni ’60 e con l’apertura di una lunga fase di conflittualità, dapprima studentesca e in seguito diffusa a larga parte della società italiana, nel corso della quale assistiamo a profondi cambiamenti nella dinamica della gestione della piazza, sia da parte dei manifestanti che delle forze dell’ordine.
Alle classiche manifestazioni si affiancano altre “azioni perturbative”, quali le occupazioni di scuole e università e i sit-in con il blocco di strade e stazioni ferroviarie; parallelamente lo scontro di piazza comincia a non essere soltanto subito dai manifestanti, ma spesso viene direttamente provocato, mentre si diffondono teorie e comportamenti che guardano alle esperienze delle guerriglie urbane e ai riots ricorrenti nel continente americano e in alcuni paesi europei, come l’Irlanda. Gli scontri di piazza assumono una rilevanza sia da un punto di vista militare, con la messa in discussione da parte dei movimenti del principio del monopolio dell’uso della forza da parte dell’ordine costituito, sia dal punto di vista della rappresentazione del conflitto stesso, divenendo in qualche modo uno spettacolo capace di trasmettere nel suo dispiegarsi il senso stesso del conflitto.
Di fronte a queste forme di comportamento le forze dell’ordine reagiscono, in un primo momento, in maniera confusa e spesso inefficiente, con un susseguirsi di azioni poco coerenti che alternano tolleranza e inefficacia a violenta reazione. Come conseguenza di questo atteggiamento ambivalente, da un lato assistiamo a una nuova impennata nel numero dei morti in scontri di piazza, con oltre 20 manifestanti uccisi tra la fine degli anni ’60 e la fine dei ’70[ref](27) Secondo Mario Galleni (Rapporto sul terrorismo, Rizzoli, 1981, pp. 289-316) i manifestanti uccisi nel corso di scontri con le forze dell’ordine nel periodo 1969-1979 sono 17 (4 passanti, 2 operai, 10 militanti di estrema sinistra, 1 di estrema destra). In questo elenco mancano, almeno, i due scioperanti uccisi a Battipaglia nell’aprile del 1969.[/ref], dall’altro si fa strada nei settori più conservatori dell’opinione pubblica la convinzione di una sostanziale incapacità/non volontà delle forze dell’ordine di reprimere i conflitti.
Certamente non è facile per polizia e carabinieri affrontare questo nuovo soggetto sociale che improvvisamente occupa le strade, con comportamenti spesso lontani da quelli tradizionali utilizzati dal movimento operaio e contadino; inoltre l’Italia è ormai una democrazia consolidata, un paese ricco, lontano dagli anni della guerra, nel quale il valore della vita in sé ha assunto una dimensione etica difficilmente comparabile con la percezione sul tema propria degli anni dell’immediato dopoguerra. Aprire il fuoco su una manifestazione, fare 5, 6, o ancora più morti non è politicamente gestibile da nessun governo e da nessuna forza di polizia. Afferma a proposito Eric J. Hobsbawn, riferendosi al maggio francese:
Quando gli studenti rifiutarono di tornare a casa, l’unica scelta rimase l’attacco armato o una pubblica e umiliante ritirata. Ma come avrebbero potuto scegliere di aprire il fuoco? Nelle società industriali stabili il massacro è una delle ultime risorse del governo, perché (a meno che si riferisca a elementi in un modo o nell’altro estranei) distrugge l’impressione di consenso popolare su cui essi poggiano. Una volta infilato il guanto di velluto sul pugno di ferro, è politicamente molto rischioso sfilarlo. Dal punto di vista politico, massacrare gli studenti, i figli della classe media rispettabile, per non nominare i ministri, è ancor peggio che uccidere operai e contadini[ref](28) Eric J. Hobsbawn, I rivoluzionari, Einaudi, 1975, p. 286.[/ref].
Non a caso i primi due morti, gli unici del fatidico 1968, saranno due braccianti uccisi a Avola, nel siracusano, durante uno sciopero per reclamare un aumento di poche lire e la fine delle gabbie salariali.
Il terrore necessario, la repressione sanguinosa da allora saranno attuati con altri strumenti, ben più subdoli e, per certi versi, più facilmente spendibili anche da un punto di vista direttamente politico. Saranno gli anni delle stragi e della strategia della tensione, inaugurata a Milano il 12 dicembre 1969, a segnalare un cambiamento di strategia in atto in alcuni settori del potere politico ed economico.
Ma riprendiamo il filo della riflessione sulle dinamiche dello scontro di piazza. Il ’68, come detto in precedenza, introduce profonde novità sia per quanto riguarda il soggetto sociale che scende nelle strade sia per il tipo di risposta e di adeguamento che produce tra le forze dell’ordine.
Le immagini, viste fino alla noia, della ormai “mitica” battaglia di Valle Giulia sono sicuramente una testimonianza precisa rispetto ad alcune delle novità che si manifestano. Gli avvenimenti sono noti e li possiamo ricordare velocemente con le parole del questore di Roma, Melfi.
[…] I dimostranti, quindi, esaurite le scorte di uova e ortaggi, sono passati a nutriti lanci di sassi e di paletti di legno della recinzione delle aiuole dei giardini limitrofi, che intanto avevano sradicato. Si sono avuti, così, le prime guardie ferite e, poiché i dimostranti da ogni direzione, avanzavano verso l’ingresso della facoltà, continuando a lanciare sassi e brandendo bastoni, la forza pubblica si è fatta avanti nel tentativo di respingere la massa, sulle cui intenzioni aggressive non vi erano, più dubbi. La violenza dei dimostranti si è, poi, evidenziata allorché, venuti a contatto con la forza pubblica, hanno letteralmente assalito con bastoni, le guardie di P.S. ed i carabinieri, mentre elementi arretrati lanciavano, con fionde, sassi, che hanno colpito numerosi elementi delle forze dell’ordine e mandato in frantumi i vetri di alcuni automezzi militari […]. Sopraggiunti altri nuclei di guardie di P.S., di carabinieri e reparti celeri, i dimostranti sono stati energicamente affrontati e dispersi, anche con l’uso di due idranti e di candelotti lacrimogeni[…][ref](29) Acs, Mi, Gabinetto, 1967-70, b. 354, f. 15584/69 Roma università , nota inviata dal capo della polizia, Di Loreto, al ministro dell’Interno il 4 marzo 1968 con la relazione del questore Melfi.[/ref].
La novità non consiste solamente nella sorpresa provocata dal fatto che, di fronte all’attacco poliziesco, gli studenti reagiscano – “non siam scappati più”, come cantava Paolo Pietrangeli -, ma nell’improvvisa coesistenza di pratiche tipiche di guerriglia urbana con comportamenti e abiti goffamente inadatti alla situazione.
I lunghi cappotti invernali dei poliziotti si fronteggiano con le scarpe con i tacchi, le giacche e le cravatte di molti studenti. Da lì in avanti gli abiti cambieranno: il look del manifestante si adegua alle nuove necessità, con la diffusione degli eskimi e delle clarks[ref](30) Alle manifestazioni si va con degli abiti particolari, consoni alla situazione; non è più il tempo del «vestito da festa» da mettersi alle grandi occasioni, come cantava Paolo Pietrangeli a proposito dell’operaio Rossini.[/ref] (o di più economiche scarpe da ginnastica) ai piedi, decisamente più utili nei casi in cui occorra rapidamente allontanarsi, inseguiti da celerini privi ormai degli ingombranti cappotti di Valle Giulia o da camionette sempre più veloci e che nel corso del tempo acquistano differenti protezioni contro pietre e biglie.
Parallelamente la gestione degli scontri di piazza, sia dal punto di vista dei manifestanti che da quello delle forze dell’ordine, si spettacolarizza in una sorta di rappresentazione teatrale del conflitto.
Barricate nelle strade, fronteggiamenti e inseguimenti producono fortunatamente, rispetto alla frequenza con la quale si ripetono, un numero ridotto di vittime; spesso, nel corso della battaglia di piazza, si arriva a un momento in cui fra i contendenti si patteggia, si cerca una sorta di via di uscita, che permetta ai manifestanti di allontanarsi e alle forze dell’ordine di difendere gli obiettivi “sensibili”, evitando di trovarsi in situazioni che possano produrre vittime con tutte le conseguenze politiche di difficile gestione del caso[ref](31) È molto difficile in quegli anni assistere a scene come quelle del luglio 2001 a Genova, con i manifestanti che, dopo aver subito le violente cariche della polizia, sono costretti a passare, con le mani bene in alto, fra i poliziotti, in una sorta di nuove “forche caudine”.[/ref].
Questa sottolineatura dell’elemento teatrale assunto dagli scontri di piazza, non intende certo cancellare la drammatica realtà che spesso caratterizza queste manifestazioni – al riguardo basta ricordare il numero delle vittime di quegli anni, persone in carne e ossa e non attori -, né tantomeno suggerire che il conflitto di piazza divenga una sorta di simulacro in cui i differenti protagonisti giocano un ruolo che serve solamente a confermare le rispettive posizioni di forza in campo. Migliaia di giovani vivono proprio in questi anni, nel corso di manifestazioni che portano a scontri di piazza, il loro rito di passaggio nel corso di una militanza politica di tipo antagonista.
Un altro dei cambiamenti riscontrabili in quegli anni, è, a partire dagli anni ’70, il recupero di una forte visibilità e di un ruolo ben preciso nella gestione dell’ordine pubblico nelle strade da parte dei carabinieri. Non è casuale che questo avvenga negli anni in cui anche la polizia di stato è scossa da quell’onda di contestazione e di spinta alla democratizzazione che si trova per altri versi a dover fronteggiare nelle strade. Gli anni ’70 sono gli anni della nascita del sindacato di polizia[ref](32) Famoso fu nel 1976 lo scandalo provocato dalla denuncia del capitano del reparto Celere di Ps, Salvatore Margherito, che aveva accusato il suo reparto di corruzione, violenza e connivenza con ambienti dell’estrema destra.[/ref], quelli delle lotte dei soldati nelle caserme, delle rivolte nelle carceri per i diritti dei detenuti, della spinta alla democratizzazione della magistratura. In questo quadro i carabinieri appaiono per il potere politico come uno dei pochi organi repressivi dello stato pienamente affidabili.
Il 1977 vede, a conferma di queste affermazioni, i carabinieri drammatici protagonisti delle giornate del marzo bolognese con l’uccisione di Francesco Lorusso, militante di Lotta continua, l’11 marzo, e la militarizzazione della città, a partire dalla sera del 12 marzo, in risposta agli scontri violentissimi che avevano sconvolto Bologna, la vetrina del buon governo comunista dell’Emilia.
Proprio nel corso del 1977, anche sulla spinta delle drammatiche vicende del terrorismo, all’interno dell’apparato repressivo dello stato osserviamo l’introduzione di alcune innovazioni tecniche che avranno dei forti riscontri nella gestione delle piazze.
La prima e la più evidente è la scomparsa dei vecchi camion militari per il trasporto delle truppe, ancora utilizzati all’inizio dell’anno, forniti di teloni facilmente incendiabili dalle molotov, e la loro sostituzione con mezzi più moderni e sicuri, i famosi “gipponi” con la torretta apribile per lanciare candelotti lacrimogeni sui manifestanti nel corso stesso di una carica. Allo stesso tempo i gas utilizzati cambiano, con effetti via via più aggressivi sui manifestanti[ref](33) «È aspro il profumo dei vostri fiori bianchi», cantava Giorgio Locascio riferendosi ai candelotti lacrimogeni, presenza abituale nelle manifestazioni di quegli anni.[/ref] – per arrivare in questa escalation chimica a quelli delle giornate del luglio 2001 di Genova. L’abbigliamento delle forze dell’ordine subisce un’uguale modificazione: maggiori protezioni per chi è più esposto – sono gli anni in cui appaiono poliziotti che sembrano dei veri e propri robot (antenati del Robocop cinematografico), con una sorta di scafandro in testa e protezioni antiproiettili su varie parti del corpo -, ma anche una capacità di scegliere il giusto abbigliamento per gli “infiltrati” delle forze dell’ordine, i poliziotti in borghese[ref](34) A titolo di esempio si pensi allo scandalo provocato dalla scoperta fatta dal giornale romano «Il Messaggero» del poliziotto in borghese, «vestito da autonomo» e che spara, nei drammatici scontri del 12 maggio 1977 che portarono all’assassinio di Giorgiana Masi.[/ref], lontanissimi parenti delle caricature che, ancora alla fine degli anni ’60, rendevano facilmente riconoscibile un poliziotto “infiltrato” in un’assemblea studentesca.
L’infuocato 1977, l’anno della rivolta dei “non garantiti”, è famoso per la durezza del confronto di piazza e per l’azione repressiva che contro il movimento fu dispiegata, sotto la regia del ministro dell’Interno, Francesco Cossiga; nonostante tutto ciò, credo che questo anno possa essere preso ugualmente come esempio concreto, riguardo a quel cambiamento, in precedenza tratteggiato, nei comportamenti delle forze dell’ordine e in particolar modo nella maggiore cautela nell’utilizzo delle armi da fuoco in piazza[ref](35) Sarà utile ricordare che la cautela di cui parlo riguardo all’utilizzazione delle armi da fuoco durante le manifestazioni, è accompagnata allo stesso tempo dall’introduzione di nuove leggi sull’ordine pubblico – la famigerata Legge Reale del 1975 – che ampliano notevolmente le possibilità di utilizzo di armi da fuoco per le forze dell’ordine in servizio.[/ref]. Il movimento esplode in una fase caratterizzata anche dall’ascesa del terrorismo di sinistra nel paese. Non è questo il luogo per un’analisi approfondita del movimento e per i distinguo necessari tra movimento e terrorismo diffuso; resta che nel corso di un anno, caratterizzato da frequenti e durissimi scontri tra manifestanti e forze dell’ordine, il bilancio finale sia drammatico con 2 manifestanti uccisi, ma, se è possibile in questi casi utilizzare termini simili, sicuramente contenuto rispetto al clima di violenza presente e alle caratteristiche per molti versi estremamente aggressive di una parte consistente del movimento[ref](36) Al riguardo occorre ricordare che nel corso di manifestazioni di piazza nel 1977 due agenti di polizia furono uccisi da colpi di arma da fuoco sparati dai manifestanti, Settimio Passamonti a Roma il 21 aprile e Antonio Custrà a Milano il 14 maggio.[/ref].
Esemplare a tal proposito credo che possa essere considerata la giornata del 12 marzo con la manifestazione nazionale del movimento tenutasi a Roma. Il clima di quel sabato pomeriggio era tragico; una giornata fredda e piovosa in un atmosfera resa ancora più plumbea dal fatto che il giorno prima, a Bologna, un militante di Lotta continua era stato ucciso da un carabiniere nel corso di alcuni scontri, non particolarmente violenti, per difendere un’assemblea di Comunione e liberazione all’università bolognese. L’assoluta sproporzione fra il fatto scatenante, la situazione di piazza, e l’assassinio di Lorusso, ucciso dal carabiniere Tramontano mentre si allontanava dal luogo degli incidenti, faceva temere un esito tragico per la manifestazione, che si svolgeva a Roma, mentre Bologna era completamente sconvolta dagli scontri e dalla militarizzazione della zona universitaria, occupata dai blindati M19 di polizia e carabinieri. Al contrario la manifestazione fu sì caratterizzata da scontri durissimi, iniziati da parte del movimento che tentò di attaccare l’obiettivo simbolicamente più eclatante, la sede nazionale della Democrazia cristiana in Piazza del Gesù, ma nonostante questo, e nonostante che da alcuni settori del movimento si facesse anche uso di armi da fuoco contro le forze dell’ordine, al termine della manifestazione, fortunatamente, non si dové fare i conti con nuove vittime.
Eravamo sul Lungotevere. Dall’altra parte del fiume c’erano, a ogni ponte, le forze dell’ordine schierate. Quelli dell’Autonomia iniziarono a sparare alla cieca. Chiunque riusciva a mettere le mani su un’arma aveva il diritto di sparare. C’erano ragazzini che non sapevano neppure dove si infilassero i proiettili. Stavano lì a discutere in mezzo alla strada con il fucile in una mano e le scatole di munizioni nell’altra. Sparavano stando in mezzo alla folla, colpire solo loro non sarebbe stato possibile.
In quegli anni le forze dell’ordine hanno spesso avuto un comportamento criminale ma in quel caso, come quando poco tempo dopo, fu ucciso l’agente Custrà a Milano, ebbero un incredibile saggezza[ref](37) Jacopo Fo e Sergio Parini, ’68. C’era una volta la rivoluzione, Feltrinelli, 1997, p. 138.[/ref].
Fu solo una coincidenza fortunata, oppure la scelta di operare una repressione serrata, ma non sanguinaria, rispetto alla quale gli assassinii di Lorusso e Giorgiana Masi furono tragici esiti non ricercati? Ricordiamo che in quegli anni il Pci, dopo il successo elettorale del 20 giugno 1976, era rientrato, per la prima volta dal 1947, nell’area di governo, sostenendo un monocolore democristiano diretto da Giulio Andreotti, con l’obiettivo dichiarato di sconfiggere crisi economica e terrorismo di sinistra, i due grandi nemici della democrazia italiana alla fine degli anni ’70. Il sostegno attivo del Pci era convinto, come l’opposizione frontale del partito verso il movimento del ’77; questo non toglie che una scelta eccessivamente militare nella repressione del movimento avrebbe potuto provocare delle enormi difficoltà al Partito Comunista nel rapporto con la sua base militante e anche con l’opinione pubblica progressista, che nei primi mesi dell’anno non aveva espresso molti consensi rispetto all’atteggiamento di totale chiusura e di avallo alla repressione nei confronti della protesta studentesca e sociale.
La sconfitta politica dei movimenti, alla fine degli anni ’70, ha aperto una lunga fase nella quale il conflitto sociale è risultato meno esposto, meno visibile, se non per brevi periodi e con rapide fiammate. Le manifestazioni di piazza, imponenti in alcuni casi (durante il movimento della pantera nel ’90, ma soprattutto in occasione della guerra in Irak dell’anno successivo) si sono normalmente svolte in un clima e in una cultura che, dopo gli anni del terrorismo, sembrava aver bandito l’idea stessa della violenza anche all’interno di un movimento di opposizione. I rari momenti di tensione sembravano più che altro una stanca ripetizione di vecchi scenari, senza alcun impatto sull’opinione pubblica. Poi, con l’esplosione del movimento dei movimenti, i mille rivoli dell’antagonismo italiano hanno ritrovato nuova linfa e contaminandosi con altre culture si sono rafforzati, “reclamando la strada” come uno dei momenti fondanti del conflitto contro il nuovo ordine imperiale. Contro questo movimento, dopo una prima fase di sorpresa, si è sviluppata una potente campagna di odio e mistificazione politica che ha camminato parallelamente a un intenso lavoro di repressione sia in chiave giudiziaria, sia nell’ambito della gestione della piazza. In questo modo di fronte all’utilizzo di nuove forme creative di disubbidienza attiva – l’uso dei propri corpi protetti da protesi come scudi, l’irruzione perturbativa in agenzie del lavoro interinale, Mac Donald o banche direttamente legate al finanziamento dell’industria bellica – abbiamo assistito a un recupero di operatività e a una scelta ferocemente repressiva delle forze dell’ordine: Napoli e poi Genova è storia di ieri. Ancora una volta la morte nelle piazze.
In quel momento si sentì uno sparo. Uno solo. Garibaldo sciolse l’abbraccio della statua e lentamente si girò su se stesso. Aprì il pugno alzato e il sasso rotolò sulla piazza. Mentre gli andava dietro gorgogliò qualcosa, ma lo udirono in pochi.
(Antonio Tabucchi, Piazza d’Italia)
Dietro le quinte
Il tema del mio saggio, poteva essere affrontato in molte maniere, privilegiando i possibili esiti di questi scontri di piazza, oppure il comportamento di uno degli attori in gioco; la mia scelta è stata quella di focalizzare l’attenzione su quei conflitti di piazza che hanno avuto l’esito più drammatico possibile, quello della morte di alcuni manifestanti. Ritenevo, infatti, che in questo modo fosse possibile cogliere quelle cesure nei comportamenti delle forze dell’ordine che devono essere ben sottolineate per non rischiare di leggere l’intera vicenda nazionale nel quadro di un’immobile continuità, rispetto a una scelta “repressiva” contro i movimenti sociali. Sottolineare i mutamenti intervenuti nel corso di oltre mezzo secolo nell’approccio delle forze dell’ordine al confronto di piazza con i movimenti di opposizione, non vuol dire certamente, per quanto mi riguarda, accettare acriticamente un’interpretazione nel solco di una lettura sostanzialmente positiva e progressiva dei processi di democratizzazione che hanno investito l’Italia nella seconda parte del XX secolo; d’altra parte, mi sembrava fondamentale sottolineare come l’opzione repressiva da parte dei poteri costituiti presenta nel corso del tempo aspetti, qualitativi e quantitativi, profondamente differenti.
Per questo saggio ho utilizzato in modo particolare due tipi di fonti: la prima è il ricorso, classico, nel mestiere di storico alle fonti archivistiche e, in particolare, a quelle prodotte dallo stato e dalle sua articolazioni; la seconda è la rete.
Sulle fonti d’archivio vorrei fare due annotazioni. La prima riguarda l’attenzione che lo storico dell’età contemporanea deve sempre porre alla possibilità di consultare fonti archivistiche prodotte e conservate al di fuori del “classico” circuito degli Archivi di stato. Nel mio caso ho utilizzato l’Archivio storico della Cgil, ma avrei potuto consultare ugualmente altre raccolte documentarie legate alle vicende dei movimenti sociali degli anni ’60 e ’70. L’invito è quindi quello a fare sempre attenzione alla possibilità di sfruttare a pieno la ricchezza e la pluralità delle fonti archivistiche esistenti per la storia dell’età contemporanea. La seconda riguarda la possibilità di consultare presso l’Archivio centrale dello stato dei documenti sul 1968, normalmente fuori dai limiti della consultabilità. Questi limiti sono stabiliti nei 40 anni dalla chiusura dell’affare, ma negli ultimi tempi, specialmente dopo l’approvazione del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici (marzo 2001), è possibile riscontrare presso l’Acs un comportamento più liberale nella possibilità di accedere alle fonti, adottando un sistema di “autorizzazione aperta”, basato su una sorta di “credito di riservatezza” che coinvolge il ricercatore. Nei casi di serie o fascicoli che oltrepassano i limiti cronologici aperti alla consultazione, il ricercatore può o accettare la tradizionale “scrematura” degli incarti oppure chiedere un’autorizzazione all’Ispettorato archivistico presso il ministero dell’Interno che si serve del parere consultivo della Commissione per le questioni inerenti la consultabilità degli atti d’archivio riservati. Dall’istituzione di questa Commissione nel 1998, sono state accolte 218 domande su 220 presentate. A fianco a questa possibilità, elemento ancor più interessante, soprattutto per i giovani ricercatori, è il fatto che il Codice di deontologia ha abolito il tasso di discriminazione esistente in precedenza verso i soggetti più deboli del mondo della ricerca, riconoscendo che l’autorizzazione concessa a uno studioso per la consultazione di serie e fascicoli ancora non accessibili, diviene generalizzata, previa scrematura, erga omnes. Per questa ragione ho potuto consultare, senza lunghe pratiche burocratiche, alcuni fascicoli sul ’68, approfittando della deroga concessa in precedenza a Vittorio Vidotto, che aveva citato i fascicoli in questione nel suo libro Roma contemporanea.
Per quanto riguarda la rete invece, le possibilità di accedere a fonti, articoli, saggi o immagini che riguardano il tema indagato è abbastanza noto, anche se non ancora sufficientemente sviluppato nel campo degli studi storici. Come per tutte le fonti resta il problema della cautela con la quale trattare le informazioni, aumentata dal fatto che sulla rete la possibilità di inserire testi e documenti apocrifi risulta particolarmente facile.
Da: Zapruder n. 1, pp. 51-71.