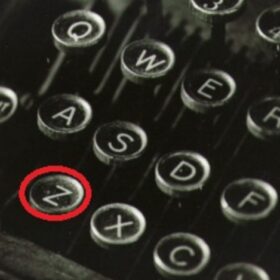Finis Europae, il numero 51 di «Zapruder» ci presenta il processo di costruzione dello spazio comunitario europeo rifuggendo tanto dalla retorica ufficiale quanto dalla narrazione puramente tecnocratica che guarda alla creazione di questo spazio senza tenerne in considerazione gli scivolamenti, le frizioni, le resistenze. Questo è quanto cerca di mettere a fuoco Martina Tazzioli nell’articolo di introduzione al numero, guardando ai confini europei come a membrane porose, costantemente attraversate e allo stesso tempo in tensione rispetto a chi cerca di attraversarle. I dispositivi nati nel corso degli ultimi anni per regolare i flussi migratori hanno finito per favorire la moltiplicazione dei luoghi della frontiera, intrecciandosi a una pluralità di pratiche informali e discrezionali che compongono oggi il mosaico di un «hotspot approach».
Geografie e genealogie di spazi migranti
di Martina Tazzioli
A cinque anni dall’inizio del cosiddetto Hotspot approach lanciato nella European migration agenda, la geografia dello spazio europeo è caratterizzata da una molteplicità di hotspot informali in molti spazi-frontiera urbani: Calais, Ventimiglia, Bardonecchia, Lesvos, Marsiglia, Evros, Eidomeni, Parigi, Lampedusa, Vucjack, Roma, solo per citare alcuni dei principali riferimenti spaziali nelle convolute traiettorie dei migranti. Si tratta di una geografia di luoghi di confinamento e controllo ma anche di lotte e pratiche collettive di solidarietà. Il termine hotspot – la cui genealogia politica va rintracciata nelle politiche anti-terrorismo dell’Unione Europea dei primi anni duemila – rimanda non solo a una serie di infrastrutture di detenzione e identificazione ma anche a una modalità di gestione, selezione e controllo di coloro che vengono razializzati e identificati come “migranti”. Secondo la Commissione europea, l’Hotspot approach «ha come funzione primaria quella di identificare, registrare e prendere le impronte rapidamente ai migranti in ingresso» via mare. L’obiettivo di effettuare la procedura di identificazione più velocemente possibile è associato a una funzione di contenimento e restrizione della libertà di movimento per come delineato dal Regolamento di Dublino. Detto altrimenti, «rapidità nella procedura di identificazione» sta in realtà per garanzia della trasmissione delle impronte digitali nel database europeo Eurodac da parte della polizia greca e italiana, sotto la supervisione e il monitoraggio dell’agenzia europea Frontex. A fare da contro altare alla velocità delle identificazioni enunciata nei testi, sta il confinamento forzato sulle isole greche di migliaia di migranti, di cui in queste settimane si torna a parlare. Le procedure di selezione e filtro iscritte nel sistema hotspot sono state attuate in Italia tra il 2015 e il 2016 attraverso meccanismi arbitrari di esclusione preventiva dai canali dell’asilo di migranti provenienti dal Nord Africa. In Grecia, invece, l’esclusione preventiva di alcuni migranti dal regime dell’asilo è stata implementata attraverso canali ufficiali, con la firma dello “Eu-Turkey deal” nel marzo 2016, che stabilisce l’eventualità di non ammettere alla procedura di asilo migranti transitati dalla Turchia.
Il confine come hotspot
In che senso dunque alcuni luoghi all’interno dello spazio europeo sono divenuti hotspots informali? Si può parlare di una standardizzazione delle pratiche di confinamento e controllo attraverso la “logica hotspot”? In realtà sono proprio l’eterogeneità e l’irregolarità delle tecnologie di governo a rendere particolarmente imprevedibile ai migranti stessi le politiche di controllo e il loro funzionamento. Non si tratta quindi di marginalizzare tale eterogeneità che, al contrario, deve essere oggetto di un’attenta analisi. Piuttosto, nel parlare di un’estensione della logica hotspot nella gestione dei confini e degli spazi-frontiera in Europa mi riferisco a una razionalità operativa, di cosa significa governare la mobilità (in modo differenziale) non tanto al confine ma attraverso di esso. Il confine come hotspot designa innanzitutto il funzionamento della frontiera e di spazi urbani trasformati in zone-confine secondo un duplice meccanismo di selezione ovvero esclusione preventiva di alcuni dai canali dell’asilo e, insieme, di contenimento attraverso misure di dispersione. Difatti, come accade quotidianamente al confine tra Italia e Francia, molti e molte tra i migranti che riescono a entrare in territorio francese vengono respinti senza avere possibilità di depositare la domanda di asilo.

Al contempo, le pratiche di contenimento della mobilità in zone-frontiera come Calais e Ventimiglia vengono spesso messe in atto dalle autorità statali secondo dinamiche centrifughe, ovvero tramite misure di dispersione dei migranti, più che non di fissazione e confinamento sul territorio. Di fatti, gestire la mobilità attraverso il confine non comporta necessariamente bloccare, respingere o detenere: molti e molte migranti sono intrappolati in una iper-mobilità forzata e destituente che li costringe a tentare lo stesso percorso ripetute volte e a intraprendere rotte convolute. In secondo luogo, sempre tenendo a mente l’idea di confine come hotspot, è importante notare che l’agenzia europea Frontex ha recentemente esteso il proprio mandato anche alle frontiere interne dell’Europa, dove avrà il compito di raccogliere dati relativi agli attraversamenti e alle persone in transito, al fine di produrre poi “risk analyses”.
E d’altro canto, osservare una parziale continuità nelle dinamiche di controllo non significa trascurare le differenze tra i singoli hotspot – formali e informali; difatti, lungo molte frontiere interne europee – come ad esempio lungo la frontiera alpina – il governo dei “movimenti indisciplinati” non avviene primariamente secondo controlli pervasivi e constanti ma, al contrario, tramite momenti di parziale non-controllo e non-registrazione che tuttavia risultano essere non meno violenti per i migranti. Guardare al confine come hotspot permette dunque di cogliere la funzione non solo di esclusione della frontiera ma anche, come sottolineato da una letteratura ormai vasta, di filtro, partizione e moltiplicatore di categorie e profili di rischio. In questo senso, si può affermare che la dimensione produttiva del confine risiede anche nei meccanismi di razializzazione tramite operazioni di profiling; processi di razializzazione che, in ultima analisi, sottendono le trasformazioni di determinati soggetti in “migranti irregolari”.
Externalisation reloaded? Ripensare la violenza dei confini attraverso Tripoli e Nyamei
Il confine come hotspot sta a indicare l’eccedere costante dei meccanismi di confinamento rispetto alle frontiere geopolitiche e nazionali e il moltiplicarsi di processi simultanei di internalizzazione ed esternalizzazione della frontiera. Al tempo stesso, è il concetto stesso di “hotspot” che deve essere riletto alla luce della ristrutturazione delle politiche di contenimento dell’Unione Europea. In particolare, se osserviamo cosa accade nel mare Mediterraneo, l’uso fatto di imbarcazioni per search and rescue come hotspots di pre-identificazione e selezione mobili risale ai tempi di Mare nostrum (ottobre 2013-dicembre 2014). Gli hotspots mobili sono poi divenuti luoghi di detenzione protratta e sequestro in alto mare con la chiusura dei porti da parte del governo italiano nel 2018.

La dichiarazione da parte dell’UE di una “crisi migratoria” in atto dal 2015 ha dato il la a una serie di vertici euro-africani, accordi bilaterali con i paesi africani, rinnovo di molti già esistenti e finanziamenti su scala continentale per il migration management come lo “Eu-Africa trust fund”. L’accordo tra UE e Turchia nel 2016 e la firma del “Memorandum of understanding” tra Italia e Libia nel 2017 hanno indubbiamente segnato tappe fondamentali nella politica europea di contenimento delle migrazioni attraverso il Mediterraneo. Con gli accordi tra guardia costiera libica e governo italiano si è aperto un ciclo di operazioni di salvataggio-cattura-sequestro che riconducono i migranti nelle prigioni libiche. Se da un lato vi è stata una moltiplicazione degli accordi tra Ue e paesi terzi in materia di controllo dei confini e confinamento preventivo dei migranti, dall’altra non si tratta esclusivamente di una questione quantitativa (maggior numero di accordi) né soltanto di un aumento esponenziale di morti nel mare Mediterraneo.
In altre parole, più che a un’esternalizzazione dei confini accelerata siamo di fronte a una ristrutturazione del modo in cui la violenza dei confini viene esercitata e orchestrata, anche con la collaborazione attiva di molti paesi terzi. Il caso Niger è cruciale per comprendere questa ristrutturazione e interrogarci su come ripensare una critica al regime dei confini oltre la denuncia di soprusi e di violazioni dei diritti umani, sempre più frequenti da parte degli stati. L’“esperimento Niger” appare particolarmente interessante e significativo se prendiamo in conto le frontiere digitali che l’Ue ambisce sviluppare attraverso una circolazione di dati biometrici e non, tra autorità nigerine, organizzazioni internazionali e Unione europea, tramite ad esempio il database Mida. Lo scambio dati è orientato a identificare e prevenire l’arrivo in Europa di soggetti “sospetti” o semplicemente indesiderati, ma anche al fine di accelerare le espulsioni dall’Europa verso i paesi di origine, secondo il nuovo regolamento Frontex. La prima “risk analysis cell” in Africa è stata implementata da Frontex in Niger, un paese che si presenta come vero terreno di sperimentazione delle future politiche migratorie euro-africane. Al tempo stesso, come parte di uno sguardo critico sulle politiche di esternalizzazione e i molteplici hotspots informali, diventa sempre più importante ripensare la violenza dei confini come inscritta in pratiche di “morte sociale” a cui attori europei e non costringono i migranti, anche senza lasciarli morire. Come ben sintetizza l’antropologo Shahram Khosravi, il governo della mobilità non si effettua soltanto attraverso restrizioni spaziali ma anche “rubando il tempo” ai migranti, sottraendo loro autonomia nella temporalità e decisioni dei movimenti.
Per una genealogia delle lotte e degli spazi di migrazione
Come anticipato in apertura di questo pezzo, la geografia degli spazi di migrazione in Europa non corrisponde solo a luoghi di contenimento – in cui dinamiche centrifughe e centripete del controllo si articolano – ma anche all’emergere di esperienze collettive di lotta e spazi di vita – «lieux de vie» come scrivevano i migranti su alcune tende nella “giungla” di Calais. Gli ultimi cinque anni sono stati segnati da un’escalation visibile nelle pratiche violente di contenimento alle frontiere esterne, nonché negli interventi, non meno violenti ma indubbiamente più difficili da mappare, di smantellamento ed evacuazione dei campi informali e di dispersione dei migranti. Ma cifra costitutiva della geografia della “crisi dei rifugiati” è stata anche la moltiplicazione di lotte collettive, di occupazioni di spazi abitativi, della circolazione di linguaggi e rivendicazioni, e di nuovi spazi politici definiti da alleanze trasversali tra “cittadini” e “migranti”.
Come bene ha sottolineato Roberto Beneduce[ref]1. Beneduce, R. (2018) Calais: mappe dell’ abbandono e della rivolta, in La Giungla di Calais, a cura di M. Agier, Ombre Corte, Verona, pp. 157-166.[/ref], la nostra immaginazione è stata guidata negli ultimi anni da una sorta di “geografia parallela”, formata da campi informali, lotte, e luoghi di violento confinamento. Tuttavia, a caratterizzare questi spazi migranti, antitesi degli hotspot del controllo, è la loro esistenza temporanea e precaria: come rendere conto dunque di spazi ed esperienze di lotta e solidarietà oltre il momento puntuale in cui queste accadono o vengono rese visibili? Come re-inscrivere la temporalità in spazi di migrazione spesso effimeri in quanto soggetti a sgomberi o misure di dispersione? In fondo, molti di questi spazi hanno funzionato per i migranti come dei “contro-hotspot” che non hanno soltanto resistito a misure repressive, di controllo e partizione, ma che hanno anche dato luogo a nuovi soggetti collettivi, per quanto temporanei e in movimento.
«We are not going back», recitavano i migranti bloccati sulle scogliere di Ventimiglia nel giugno 2015, subito dopo la sospensione di Schengen da parte della Francia: quel motto ha da quel momento circolato per tutta Europa, diventando in qualche modo la conferma di ciò che Nicholas De Genova ha definito l’«incorrigibilità» delle migrazioni[ref]2. De Genova, N. (2010) The queer politics of migration. Reflections on “illegality” and incorrigibility, «Studies in Social Justice», n. 4, vol. 2, pp. 101-126.[/ref], e di soggettività, desideri e pratiche di libertà che semplicemente sono già “qui” e non possono essere cancellate. Che cosa resta dunque degli spazi di migrazione e delle lotte per il movimento dopo che i primi sono violentemente sgomberati e le seconde neutralizzate? Per rendere conto degli “spazi infami” di migrazione, riecheggiando Foucault, e delle tracce che questi lasciano in seguito alla loro invisibilizzazione, una contro-geografia non basta. Piuttosto, genealogia e contro-geografia di questi spazi di lotta e movimento possono essere produttivamente articolate tra loro. Analizzare come determinate esperienze di migrazione si sono sedimentate nei territori e nella memoria collettiva per poi essere ri-attivate oggi fa parte di una genealogia della solidarietà che guarda non solo alla circolazione di pratiche e linguaggi nello spazio ma anche alla loro trasmissione nel corso degli anni. Cosa resta degli spazi migranti? Per non rispondere attraverso il vocabolario della “crisi” e dell’“emergenza” a questa domanda, tracciare una genealogia degli spazi di migrazione e delle lotte che li hanno attraversati diventa parte costitutiva di un sapere critico sul regime dei confini.
(In copertina: “Fuck Frontex” – Platz der unbilligen Lösungen. Ph: Rasande Tyskar)