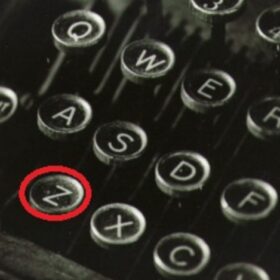Questo articolo apre una riflessione sul portato delle cosiddette primavere arabe, a dieci anni di distanza. Una lunga storia di rivolte caratterizza la Tunisia, che ha visto almeno tre grandi momenti di mobilitazione nel corso degli ultimi cinquanta anni. Francesco Tamburini li ripercorre, sullo sfondo dei più ampi cambiamenti economici e istituzionali del paese.
di Francesco Tamburini
Le rivolte che hanno interessato la Tunisia per oltre due settimane, a partire dal 15 gennaio 2021, hanno rappresentato una prova tangibile della crisi profonda in cui è avviluppato il paese maghrebino. Una crisi multidimensionale che riguarda non solo l’aspetto economico, ma anche quello securitario, istituzionale, politico e sociale. Una crisi certamente aggravata dalla pandemia, che ha collocato la Tunisia al terzo posto tra gli stati africani per numero di contagi (dopo il Sud Africa e il Marocco), ed alla quale il governo tunisino ha risposto sin da subito proclamando lo ḥalāt al-ṭawāri (حالة الطّوارئ), lo stato di emergenza regolato sulla legge 78/50 del 28 gennaio 1978, emanata durante il regime da Bourguiba e mai riformata neanche dopo il 2011. Si è spesso detto, e certamente per molti versi con ragione, che la Tunisia è stato il migliore risultato delle così dette «primavere arabe». Ad oggi però questo risultato risulta appannato, fortemente opacizzato, e si palesa la fotografia di un paese che è riuscito a creare senza dubbio una democrazia formale, ma non certamente una democrazia sostanziale, o “materiale”, cioè la capacità di chi governa di soddisfare le istanze dei propri cittadini, comprese le minoranze, all’interno di un sistema di uguaglianza politica, sociale e economica.
Tuttavia il disagio sociale che è esploso a gennaio non è sporadico, né è una semplice riedizione delle proteste nel villaggio di Sidi Bouzid, prodromi della «rivoluzione dei gelsomini» del 2011. Le rivolte popolari sono cicliche in Tunisia, quasi un fattore endemico, e sono state sempre un sintomo premonitore di grandi malesseri e presagi di futuri sconvolgimenti nel paese. Una volta acquisita l’indipendenza dalla Francia nel marzo 1956, la Tunisia cade sin da subito nell’involuzione autoritaria di Habib Bourguiba. L’ambasciatore italiano a Tunisi, Raffaele Ferretti, scriveva nel 1958 che:
dopo due anni abbondanti d’indipendenza non ha ancora una costituzione; in un paese dove il cesarismo, il messianismo, il nepotismo, il giuoco delle influenze di Palazzo (ad opera specialmente di donne) sono caratteristiche affermate di una dittatura che ha appena due anni di vita; in un paese poverissimo che per poter progredire dovrebbe condurre una rigorosa politica di lesina, e che comunque i suoi dirigenti dovrebbero dover tenere al riparo da qualsiasi scossa, sia interna che esterna.
Archivio Storico Diplomatico del Ministero Affari Esteri, Direzione Generale Affari Politici 1948–60, b. 316, Telesp. Riservato n. 1627/e, 13 settembre 1958, da Ambasciata a Tunisi a Ministero Esteri
Parole dure ma che ben sintetizzano la precarietà e la mancanza di regole democratiche di un regime che negli anni di democratico avrà solo una parvenza. Il bourguibismo, definito da alcuni una «monarchia presidenziale», si confondeva anche con il paternalismo, dato che Bouguiba riteneva che il popolo tunisino non fosse sufficientemente maturo e razionale da poter partecipare democraticamente alla vita politica. Le elezioni erano giudicate come generatrici di «germi pericolosi alla salute della nazione» (Borsali 2008), pertanto furono sempre ridotte al minimo le occasioni in cui la volontà popolare potesse esprimersi liberamente. Nel marzo del 1975, Bourguiba sarà eletto presidente a vita in virtù dei «servigi resi alla Nazione nella lotta contro il colonialismo e per avere fatto della Tunisia un paese unito, indipendente e moderno».
Alla mancanza di democrazia si associava una disastrosa situazione economica. Sovrappopolato, privo di risorse economiche e tecnici specializzati, ostacolato nei suoi rapporti internazionali da una politica estera a tratti confusionaria e indecisa se restare in campo occidentale oppure panarabo, l’ex protettorato francese non ebbe sin da subito vita facile. La «tunisificazione» di molte professioni, così come la nazionalizzazione delle terre agricole (legge 64-5 del 12 maggio 1964), portò alla lenta ma graduale emorragia delle comunità straniere, in primis quella italiana, rendendo ancora più asfittico il panorama economico. Le nazionalizzazioni andarono di pari passo col «socialismo cooperativo», che avrebbe dovuto far prevalere gli interessi collettivi su quelli privati, ma fu applicato in modo rigido e burocratico e fu un disastro.
Nel 1969 Bourguiba pose termine all’esperimento socialista e collettivista tunisino, rivelatosi economicamente fallimentare (il governo ammise di avere accumulato debiti per 13 milioni di dinari). Nel 1970 il primo ministro Hedi Nouira passò dal «socialismo cooperativo» a una forma di liberismo fondato sull’apertura della Tunisia verso l’esterno, incoraggiando gli investimenti stranieri per trasformare il paese in una «Singapore maghrebina».
La fine dell’esperimento socialista però non fu indolore: prima condusse all’ottenimento di maggior potere da parte di Bourguiba, che nel 1974 assunse la presidenza a vita; in secondo luogo, a livello popolare, si creò un vuoto ideologico che fu colmato dai sindacati dell’Union général tunisien du travail (Ugtt, unione generale tunisina del lavoro) e, in seguito, dal radicalismo islamico. Nel 1977 il dissenso pervase sia strati più bassi della popolazione, che la stessa classe media, portando a un numero impressionante di scioperi (ben 452), che provocarono la perdita di oltre un milione di ore lavorative. Vi fu una frattura tra i sindacati dell’Ugtt e il partito unico di Habib Bourguiba, il Parti socialiste destourien, alla quale il governo del primo ministro Nouira non seppe rispondere efficacemente, reagendo con dure repressioni che colpirono ogni forma di dissenso, soprattutto all’interno del mondo operaio. I sindacati reclamarono decisamente un’autonomia dal governo e dal potere politico, proclamando, il 26 gennaio 1978, il primo sciopero generale nella storia della Tunisia indipendente. Migliaia di disoccupati e lavoratori scesero per le strade di Tunisi, scontrandosi con l’esercito e forze dell’ordine chiamate per sedare i tumulti. Fu il così detto «giovedì nero» (jeudi noir), che provocò più di cinquanta morti e un centinaio di feriti tra i dimostranti. Bourguiba proclamò lo stato d’emergenza, in base all’art. 46 della costituzione del 1959, accompagnato dalla legge 78/50, che prevedeva pesantissime limitazioni ai diritti civili e politici dei cittadini tunisini. Nouira lasciò l’incarico di primo ministro nel 1980, rimosso per non avere saputo gestire la crisi economico-sociale.

Fu chiaro che i disordini sociali non potessero essere prevenuti solo con le misure economiche, dal momento che si era in presenza di una crisi di partecipazione popolare alla politica, pertanto avvennero timide aperture sul principio del multipartitismo. Questo, tuttavia, rimase un concetto vuoto, poiché non fu definito lo status dell’opposizione, né il problema della sua legalizzazione. Ecco che fu varato alcuni mesi dopo quello che potrebbe essere definito un «multipartitismo di stato». Un multipartitismo controllato dall’alto. In campo economico, il nuovo ministro Mohammed Mzali previde l’aumento dei salari, riesaminati in funzione del costo della vita, come anche al blocco dei prezzi dei beni di prima necessità, misura che costò all’erario pubblico 46 milioni di dinari. Sfortunatamente gli investimenti intrapresi nelle zone depresse nel sud del paese e lungo le frontiere con l’Algeria non ebbero il tempo di dare i loro frutti, anche perché a metà anni ottanta le modeste rendite petrolifere, che sino ad allora avevano permesso di mantenere contenuti i prezzi dei beni di prima necessità, iniziarono a non essere più sufficienti a causa dell’abbassamento sul mercato internazionale del prezzo del greggio.
Sollecitata dal Fondo monetario internazionale a stabilizzare l’economia, la Tunisia, dopo avere tentato invano di aumentare la pressione fiscale sulle classi privilegiate, fu costretta a aumentare il prezzo della farina e dei cereali del 70%, innescando tra il 1983 e il gennaio 1984 i così detti «moti del pane» o del «couscous». Essi furono molto diversi da quelli del 1978, che erano essenzialmente un conflitto tra governo e Ugtt.
Nel dicembre del 1983 la crisi non riguardò il sistema politico istituzionale, ma fu una vera e propria rivolta popolare di livello nazionale, che interessò prima il sud del paese per poi estendersi a tutto il paese e infine a Tunisi. Furono presi di mira dalla popolazione i luoghi proibiti di un benessere inaccessibile quali banche, supermercati, negozi di lusso, agenzie di viaggio e autovetture simboli dell’Occidente. Il governo fu preso di sorpresa dalla vastità e virulenza delle proteste e fu necessario chiamare nuovamente l’esercito, che questa volta fece uso anche dei blindati. Il 6 gennaio, dopo che la calma era stata ristabilita, al prezzo di oltre centocinquanta morti, Bourguiba annunciò alla televisione l’annullamento del provvedimento di rincaro del pane, dimostrando ancora una volta di essere, nonostante l’età e la malattia, la vera e unica guida della Tunisia. Era la seconda volta che il contratto non scritto tra il «combattente supremo» e il popolo, ovvero pane in cambio della «monarchia presidenziale», veniva infranto e poco dopo ricostituito, ma non per sempre.
Anche il successore di Bourguiba, Zine El-Abidine Ben Ali, subentrato al potere della Tunisia con il «colpo di stato medico» del novembre del 1987, si trovò a fronteggiare la grande rivolta popolare avvenuta nel gennaio 2008 nel bacino minerario di Gafsa, la quale sconvolse per sei mesi tutto l’omonimo governatorato nel centro della Tunisia. Le contestazioni, le più vaste e rilevanti dai moti del pane del 1984, scoppiarono dopo che un concorso pubblico per operai, tecnici e impiegati presso la Compagnie des phosphates de Gafsa, unico motore economico della regione, era stato platealmente inficiato da corruzione, clientelismi e nepotismo, favorendo l’assunzione di amici e parenti sulla base di affinità tribali e politiche.
Scioperi e manifestazioni pacifiche videro la partecipazione di centinaia di studenti universitari e liceali, disoccupati e tutta la popolazione marginalizzata sia socialmente che economicamente. I partiti tradizionali, anche quelli dell’opposizione non legalizzata, rimasero fondamentalmente estranei alle proteste, preoccupati soprattutto dalle elezioni presidenziali del 2009. Solo alcune sezioni locali dell’Ugtt si mobilizzarono, così come la Lega tunisina dei diritti dell’uomo e l’Associazione tunisina delle donne democratiche. I desiderata delle proteste si riassumevano nello slogan «determinazione e dignità», che implicava la fine dei concorsi truccati e l’assunzione dei disoccupati con un diploma, oltre all’accesso ai servizi pubblici essenziali per le classi più disagiate (acqua corrente, elettricità e sanità). Fu una rivolta che interessò la parte più diseredata della Tunisia: quella interna e lontana dalle più ricche zone costiere, quella sprovvista di infrastrutture, quella delle “zone d’ombra” che la politica di Ben Ali non aveva eliminato. Una politica definita khubzisme (da khubz – خبز–, pane in arabo), ossia tentare di ingraziarsi i ceti inferiori con i generi di prima necessità per ottenerne l’assenso politico, allo scopo di evitare sollevazioni popolari come quelle verificatesi nel 1983-84.
La rivolta mise in luce la crisi socioeconomica del regime e anticipò le proteste che lo avrebbero abbattuto. Il modello di protesta popolare di Gafsa fu molto simile a quello del 2010-2011 per diversi motivi: fu una protesta spontanea e imprevista, proveniente dal basso; i partiti dell’opposizione (legalizzati e non) non seppero sfruttarla a proprio vantaggio; i tunisini all’estero fecero da cassa di risonanza alle proteste; il regime mostrò il suo vero volto con arresti arbitrari e l’uso sistematico della tortura, quindi la macchina repressiva entrò in stallo e non reagì in modo appropriato, perché, dal 1984, non era più abituata a reprimere rivolte popolari che non avessero a che fare con le opposizioni classiche (associazioni dei diritti umani o sindacati studenteschi); l’esercito non intervenne direttamente, ma si limitò a circondare i centri urbani interessati; gli eventi furono filmati con telefoni cellulari da improvvisati reporter e postati su Youtube e Dailymotion. La «rivolta del popolo delle miniere», la cui onda lunga di proteste per gli arresti giunse sino al novembre 2010, rimase nella memoria collettiva del paese e fu il segnale che si era inceppato definitivamente il meccanismo del «patto di sicurezza». Stava avvenendo un surriscaldamento del sistema che sarebbe esploso meno di due anni dopo.

Gafsa non fu però un precedente isolato: vanno infatti letti nella stessa chiave interpretativa i moti dell’estate del 2010 a Ben Guerdane, cittadina di frontiera con la Libia, la cui economia si basava sull’importazione, spesso illegale, di merci dalla ǧamāhīriyya libica. Quando il 15 agosto la dogana di Ras el-Jedir fu chiusa, la popolazione, che si vide privata anche di quel contrabbando con cui sopravviveva, insorse contro le autorità, che furono costrette a riaprire in fretta la frontiera. Si era verificata la prima vittoria popolare contro il regime.
Se nel gennaio del 2008 e nell’estate del 2010 le proteste erano rimaste circoscritte e presto “tamponate” in qualche modo dal governo, così non fu nel dicembre 2010. La drammatica morte di Bouazizi fu un evento talmente traumatico ed ebbe un impatto psicologico così duro da rendere inaccettabile lo status quo e da provocare un senso di ribellione che si espanse a livello nazionale. Dal governatorato di Sidi Bouzid, tra l’altro confinante con quello di Gafsa, si espansero a macchia d’olio e in breve tempo in tutto il paese sommosse e manifestazioni spontanee con cui solidarizzarono i comitati locali dell’Ugtt (i cui vertici, invece, propensi a un’opera di mediazione, furono totalmente scavalcati). Anche le organizzazioni politiche tradizionali furono prese di sorpresa dalla protesta e la subirono passivamente. Esse, infatti, non riuscirono a creare una leadership che potesse guidarla assumendo una posizione egemonica, poiché il movimento era essenzialmente privo di ideologia e acefalo. Senza contare che la maggior parte dell’opposizione legale era troppo compromessa con il regime per poter vantare una rappresentanza morale della contestazione. Tra le opposizioni illegali anche il movimento islamista, le cui capacità organizzative erano state pressoché annientata dalle precedenti repressioni governative, rimase in secondo piano, anche perché la rivolta non ebbe mai una dimensione religiosa. Essa si concentrò sulla rivendicazione della karāma (الكرام) cioè dignità. La dignità esprimeva un concetto legato all’individualità, piuttosto che alla collettività, alla comunità dei credenti (‘Umma), oppure alla murūa (مروة), in arabo non solo virilità, ma anche l’onore del gruppo, della tribù. Basti pensare infine al suicidio di Mohammed Bouazizi, atto supremo individuale, ma anche un atto che nella concezione islamica, come in tutte le religioni rivelate, è proibito (harām).
A dieci anni di distanza la karāma non è stata ancora conquistata dal popolo tunisino. Oggi si è resa ancora più evidente la mancanza di una vera transizione democratica, soprattutto di una democrazia sostanziale, che sia in piena coerenza con gli ideali del 2011 e le aspirazioni popolari. Dalla fuga di Ben Ali si sono succeduti ben dodici governi, che non hanno mai saputo distribuire giustizia sociale e dignità alla popolazione. Un sentimento di frustrazione crescente e di speranze tradite da parte di istituzioni che la gente comune sente sempre più lontane. Quelle stesse istituzioni che non hanno ancora potuto, o meglio voluto, rendere noti ufficialmente i nomi dei martiri del 2011, gli šuḥada, probabilmente perché si desidera giungere ad una “riconciliazione” con le vecchie élite del passato regime. Molti diritti espressi nella costituzione del 2014 (come il diritto al lavoro) non hanno ricevuto una adeguata applicazione tramite decreti applicativi, e il clientelismo e fasād (فساد), la corruzione, sono tornata a insinuarsi in tutti i settori della vita pubblica. Alcuni sindacati di polizia sono diventati uno strumento di pressione politica, che giungono a influenzare le decisioni dei tribunali contro gli abusi della polizia. Dal 2014 non si è stati in grado di eleggere la Corte costituzionale, con grave nocumento per tutto il sistema politico, impedendo a nuove norme di penetrare l’ordine giuridico.
A tutto ciò si aggiunge la disastrosa situazione economica. Oltre l’83% dei giovani ha una istruzione superiore e non riesce a trovare un impiego, l’inflazione raggiunge il 6% e i governi tunisini sono stati costretti ad indebitarsi per fare fronte all’emergenza accumulando un debito pubblico superiore al 70% (prima della rivoluzione era del 35%). Si è accresciuto inoltre il già esistente divario tra le aree costiere e quelle interne. Tuttavia anche le regioni sulla costa, una volta più prospere grazie al turismo, oggi ristagnano a causa della mancanza del turismo occidentale. La crisi non risparmia nessun ceto sociale o gruppo di età, ma è un fatto che la forza d’urto delle proteste sono ormai i ragazzi giovanissimi che non vedono più nessuna speranza: su 1.600 arrestati dalla polizia, il 30% era minorenne. La differenza con le rivolte dei decenni scorsi non è solo la trasversalità di questi moti, ma è anche la loro diversa prospettiva. Negli anni ’70 e ’80, come anche nella Rivoluzione del Gelsomino del 2011, c’era un nemico da abbattere o contrastare: il niẓām (نظام), il sistema, il regime. Oggi che questo non c’è più, è subentrata una rabbia che è fondamentalmente una rottura dei giovani con lo stato, contro ogni forma di autorità, contro i partiti politici, le élite economiche e i media dominanti. Sebbene questi ultimi facciano passare le rivolte come forme di banditismo e illegalità, privilegiando la solita logica securitaria, i moti costituiscono una sorta di corpo sociale più o meno inconsapevole, che ha raggiunto una immunità di gregge dopo anni di lotta contro il sistema. È un “noi politico” acefalo che non ha rappresentanti e che mette in discussione i teorici traguardi raggiunti dalla “rivoluzione” del 2011.
Immagine di copertina: Yacine Mahjoub, Tunisi, 19 gennaio 2021. Proteste a Tunisi, sul cartello si legge «non emarginarmi, non zittirmi, non reprimermi con la forza, non farmi diventare povero, uccidimi o lasciami vivere».
Bibliografia orientativa
Bayat A.
(2017) Revolution without Revolutionaries: Making Sense of the Arab Spring, Stanford, CA, Stanford University Press.
Borsali, N.
(2008) Bourguiba à l’épreuve de la démocratie (1956-1963), Sfax, Samed.
Geisser V., Allal A., (dir.)
(2018) Tunisie. Une démocratisation au-dessus de tout soupçon?, Paris, CNRS.
Krichen, A.
(2018) La promesse du printemps: Tunisie, 2011-2017, Paris, Éditions de La Sorbonne.
Masri, M.
(2017) Tunisia: an Arab Anomaly, New York, Columbia University Press.
Mhenni, L.
(2011) Tunisian girl. La rivoluzione vista da un blog. Roma, Alegre.