Di morti sul lavoro si parla sempre poco, di morti sul lavoro analizzando l’intreccio fra formazione e lavoro in chiave storica ancora meno.
Insieme a Sislav (Società italiana di storia del lavoro) abbiamo chiesto a Pietro Causarano una analisi dei meccanismi che hanno portato alla morte di Lorenzo Parelli e Giuseppe Lenoci, che ripubblichiamo qua.
In dialogo anche con i temi affrontati da Pierino torna a scuola, il numero 57 di «Zapruder», dedicato alle trasformazioni del sistema educativo secondario negli anni ottanta.
Buona lettura!
Morire lavorando, morire studiando
di Pietro Causarano
Gli ultimi tragici eventi internazionali, legati all’invasione russa dell’Ucraina e alla guerra, hanno inevitabilmente soverchiato se non azzerato l’attenzione rispetto ad altre questioni che hanno agitato e diviso l’opinione pubblica negli ultimi anni e mesi, dalla pandemia al mutamento climatico, dalle crisi industriali alle morti sul lavoro. Anche la breve fiammata di sdegno legata agli incidenti mortali che hanno coinvolto, in modalità e situazioni diverse, due giovanissimi studenti durante l’attività di stage è rapidamente scomparsa dietro vicende ben più drammatiche sul piano collettivo. Com’è noto, si tratta del caso di Lorenzo Parelli, 18 anni da poco compiuti, tirocinante in un’azienda operante nell’ambito della carpenteria metallica in provincia di Udine, rimasto schiacciato sotto una putrella, e quello di Giuseppe Lenoci, 16 anni, morto in un incidente stradale ad Ancona con il furgone aziendale durante un viaggio di trasferimento lontano dalla ditta di termoidraulica presso cui era affidato. Le dinamiche – a quel che si sa fino ad oggi – sono diverse ma comunque legate ambedue ad un deficit di tutoraggio e controllo preventivo rispetto ai rischi cui potevano incorrere in quanto stagisti, al di là della retorica un po’ ipocrita sulla fatalità che talvolta è emersa su piattaforme social e media.
Eppure l’attenzione che ha segnato per poche settimane queste due morti, fra gennaio e febbraio 2022, ha evidenziato un’emozione molto intensa nell’opinione pubblica e fatto esplodere il disagio studentesco in una varietà di proteste di piazza, alcune inopinatamente represse con un uso della forza apparso ai più sproporzionato e in larga parte ingiustificato, incapace comunque di tener conto della complessità di richieste che venivano dagli studenti e che riguardavano non solo la scuola in sé e il problema dell’alternanza scuola-lavoro, ma anche il rapporto di essi con la costruzione del loro futuro (https://www.valigiablu.it/alternanza-scuola-lavoro-studenti-protesta/). Analoga emozione, con una forte reazione sindacale, si era avuta qualche mese prima di fronte alla ripresa intensa dello stillicidio di gravi infortuni e morti sul lavoro, dopo la loro relativa diminuzione durante la pandemia e la pausa delle chiusure e rallentamenti nella produzione di beni e nell’erogazione di servizi degli ultimi due anni. La rubrica “Al presente” della SisLav se n’è già occupata nell’estate 2021 attraverso la penna coinvolgente di Simona Baldanzi, scrittrice, ricercatrice e delegata sindacale, nel suo intervento intitolato polemicamente Riaprire, ripartire, recuperare e crepare (https://www.storialavoro.it/al-presente-30/).
Il Centro di formazione professionale dell’Istituto salesiano Bearzi di Udine, quello frequentato da Lorenzo Parelli, addestra i ragazzi al lavoro – nell’ambito dell’adempimento dell’obbligo d’istruzione e poi formativo – per il settore elettrico, meccanico e motoristico, con un percorso misto di formazione generale e tecnico-professionale affiancato da stage aziendali di diverso e crescente spessore orario. Analogamente anche Giuseppe Lenoci era iscritto ad un Centro di formazione professionale, denominato degli Artigianelli di Fermo, erede di una Scuola di arti e mestieri fondata da un religioso nell’immediato secondo dopoguerra e poi riconosciuta dallo Stato nei primi anni ’60. In questo caso siamo davanti a percorsi legati alla meccanica di precisione, alla trasformazione alimentare e agro-alimentare, al calzaturiero, organizzati su bienni di qualifica. In realtà dunque non saremmo propriamente di fronte a casi di alternanza scuola-lavoro, ex L. 107/2015 (detta della “buona scuola”), ma neppure pienamente davanti a quel profilo dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (Pcto) , che poi l’hanno sostituita, ex L. 145/2018, art. 1, commi 784-5, e successive linee guida con Dm 774/2019. Si tratta più tradizionalmente di formazione professionale extra-scolastica, seppure fortemente strutturata anche dal punto di vista dell’offerta formativa per la cultura di base e generale e ampiamente collegata con la realtà economica locale e il tessuto imprenditoriale del territorio, com’è tipico delle aree della Terza Italia.
Lo scambio fra la formazione in aula e in laboratorio-officina, da una parte, e la formazione in tirocinio (gratuito) e in azienda, dall’altra, è costitutivo di queste istituzioni che nella relazione a breve-medio termine con il mercato del lavoro operaio qualificato trovano storicamente la loro giustificazione e capacità attrattiva fra i ragazzi. Bisogna inoltre tener conto che le aree di distretto industriale, tradizionalmente, hanno tassi di scolarizzazione prolungata più bassi e insieme tassi di precoce inserimento lavorativo più elevati rispetto ad altre aree urbane più grandi o di tipo metropolitano. In effetti, per molti aspetti, questi istituti di formazione professionale hanno sempre più integrato o sostituito l’apprendistato, in relazione all’evoluzione complessa delle tecnologie delle macchine e al mutamento delle pratiche lavorative e al declinare delle specificità rispetto alla standardizzazione tecnicizzata dei processi produttivi, sia di quelli più tradizionali e rigidi sia di quelli più flessibili e integrati.
Il fatto quindi che questi ragazzi fossero impegnati in azienda, all’interno di percorsi formativi professionalizzanti, non è in sé una cosa strana né la loro situazione può essere sovrapposta ai percorsi scolastici di Pcto che investono la scuola secondaria, sia nell’ordine liceale sia a maggior ragione negli indirizzi degli istituti tecnici e professionali. La cosa strana e terribile è che siano morti in un’esperienza di lavoro, indiretta e – va di nuovo ricordato – non retribuita, come sono gli stage e i tirocini. Parelli pare sostasse guardando gli altri lavorare al montaggio in un’area a rischio e esposta e che nessuno lo avesse avvertito del potenziale pericolo rappresentato dai carichi sospesi, né il tutor aziendale cui era stato affidato all’inizio e che si era ammalato proprio quel giorno né il sostituto provvisorio. Lenoci è rimasto coinvolto nell’incidente automobilistico e nello schianto del furgone della ditta, molto lontano dal luogo di lavoro cui era stato mandato dal suo istituto e sembra forse in sostituzione di un dipendente strutturato: si tratta di elementi tutti oggetto di attenzione nelle indagini giudiziarie in corso.
Per riflettere su queste vicende così simboliche nella loro drammaticità, forse è bene però separare due questioni ben distinte: la prima riguarda la prevenzione, la salute e la sicurezza sul lavoro e per tutti i lavoratori, da cui deriva anche la problematicità dell’evento fatale e accidentale che ha coinvolto questi giovani studenti i quali non erano apprendisti, contrattualmente tutelati e remunerati, e perciò in quanto tirocinanti non lavoravano propriamente in addestramento (e avrebbero quindi dovuto godere semmai di un surplus di attenzione e precauzione nella prevenzione e nell’accompagnamento); la seconda riguarda la relazione fra formazione e lavoro di fronte all’esperienza scolastica e di studio e ai tirocini, un tema antico e a lungo dibattuto nella storia del sistema formativo italiano, almeno fin dalla prima industrializzazione in età giolittiana. Nella breve discussione pubblica di quelle settimane di inizio 2022, subito spenta dall’aggressione russa all’Ucraina, i due livelli si sono spesso sovrapposti creando confusione e mischiando sulla scorta della reazione emotiva dimensioni incommensurabili come la mortalità sul lavoro con le idee che ognuno di noi ha su cosa debba essere l’educazione e la formazione a scuola e tramite la scuola e il suo rapporto con il mondo del lavoro (per una rassegna cfr. la pagina della Fondazione Feltrinelli del 5 febbraio 2022, intitolata Quale scuola, quale lavoro, nella rubrica web “La nostra città futura. Zitti e buoni”: qua).
Sgombriamo il campo da ambiguità e equivoci che sono talvolta risuonati nello sdegno immediato: la morte sul luogo di lavoro dei due studenti tirocinanti non è diversa da quella che colpisce qualsiasi lavoratore o apprendista né è più grave, pur toccando forse maggiormente la sensibilità collettiva. E questa sorpresa emotiva dell’opinione pubblica e della politica rappresenta però anche un dato indicativo di un certo fatalismo diffuso: un incidente può succedere se si fanno certi lavori, ma non deve capitare ad uno studente in stage. Un fatalismo che se è storicamente presente anche in molte identità professionali di lavoratori manuali del passato (soprattutto maschi), viceversa non è ammissibile oggi, in particolare in chi ha responsabilità politiche e di controllo amministrativo, nella gestione d’impresa ed anche nella comunicazione/informazione. Gli incidenti, gli infortuni, le esposizioni nocive con conseguenti malattie professionali, non sono fatalità, sono espressione di una vera e propria patologia organizzativa dei modelli e dei sistemi produttivi. Ci mostrano ancora oggi – seppure in maniera meno drammaticamente significativa di un passato non troppo lontano – la gerarchia di priorità di senso e di valore attribuita ai fattori della produzione. Luigi Campiglio, in un vecchio studio del 1976 (Lavoro salariato e nocività. Infortuni e malattie del lavoro nello sviluppo economico italiano, Bari, De Donato), segnalava la perfetta fungibilità nell’andamento degli investimenti industriali italiani dagli anni ’20 agli ’70 del ‘900 rispetto alla curva degli infortuni in fabbrica. Certamente oggi molto è cambiato nel modo di lavorare, di utilizzare le macchine, nella sensibilità di datori di lavoro e di lavoratori nel campo della prevenzione. Eppure il problema presenta ancora dimensioni quantitative tragiche (https://italiaindati.com/morti-ed-infortuni-sul-lavoro-in-italia/). Ma non ha senso distinguere in termini di gravità una morte accidentale sul lavoro da un’altra: sul luogo di lavoro, a prescindere dal perché uno si trova lì e dal ruolo che ricopre, non si dovrebbe mai correre il rischio di morire e in ogni caso si dovrebbe dimostrare che effettivamente sia stato fatto di tutto perché il pericolo alla base del rischio e dell’esposizione non si concretizzasse, sia dal punto di vista del datore di lavoro sia dal punto di vista della consapevolezza acquisita dal lavoratore, dall’apprendista o dallo stagista.
E qui entra in gioco la formazione, che fin dall’introduzione nel nostro ordinamento della normativa europea sulla prevenzione dei rischi da lavoro a metà degli anni ’90 ha rappresentato uno degli assi centrali su cui si sarebbe dovuta costruire la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro. Molto ci sarebbe da dire sui limiti e il carattere spesso formalistico di questa formazione obbligatoria dei lavoratori, soprattutto quella di base, ma indubbiamente è stata un’innovazione fondamentale che ha contribuito a sostenere un mutamento di atteggiamento e di mentalità che si era già avviato negli anni ’70 in materia ambientale e dei rischi da lavoro. Ho avuto modo di mostrare in alcuni miei scritti come le sperimentazioni nei corsi seminariali delle 150 ore all’università e alla scuola secondaria superiore – dedicati negli anni ’70 e ’80 all’organizzazione del lavoro e alla prevenzione, anche in chiave di genere, e frequentati prima di tutto da delegati e sindacalisti ma anche da semplici lavoratori e lavoratrici – abbiano rappresentato un elemento decisivo nella diffusione di nuovi orientamenti in materia di sicurezza e ambiente. Nuovi modelli che poi fioriranno talvolta anche nell’innovazione delle culture aziendali e d’impresa nel momento in cui si realizzerà la “grande trasformazione” organizzativa sul piano qualitativo e tecnologico di fine ‘900.
Già allora, nel decennio delle grandi conquiste del movimento dei lavoratori, i settori sindacali e associativi più attenti alle tematiche educative in relazione al lavoro chiedevano che una cultura della sicurezza fosse introdotta nei percorsi di studio e addestramento professionalizzanti, sia a scuola sia nella formazione professionale, perché comunque c’era una massa di studenti, quella prevalente, che studiava per andare a lavorare e che con questi rischi da lavoro si sarebbe dovuta confrontare successivamente senza essere davvero attrezzata. Solo nel 2017 però – di fronte all’obbligatorietà dell’alternanza scuola-lavoro – viene emanato il Dm n. 195 che, all’art. 5, norma la formazione in materia di sicurezza e prevenzione degli studenti che entrano in questo meccanismo, pur mantenendo margini di ambiguità e di indeterminatezza procedurale nell’attribuzione della responsabilità riguardo ai rischi specifici fra scuola e azienda. Il tutto è stato poi ripreso successivamente nelle linee guida per il Pcto (Dm 774/2019, punto 6), che però non ha risolto il concreto pericolo di una lettura formale di quest’obbligo formativo.
Veniamo ora quindi al versante della scuola in rapporto al lavoro, tema affrontato a più livelli nel dibattito pubblico e in forma assai più larga e da tempo, almeno a partire dalla riforma della “buona scuola”, e i cui paradigmi sono stati modificati e innovati da quella stessa “grande trasformazione” del lavoro di fine secolo prima richiamata. Un nuovo sussulto c’è stato in relazione a questi incidenti. Molti opinionisti e intellettuali di diversa sensibilità e estrazione (ad es. Luciano Canfora, Luigi Ricolfi, Paola Mastrocola fra gli altri: https://www.repubblica.it/cultura/2022/01/29/news) hanno posto la questione nei termini per cui la scuola dovrebbe fornire una cultura generale e una formazione trasversale, non direttamente condizionata alla professionalizzazione. L’evento tragico di Lorenzo Parelli e Giuseppe Lenoci così sarebbe stato soltanto l’esito patologico di una condizione che lo studente – a quella età – non dovrebbe affrontare e non gli dovrebbe neppure essere proposta, figlia di una abbassamento strutturale della qualità scolastica nell’esercizio della sua funzione. La dimostrazione cioè che in età scolare non si dovrebbe stare sul luogo di lavoro ma solo in contesti di studio. In altri termini che il lavoro non è studio e lo studio non è lavoro. O meglio, per riprendere una vecchia rappresentazione polemica di questa dicotomia proposta da Antonio Santoni Rugiu, c’è chi impara studiando e chi impara facendo, una dicotomia espressione evidente di quel “démembrent de l’éducation” che Pierre Naville evidenziava già subito dopo l’ultima guerra.
Questione legittima, ma se impostata in questi termini risulta un po’ datata oggi e per molti versi ingenua perché dimentica che nel corso del ‘900 l’addestramento al lavoro, sempre più tecnicizzato e standardizzato, è stato gradualmente esternalizzato rispetto ai contesti aziendali. Questo approccio sconta un’idea di scuola secondaria superiore curvata sulla dimensione liceale di cultura generale (sub specie soprattutto classica) che oblitera l’esistenza dell’istruzione tecnica e professionale, così strutturata da almeno un secolo. Soprattutto dimentica la “doppia gamba” data dalla relazione che si è venuta instaurando – a partire dalla riforma scolastica Moratti del 2003 – fra la formazione professionale regionale e l’istruzione professionale di Stato (ambedue rilasciano qualifiche), accanto a quella generalista liceale o tecnica, dopo l’elevamento dell’obbligo di istruzione a 16 anni e l’introduzione dell’obbligo formativo a 18 anni. Lo stage e il tirocinio lavorativo non sono una novità introdotta dalle riforme degli ultimi decenni nel contesto dell’istruzione tecnica e professionale e della formazione professionale, esistevano già, magari molto meno formalizzati e strutturati. Ma è un po’ ipocrita accorgersene ora che queste pratiche di scambio scuola-impresa investono gli indirizzi liceali di cultura generale, dove indubbiamente spesso esiste un problema di coerenza fra percorsi di studio ed esperienza di confronto con il lavoro. Davvero si ritiene che introdurre forme serie di interazione con l’esperienza lavorativa in età scolare (fuori del regime dell’obbligo di istruzione e solo in relazione con l’obbligo formativo), forme per altro esistenti da tempo e in modalità diversa per i percorsi professionalizzanti, sia squalificante per lo studio e insieme solo prodromico alla costruzione di un lavoratore debole culturalmente e di un cittadino potenzialmente sottomesso? In fondo mettere in gioco esperienza scolastica e esperienza lavorativa significa fare interagire le diverse componenti culturali del lavoro: le conoscenze (i saperi), le abilità (il saper fare), le capacità (le competenze). L’importante sarebbe non mortificare nessuna di esse che, pur combinandosi in modo diverso a seconda dei percorsi di studio, sempre sono (o dovrebbero essere) tutte presenti.
Si dice: se tutti studiassero e basta in una scuola di qualità, da ragazzi, la differenziazione, definita una volta “classista”, che opera selettivamente attraverso le scelte dei percorsi di studio, o generalisti o professionalizzanti, sparirebbe o quantomeno si attenuerebbe, oltre a far evitare i rischi fisici dei tirocini lavorativi. Indubbiamente la costruzione sociale della moderna idea di infanzia e adolescenza, della sua autonomia e soggettività in termini di diritti, deriva dai mutamenti di mentalità e di cultura diffusa nella società che hanno allontanato i ragazzi dal lavoro precoce. Un ruolo fondamentale è così stato giocato dalla dinamica istituzionale della scolarizzazione di massa, a partire dal periodo fra le due guerre mondiali e soprattutto nel secondo dopoguerra dei “Trenta gloriosi” con il Welfare e il benessere, almeno nel nostro mondo collocato nell’emisfero nord del pianeta che ha visto un gigantesco investimento delle famiglie sullo studio dei figli. E l’elevamento dell’età dell’obbligo – con la costruzione di percorsi comuni trasversali di istruzione generale di base sempre più lunghi – ha costituito l’asse di questo mutamento permettendo uno sviluppo più ampio della personalità individuale.
Ma questo è avvenuto anche grazie al fatto che le opportunità di crescita personale legate allo studio sempre più prolungato, oltre l’alfabetizzazione, erano collegate a due fattori strettamente interrelati: da una parte, ad una scelta nella specializzazione degli indirizzi scolastici sempre più tardiva rispetto al passato (in forma differenziata, nei diversi sistemi del secondo dopoguerra, a 14 o poi 16 anni, ma nel mondo tedesco è rimasta ancora precoce, a 11-13 anni a seconda dei Länder); dall’altra, alla crescita esponenziale dell’offerta di percorsi professionalizzanti posteriori all’istruzione di base che, seppur mostrassero e mantenessero le vischiose logiche riproduttive della stratificazione sociale, avevano anche un effetto cumulativo intergenerazionale che piano piano spostava le forze in gioco, apriva a dinamiche di scelta delle opportunità formative molto più articolate e complesse nel mentre il nostro paese con l’Europa viveva una grande e rapidissima trasformazione industriale (si pensi solo, in prospettiva storica, alla questione di genere).
Fino alla fine del secolo appena concluso ancora i due terzi dei ragazzi che in Italia andavano alla scuola superiore sceglievano indirizzi tecnici o professionali e solo recentemente indirizzi generalisti e professionalizzanti hanno teso a pareggiarsi. Lo stesso accade ancora oggi soprattutto nel mondo di lingua tedesca e mitteleuropeo, ma anche in parte nell’Europa del nord e nei paesi dell’est ex sovietico, dove la prevalenza dei percorsi professionalizzanti su quelli generalisti è rimasta. Si è parlato anche per l’Italia di “sistema duale”, dopo la riforma Renzi del 2015, richiamando il modello tedesco. Ma c’è una differenza fondamentale: nel sistema tedesco l’alternanza scuola-lavoro prevede un investimento consistente sulla formazione, sul piano finanziario e organizzativo, da parte degli attori economici e gli studenti transitano nell’esperienza lavorativa come apprendisti retribuiti. In Italia il vantaggio competitivo è determinato dal fatto che per il sistema d’impresa stagisti e tirocinanti sono gratuiti, a differenza degli apprendisti, e non ci sono vincoli rispetto al rapporto di lavoro in essere e futuro perché non c’è rapporto di lavoro. Forse di questo si dovrebbe allora cominciare a parlare, stando sulla realtà delle cose.
(l’articolo è stato pubblicato originariamente qua)








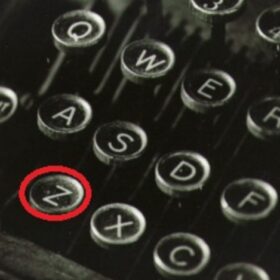





1 commento
Pingback
17 Maggio 2022 at 9:59