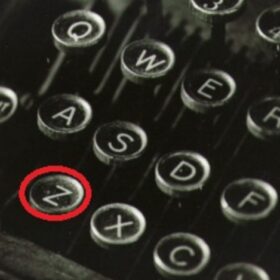Da pochi giorni è partita la distribuzione di “Che gelida manina. Malattia e cura”, il 60° numero di «Zapruder», che esce a tre anni dall’insorgere del virus che ha scatenato la pandemia da covid-19 e guarda a malattia e salute come aspetti costanti e problematici della storia umana (qua indice).
Per accompagnarne l’uscita abbiamo chiesto a Simone Pieranni, che nel numero 53 ha già scritto della gestione epidemica in Cina (Dragocrazia. Potere e controllo nella Cina contemporanea), di fare per noi – e per voi – un aggiornamento sulle ripercussioni che sta avendo sul presente la gestione politica dell’emergenza sanitaria.
Covid f(r)ee. Potere ed epidemia in Cina
di Simone Pieranni
C’è ancora una domanda che si fa sempre strada quando si parla di Cina oggi, a metà del 2023 con il mondo indaffarato da ormai un anno con la guerra in Ucraina e tutto quanto ne è derivato, e la pandemia che sembra ormai un ricordo lontano. Almeno per noi. La dirigenza del Partito comunista cinese in realtà è ancora al lavoro su quell’aspetto. Perché c’è da rispondere a quella domanda, ovvero per quale motivo a un certo punto Pechino ha deciso di cambiare completamente la propria politica sul covid, passando da uno dei lockdown più duri visti sul pianeta a un “liberi tutti” totale? Ci sarebbero alcune risposte che potrebbero essere deduzioni da tutta una serie di aspetti che si sono realizzati prima di questa clamorosa inversione a U: ci sono state delle proteste, intanto; proteste veementi, forti, dirette contro la leadership e nelle città più grandi e più importanti del paese. Proteste che hanno fatto il giro del mondo e – dettaglio decisamente più importante – che hanno visto tutti in Cina, perché a novembre del 2022 la censura nulla ha potuto contro il profluvio di video e immagine che ha letteralmente spaccato i social cinesi.
Ci sono state delle lamentele da parte della comunità business, sia quella internazionale, sia quella cinese. Parecchi europei e americani nel periodo della politica “covid zero” hanno fatto le valigie, si sono messi in attesa di trovare il volo che sarebbe partito, un’attesa che a volte è durata anche mesi; immaginatevi questi laowai, “stranieri per i cinesi”, ad alto reddito abituati a una vita più che decente, che per settimane hanno le valigie pronte e aspettano una chiamata dall’ambasciata o dalla loro azienda che gli dica: «ok puoi tornare». Ma anche tanti imprenditori cinesi, e lavoratori cinesi, hanno sofferto la rigida chiusura. E così ci hanno pensato i boss, come Terry Gou, fondatore di Foxconn, azienda nota per i suicidi di molti lavoratori una dozzina di anni fa nonché principale partner di Apple in Cina per l’assemblaggio degli Iphone. Si dice che Terry Gou abbia scritto a Xi Jinping chiedendo un cambiamento: il rischio era grosso, l’economia stava scivolando a picco, la disoccupazione giovanile era al 19%, meglio tornare indietro. Di sicuro ci sono state anche le indicazioni del mondo scientifico cinese, specie quello che da mesi durante “covid zero” sosteneva che fosse possibile riaprire e convivere con il virus. In questo caso gli esperti dicono che le analisi sulle varianti siano state fondamentali: una volta che ci si è assicurati una letalità minore del virus e delle sue varianti, la Cina avrebbe potuto fare esattamente come noi: una valutazione cinica, certo, che in sostanza sosteneva che probabilmente sarebbero morti un po’ di anziani e di persone fragili, ma che la stragrande maggioranza della popolazione se avesse contratto il virus si sarebbe ammalata solo in modo leggero.
Tutte queste spiegazioni sono corrette, e probabilmente questi sono i fattori che hanno portato al drastico cambio di linea della dirigenza cinese. Il Partito comunista aveva presentato la battaglia contro il covid come una specie di guerra, prima che la guerra vera in Ucraina scoppiasse davvero. Xi Jinping sembrava volersi appuntare al petto delle stellette immaginarie in mancanza di una guerra vera da mettere nel curriculum, in modo da essere davvero come Mao Zedong, non solo nella sua centralità politica e nell’accumulo di cariche. E ancora di recente il Pcc sta cercando di offrire una sua narrazione tentando quanto a volte le macchine propagandistiche sono chiamate a fare in modo fantasioso e spericolata, ovvero sta cercando di dire che tra la “Zero covid” e la riapertura totale in realtà c’è una specie di continuità, non si sarebbe tratta di una “inversione a U”. E lo sta facendo “alla cinese”, cioè cancellando dati.
Il 12 aprile il «Wall Street Journal» ha scritto che:
Due mesi dopo aver dichiarato la vittoria sul covid-19, Pechino sta cercando di modellare il modo in cui la pandemia viene ricordata in Cina, nascondendo i dati sul suo impatto e censurando le persone che contraddicono la linea del governo secondo cui la sua gestione del virus è stata un trionfo. Una delle domande più grandi – quante persone sono morte – rimane senza risposta, con il governo che limita l’accesso ai documenti che potrebbero aiutare a far luce sulla questione. Rapporti ufficiali sul numero di corpi cremati, normalmente rilasciati trimestralmente, scomparsi o non sono stati aggiornati nei tempi previsti in più di 30 province, città o distretti. Una città ha cancellato documenti risalenti all’inizio del 2020.
Wenxin Fan and Shen Lu, China Seeks to Write Its Own History of Battle With Covid-19
A questo punto dobbiamo riavvolgere il nastro. Perché prima del cambio di politica sono successe tante cose che probabilmente hanno finito per influire sulle scelte successive in tema di pandemia. Intanto a ottobre c’è stato il ventesimo congresso del Partito comunista. Per capire quanto Xi Jinping abbia cambiato il Partito, e quindi la politica in Cina, bisogna raccontare com’era e che cos’era il Partito prima dell’ascesa di Xi. Il Partito comunista cinese non è monolitico come spesso viene descritto. Al suo interno ci sono gruppi di potere contrapposti, divisi in correnti e fazioni, proprio come nei partiti occidentali. Fino al 2012, cioè prima della nomina di Xi Jinping, si contavano tre fazioni principali. Una è quella dei “populisti”, composta dai funzionari che arrivano dalla Lega della gioventù comunista, una delle organizzazioni giovanili del Partito. È formata da funzionari che fanno la gavetta, spesso partendo da posizioni amministrative nelle zone più povere del paese, e che hanno sviluppato un’attenzione particolare per le diseguaglianze e le questioni sociali. Il periodo d’oro dei populisti è stato il decennio dal 2002 al 2012, durante i due mandati da presidente di Hu Jintao, cresciuto proprio nella lega della gioventù comunista. Poi c’è un’altra fazione, quella dei cosiddetti “principini”, cioè i discendenti dell’aristocrazia rossa: figli o parenti dei vecchi compagni di Mao Zedong, i rivoluzionari che nel 1949 portarono al potere il partito comunista. Sono definiti elitisti e ci tengono a far pesare la loro origine nobile. Per loro, quelli della Lega della gioventù sono dei compagni di serie b, dei “bottegai”.
Molti principini, da metà degli anni ‘90 fino al 2012, anziché militare all’interno del partito hanno preferito diventare imprenditori. Hanno sfruttato quelli che in Cina si chiamano guanxi, i ganci, il network relazionale. In pratica, grazie ai loro rapporti privilegiati coi vertici della politica, le loro aziende potevano muoversi in anticipo su tutte le altre. Tanti di questi nobili prestati al business hanno fatto i miliardi e sono diventati estremamente influenti negli ambienti economici cinesi. Ma alcuni di loro sono rimasti nel Partito, ad aspettare il momento buono. Uno di loro, ad esempio, è Xi Jinping.
La terza fazione è formata dai funzionari locali della capitale economica cinese, Shanghai. È la cosiddetta “cricca di Shanghai”, fondata e guidata da sempre da Jiang Zemin, numero uno del Partito dal 1989 fino al 2002. Oggi Jiang Zemin ha 96 anni e anche lui pare che non stia proprio bene, infatti non era presente all’ultimo congresso del partito. Nonostante questo, e pur non ricoprendo più nessun incarico ufficiale, pare che continui ancora ad avere un certo peso nella politica nazionale. Quindi, tre fazioni: populisti, principini e cricca di Shanghai, tutte sotto l’ombrello del Partito.
Quando, ad esempio, nel 2002 Hu Jintao viene eletto presidente si realizza quella che il Partito ha sempre definito come la “democrazia intra partitica” o anche “guida collegiale”. Cioè: la fazione vincitrice, che esprime il presidente, è quella al comando, ma esercita il potere, diremmo noi, nel rispetto delle minoranze interne. Le nomine all’interno degli organi politici rispecchiano in qualche modo i rapporti di forza interni al Partito, ma tutte le posizioni sono rappresentate. E nelle stanze del potere ci si confronta, si discute anche animatamente, finché non si trova un compromesso accettabile per tutti. Quella diventa “la linea ufficiale del Partito”, e una volta uscita non si discute più. Oggi non è più così: il principino Xi Jinping ha vinto la sua guerra personale contro i “bottegai”.
La vera svolta storica di Xi Jinping sono state le nomine del Comitato permanente, il gruppo dei sette uomini più potenti della Cina. E questo ci racconta un dato importante riguardo la pandemia: oggi è complicato capire chi abbia influenza Xi, considerando che Xi, personalmente o grazie a strettissimi alleati, controlla tutto il Partito. Nel nuovo comitato permanente uscito dal Congresso non esiste più il confronto interno, non esistono più fazioni diverse che devono trovare un accordo. Oggi quei sette uomini, i sette che governeranno la Cina almeno per i prossimi cinque anni, sono tutti uomini di Xi. Il numero uno è ovviamente Xi Jinping, che si è auto riconfermato per un terzo mandato. Il numero due, che sarà anche il nuovo premier, è Li Qiang. Li Qiang è il segretario del Partito di Shanghai ma non è uno della “cricca di Shanghai”, è un fedelissimo di Xi Jinping: i due hanno lavorato fianco a fianco per anni e prima di finire a Shanghai, Xi lo aveva mandato a coprire una delle posizioni più ambite dai dirigenti cinesi: segretario del partito del Jiangsu, una delle regioni più ricche della Repubblica popolare. Il numero tre è Zhao Leji, per lui è il secondo mandato nel Comitato. Anche Zhao è un alleato di Xi ed è stato a capo del dipartimento di disciplina del Partito, l’organo che in sostanza veglia sull’integrità dei membri del Partito comunista cinese. Confermato un secondo mandato anche per Wang Huning, il numero 4: Wang è l’ideologo e alleato “politico” di Xi.
L’inventore del “sogno cinese”, lo slogan che racchiude la visione della Cina del futuro di Xi Jinping. Il numero cinque è una sorpresa: Cai Qi, segretario del Partito di Pechino, altro alleato di lungo corso di Xi Jinping. È lui ad avere gestito a Pechino il megaprogetto urbano di Xiong’an, quella che nelle intenzioni di Xi deve essere l’esempio delle “smart city” con caratteristiche cinesi.
Ding Xuexiang, il numero sei, è di fatto il segretario personale di Xi Jinping. Prima dell’epidemia da covid19, in ogni uscita pubblica in Cina o all’estero, lo si vedeva sempre a fianco del presidente. Probabilmente, è il funzionario con cui Xi Jinping ha trascorso più tempo negli ultimi anni. Anche il numero sette è una sorpresa: Li Xi. Probabile capo della commissione della campagna anticorruzione. È una posizione di grande potere, perché la campagna anticorruzione è stato lo strumento con cui Xi Jinping, negli anni, si è liberato di tutti i potenziali avversari interni nel Partito. Ed è una campagna che, con ogni probabilità, continuerà finché Xi Jinping sarà al potere. Quindi questo è il nuovo comitato permanente del Partito comunista cinese: il capo, Xi Jinping, più sei fedelissimi, di provata fiducia, totalmente devoti al presidente.
Finisce il congresso, iniziano le proteste. Partiamo da un dato: le proteste in Cina ci sono sempre state. I cinesi non sono quel popolo suddito e obbediente che spesso viene descritto nei media occidentali. Le autorità li chiamano “incidenti di massa”: possono essere proteste pacifiche, cortei, ma anche contestazioni violente. Fino a qualche anno fa sapevamo che di episodi simili ne capitavano migliaia all’anno. Poi, all’inizio degli anni duemila, Pechino ha deciso di chiudere i rubinetti: il numero ufficiale delle proteste in Cina, da allora, è segreto di stato.
Le proteste del novembre 2022 però sono una novità: gli incidenti di massa erano sempre manifestazioni di dissenso locale, spesso contro funzionari locali, fabbriche inquinanti, aziende al centro di scandali alimentari, bersagli con un nome e un cognome, o una ragione sociale almeno. E a Pechino, al cuore del Partito comunista, veniva chiesto di intervenire per sistemare le cose. Chiudendo le aziende o cacciando i funzionari corrotti. Oggi, invece, chi manifesta in Cina lo fa proprio contro il governo centrale, perché la politica “Zero covid” è un marchio di fabbrica del presidente Xi Jinping. Il punto di partenza sono i lockdown, improvvisi e durissimi, e l’inefficienza del sistema cinese a organizzare e gestire le persone che rimangono chiuse in casa o nei covid center. Non a caso la prima manifestazione di grande dissenso c’è stata mesi fa a Shanghai, quando alle persone chiuse in casa in pratica non arrivava cibo.
Un altro elemento di novità è sicuramente l’estensione geografica delle proteste. Dopo le prime manifestazioni contro le restrizioni per l’epidemia ci eravamo chiesti se fossimo di fronte a eventi locali, limitati o meno. Sabato e domenica hanno dimostrato che queste proteste raggiungono varie città, da Urumqi in Xinjiang, fino a Shanghai, Chengdu, fino a Pechino. La frustrazione è ormai generale.
Un’altra peculiarità delle proteste – almeno dai video che abbiamo visto – è stata la partecipazione dei giovani. Le università hanno manifestato e per le strade erano soprattutto i giovani a scandire gli slogan. E qui abbiamo un dato che può indicarci una strada futura, per quanto riguarda la dialettica tra popolo e autorità: sono loro, i giovani, che possono mettere in difficoltà il Partito comunista cinese, specie nelle grandi città. Perché non condividono le esigenze di ordine e stabilità del Partito, e stanno vivendo sulla propria pelle il rallentamento economico e l’incertezza che sta dominando le vite dei cinesi. Il 19% dei giovani è attualmente disoccupato e il rallentamento dell’economia mette in crisi quel patto sociale che il Partito ha stipulato con la popolazione cinese: vi potete arricchire ma rinunciate ad alcuni diritti.
I giovani vedono fermarsi l’ascensore sociale che aveva contraddistinto gli anni di crescita cinese impetuosa, e adesso cominciano a reclamare diritti: libertà di parola, di espressione, di associazione. E sono loro che presumibilmente potrebbero portare la dirigenza del Partito ad allentare alcune scelte già effettuate, ad esempio una chiusura culturale piuttosto evidente nei confronti del mondo esterno, al di là della riapertura “fisica” della Cina ai visitatori stranieri, così come la volontà da parte di Xi Jinping di riportare il Partito a controllare ogni anfratto della vita sociale, anche educativa, della popolazione.
Per qualche approfondimento in più…
- Protests erupt across China in unprecedented challenge to Xi Jinping’s zero-Covid policy | CNN
- Clashes in Shanghai as protests over zero-Covid policy grip China | The Guardian
- China’s lockdown protests spread to campuses and cities abroad | Reuters
- China’s ‘zero-COVID’ U-turn leads to loss of faith in leadership | Aljazeera
- Why has China’s zero-Covid U-turn sparked so much public resentment? | South China Morning Post