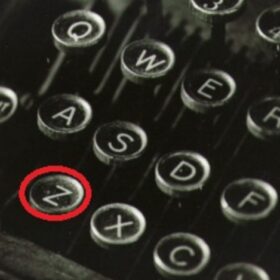Pubblicata dall’editore Editpress, nasce una nuova collana dedicata alla storia orale; uno spazio dove riflettere sul passato attraverso il racconto e la memoria, che metta al centro la relazione tra chi intervista e chi viene intervistato, la dimensione del linguaggio e quella della restituzione del lavoro critico di chi fa storia orale. La collana mira ad aprirsi a una pluralità di forme narrative e di strumenti, raccogliendo contributi di studi interdisciplinari e internazionali. Con Gabriella Gribaudi, direttrice della collana, e Alessandro Casellato, membro del suo comitato scientifico e presidente dell’Associazione italiana di storia orale (Aiso), abbiamo costruito un dialogo, su cosa sia, come e dove si situi oggi la storia orale.
intervista di Giulia Sbaffi
Giulia Sbaffi: La prima curiosità che ho è capire da dove nasce questa idea. Cioè perché una collana di storia orale, quali sono le forze e le energie che la animano?
Gabriella Gribaudi: l’iniziativa è partita dall’Aiso.
Alessandro Casellato: In verità è partita dall’editore, Editpress. È un piccolo editore fiorentino con alcune collane di tipo universitario, soprattutto di antropologia. L’editore aveva individuato un vuoto nel mercato dei libri: non c’è in Italia una collana dedicata alla storia orale. Ha affidato a un suo collaboratore, Giovanni Pietrangeli, una sorta di mandato esplorativo, e lui si è messo in contatto con me. All’Aiso è sembrata subito una cosa che potesse essere nelle nostre corde. Era uno degli obiettivi che ci eravamo dati: consolidare da un punto di vista editoriale e quindi anche scientifico la presenza della storia orale, ma da soli – come Aiso – non ne avremmo mai avuto le forze. Ecco quindi che sapere che c’era qualcuno che è venuto a bussare alle nostre porte ci ha molto rassicurato e abbiamo pensato a come dare forma a questo progetto: abbiamo proposto il nome di Gabriella Gribaudi per dirigerla, e dato disponibilità come singoli studiosi e come associazione a sostenerla.
Giulia Sbaffi: Qual è il rapporto tra editoria e storia orale?
Gabriella Gribaudi: Non è un rapporto facile, come non è un rapporto facile quello tra la storia orale e l’accademia. Tuttavia ci sono molti libri, quelli di Portelli, i miei e tanti altri che sono stati accolti molto bene. Sono libri di storia orale o comunque incrociano la storia orale con altre fonti e hanno avuto una buona accoglienza, sono stati accettati e apprezzati dagli editori e dagli studiosi. Nonostante ciò si ripropongono spesso intorno alla storia orale discussioni e critiche emerse molti anni fa. Chi, come me, fa storia orale dagli anni 70, le conosce a memoria[ref]1. Tra gli altri: Gribaudi G., Guerra totale. Tra bombe alleate e violenze naziste. Napoli e il fronte meridionale 1940-1944, Bollati Boringhieri, Torino 2005; Portelli S., Storie Orali. Racconto, immaginazione, dialogo, Donzelli, Roma 2017.[/ref].
Giulia Sbaffi: Quali sono le resistenze maggiori? La presunta scarsa affidabilità della fonte, può essere ancora questo il cuore del dibattito che crea ostacoli all’interno dell’accademia o ci sono altre ragioni?
Gabriella Gribaudi: Non tanto forse la scarsa attendibilità, poiché su questo c’è stato un dibattito approfondito. Tutte le fonti sono in un certo senso inattendibili, le dobbiamo criticare tutte. Molte delle critiche che vengono fatte riguardano la limitatezza dei soggetti e dei contesti analizzati. In epoca di global history questo appare limitante. Ma la fonte orale rende possibile studiare la soggettività come nessun’altra fonte, tenendo conto ovviamente di tutti quegli aspetti su cui riflettiamo da anni: chi è il narratore, come racconta, che cosa ricorda, che cosa omette…
Alessandro Casellato: È una critica molto simile a quella che è stata fatta, anche recentemente, per esempio nell’History Manifesto, alla microstoria, imputandole la difficoltà ad affrontare il tema della generalizzazione. Questo è, effettivamente, un problema teorico su cui i microstorici hanno riflettuto molto. In più, credo che ci sia una questione legata alla scarsa legittimizzazione, rispetto al passato, della storia sociale rispetto alla storia politica. Le fonti orali sono calate nella storia sociale, se non altro perché si tende a cercare, a sollecitare, i racconti di coloro che appartengono a gruppi sociali minoritari o subalterni, che hanno minore accesso alle leve del potere e anche della parola pubblica.
E poi credo ci sia anche un’altra questione che in Italia sia più difficile da affrontare che in altri contesti, e cioè la storia recente. La storia contemporanea italiana fatica a trattare gli ultimi decenni, quelli su cui la storia orale può dire di più e anzi può fare da apripista. La storiografia italiana è molto molto reticente ad affrontare tematiche prossime al presente, cioè gli ultimi quarant’anni, e credo che anche queste ragioni indeboliscono un po’ la storia orale agli occhi della storiografia accademica. Tuttavia, bisogna riconoscere il fatto che rispetto agli anni ’70-80 c’è stato un enorme balzo in avanti nel riconoscimento della storia orale; non vorrei fare una lettura vittimistica: possiamo giocare con molta più autorevolezza oggi rispetto ad una generazione fa. Ci sono state delle ricerche, ad esempio quelle che ha richiamato adesso Gabriella Gribaudi, su questioni centrali nel dibattito storiografico, condotte attraverso la metodologia della storia orale. Ci sono state delle opere straordinarie in Italia e che poi sono state tradotte in molti altri paesi. Solo i ciechi non possono riconoscerlo.
Gabriella Gribaudi: Questo è vero. Nel mio percorso, non posso lamentarmi di aver avuto difficoltà o di non essere stata capita. Ogni tanto forse riemergono questi problemi e forse quello che dice Alessandro è giusto: c’è una difficoltà, anche oggi, a identificare e capire che cosa sia la storia sociale. È passata come la storia dei gruppi sociali, la storia delle classi medie o della borghesia. La storia sociale che noi abbiamo praticato, era una storia calata nei contesti, sul modello della microstoria; si analizzavano gli aspetti soggettivi, si usavano delle metodologie, degli approcci di tipo antropologico, era una storia sociale diversa. Quella fase, quel momento, è passato e tutto considerato quelle riflessioni non hanno incontrato il resto della storiografia.
Oggi c’è un problema diverso. La critica giusta a una storia contemporanea tutta incentrata sulla vicenda nazionale ha portato i giovani studiosi a cercare percorsi di ricerca di global history, individuare delle tematiche che abbiano un contesto e un riferimento internazionali. E in tali percorsi è difficile trovare l’uso delle fonti orali, che invece potrebbero essere proficuamente applicate anche a una ricerca di storia globale. L’immigrazione e l’emigrazione sono ad esempio temi di global history. Penso, e ho sempre seguito questa strada, che si possano studiare eventi e contesti incrociando la storia orale con altre metodologie, altre dimensioni, altre fonti e che l’incrocio tra le fonti sia uno degli aspetti interessanti della ricerca storica.
Giulia Sbaffi: Una cosa che mi ha molto colpita leggendo l’introduzione e l’indice di questo volume, è che mi sembra che si ricostruisca una genealogia di quello che è stato il percorso della storia orale: da dove è partita, il rapporto con la memoria, la Shoah, gli anni 90 e poi la seconda parte invece mette a tema quelle che sono le questioni portanti della storia orale: i conflitti, primo tra tutti quello tra chi intervista e viene intervistato. Mi piacerebbe che voi parlaste adesso proprio di questo, del rapporto tra chi intervista e chi viene intervistato, che cassetta degli attrezzi ha chi intervista, come si muove tenendo anche conto di quel complesso di vissuto che chi intervista porta comunque con sé nel dialogo.
Gabriella Gribaudi: Il volume che introduce la collana propone gli atti di un convegno su testimoni/testimonianze tenutosi a Napoli nel marzo del 2018. A partire dal famoso libro di Annette Wieviorka si era sviluppato un profondo dibattito sul testimone. Come valutare la validità e la sincerità del testimone? Allora abbiamo scelto di approfondire il tema a partire da casi concreti analizzando i vari contesti in cui la testimonianza e il testimone venivano utilizzati, riflettendo sulle metodologie e sui differenti riferimenti disciplinari e scientifici. L’idea era anche di discutere del dialogo intervistatore/intervistato e dei problemi che potevano sorgere in questo rapporto. Il testo inizia dalla tematica in cui il ruolo della fonte orale e della testimonianza è stato cruciale: la Shoah, gli enormi archivi che si sono formati, il problema della raccolta e della gestione. Su questo aspetto c’è un primo articolo di Giovanni Contini, che ha lavorato a Los Angeles alla fondazione Spielberg. Contini ci spiega in dettaglio come sono state raccolte le migliaia di interviste presenti nell’archivio, quali sono stati i criteri per la loro catalogazione e quali sono i temi che emergono. Le interviste non sono state trascritte ma indicizzate così che attraverso le parole chiave si possa arrivare direttamente alla registrazione. L’indicizzazione si rivela spesso rigida, riduce le esperienze attraverso una lettura storica semplificata. Nonostante ciò l’archivio è un corpus documentario ricchissimo che documenta non solo la Shoah ma anche la vita e la cultura ebraica nelle sue varie declinazioni. In questo caso c’è il problema che l’intervistatore non sempre riesce a cogliere la complessità o riesce a dare spazio vero al testimone perché non è uno storico e pone domande seguendo un canovaccio preparato. Questo è uno degli aspetti che ha dato adito a una serie di critiche.
Sul tema del testimone è molto interessante il caso trattato da Christoper Browining che ha lavorato su un processo a un criminale nazista che poi è stato assolto. Browning spiega i motivi per cui il criminale è stato assolto. Il tribunale non ha accettato per valide le testimonianze dei sopravvissuti perché c’erano delle piccole differenze, delle piccole dissonanze dalla documentazione acquisita e, seguendo un copione rigidamente penalistico, le ha rifiutate. Dal momento che il criminale era stato assolto dal “tribunale degli uomini”, Browning ha voluto che fosse giudicato dal tribunale della storia e così ha ripercorso tutte le sedute del tribunale, ha rivisto tutte le deposizioni ed è andato a vedere tutte le testimonianze in giro per il mondo (tra cui quelle della Spielberg Foundation) che riguardassero il campo in cui aveva operato il criminale nazista. Ha confrontato le storie, spiegato le incongruenze e le dissonanze riportandole alle logiche delle narrazioni, svelando infine la verità storica in contraddizione con la verità giudiziaria. Nel ricostruire questo materiale Browning fa una critica di come queste testimonianze raccolte, non da uno storico, abbiano sviato il racconto del testimone portandolo su altre tracce[ref]2. Browning C., Collected Memories. Holocaust History and Post-War Testimony, UWI, Madison (WI) 2003.[/ref]. Questo è uno degli aspetti interessanti della storia orale, io, che l’ho praticata anche molto con gli studenti, mi sono resa conto di questo. Molti studenti magari bravissimi dal punto di vista della preparazione scientifica non erano assolutamente dei bravi intervistatori, perché ansiosi, perché facevano delle domande che non c’entravano con la storia, portavano la persona su un’altra strada, suggerivano la risposta. Altri studenti invece, molto meno preparati, erano dei bravissimi intervistatori perché capaci di ascolto. Questo direi che è il problema molto semplice, anche banale, della storia orale: la capacità di ascolto. Nel volume ce lo dice molto bene lo storico israeliano Kobi Peled, che pone al centro proprio questo tema: la capacità di ascoltare e di rimanere in silenzio. Peled è un ebreo-israeliano, figlio di sopravvissuti della Shoah, ma nella sua ricerca segue le vicende degli arabi-israeliani; nel suo saggio ci racconta il rapporto importante e complesso che si instaura tra portatori di opposte storie.
I due interventi che più riflettono sul dialogo tra intervistatore e intervistato sono quelli di Alessandra Dino e di Giovanni Starace. Dino, sociologa, ha svolto una lunghissima intervista a un ex boss mafioso e ci descrive il suo coinvolgimento di palermitana di fronte quello che è stato un grande assassino, mette al centro della sua riflessione questo rapporto. Giovanni Starace, psicanalista, ha fatto un lavoro in carcere con un gruppo di detenuti assieme ai quali ha riflettuto sulle vite e su una serie di tematiche inerenti la violenza. Nel saggio riflette sull’atteggiamento dello studioso nei confronti di persone “altre” con cui non può scattare un’identificazione empatica. Ci si deve muovere su un difficile crinale tra il bisogno di non affrontare il dialogo con giudizi preventivi che impedirebbero qualsiasi rapporto e nello stesso tempo con la capacità di raccontare il male. Nell’ultima sezione del volume i saggi si misurano con le testimonianze rese in sedi istituzionali che vedono di fronte non il ricercatore e il testimone ma spesso il perpetratore e la vittima con l’intermediazione di una corte più o meno formalizzata. Si situano questi casi nelle fasi di transizione da dittatura a democrazia, dopo tragiche vicende di violenza di massa o di repressioni sanguinose, quando la memoria è dolore, trauma recente non elaborabile. La testimonianza è in questi casi memoria delle vittime ma anche ricerca di verità e giustizia in un processo molto complesso che si differenzia nei vari casi riportati nel libro[ref]3. Gribaudi G. (a cura di), Testimonianze e testimoni nella storia del tempo presente, Editpress, Firenze 2020.[/ref].
Alessandro Casellato: Delle cose che ha detto Gabriella almeno due mi farebbe piacere riprenderle dal momento che sono legate a dei temi su cui stiamo riflettendo come Aiso. Una è la questione degli archivi orali e l’altra è l’intervista come relazione tra persone, in contesti specifici, dentro luoghi determinati. La questione degli archivi è molto attuale oggi perché abbiamo almeno due generazioni sul campo che hanno prodotto, nei decenni passati, fonti che sono diventate dei documenti sonori. E sono fonti a tutti gli effetti. Come Robert Browning, chiunque di noi potrebbe avere l’interesse ad attingere a testimonianze raccolte in passato, per ricerche proprie e diverse da coloro che quelle fonti le hanno prodotte. Ma c’è un problema materiale di conservazione degli archivi: su questo stiamo lavorando non solo come Aiso, ma anche con altre associazioni e con le istituzioni che sono preposte alla conservazione delle fonti e che stanno cercando di raccogliere l’invito della stessa Unesco di occuparsi con urgenza della salvaguardia di questi supporti particolarmente fragili e deperibili che sono i nastri. L’Unesco chiama alla digitalizzazione come primo passo per mettere in salvo questi archivi. Ma non è solo una questione tecnica, è una questione che tocca il modo in cui quelle fonti sono state prodotte e un legame che è viscerale dei ricercatori con le loro cassette, con le loro registrazioni. Quelle fonti, soprattutto nei decenni passati, sono nate da un rapporto di confidenzialità molto forte – talvolta cementato da una comune militanza politica – che ha fatto sì che possano contenere elementi straordinariamente sensibili, e una delle difficoltà che i ricercatori hanno è staccarsi da quelle fonti e fidarsi di istituzioni che siano in grado di dare sicurezza, non solo della conservazione materiale, ma anche della corretta messa a disposizione agli altri che li vogliano consultare, senza infrangere quel patto di fiducia che è alla radice delle interviste fatte. Dobbiamo cercare di fare un percorso doppio: costruire dei processi che facilitino questa transizione dalla sfera del personale, della ricerca individuale, a una sfera più pubblica che è quella degli archivi. E insieme realizzare una sorta di educazione di noi stessi a pensare che quello che facciamo, che la fonte che registriamo non è solo per noi, non è solo per la nostra ricerca, ma anche per le persone che ce l’hanno rilasciata, per i gruppi sociali che hanno partecipato alla ricerca, e poi anche per i ricercatori del futuro. Questo ci consentirebbe di avere paradossalmente una gamma molto ampia di testimonianze orali a cui appoggiarci, anche per ricerche storiche tradizionali d’archivio, cioè basate su documenti sonori frutto di interviste raccolte da altri, in tempi passati.
L’altra cosa che in qualche modo è legata a questa e che è stata al centro di un seminario online che abbiamo fatto un mese fa, è come fare storia orale a distanza e in emergenza. Tema che è esploso in seguito al Covid, la quarantena, la reclusione. È un tema che i nostri colleghi anglosassoni hanno saputo affrontare con più scioltezza e più rapidamente di noi dando indicazioni molto efficienti. Per noi è stato più complicato, perché siamo meno abituati ad usare per le interviste le piattaforme come quella che ci sta mediando l’intervista oggi, e la cosa ci dà problema. Quello che volevamo cercare di capire, raccogliendo esperienze in corso, ricerche che sono state deviate dal distanziamento sociale oppure che sono state attivate dall’emergenza Covid, è la modalità con cui fare storia orale a distanza. Quello che è uscito ha due facce. Da un lato c’è stato un rapido adattamento di quelli che dovevano fare delle ricerche e portarle a termine, come spesso succede nelle crisi. E quelli che l’hanno fatto, molto spesso ci hanno restituito una certa efficienza del mezzo, dei vantaggi notevoli dal punto di vista economico e organizzativo: si spende molto meno a fare le interviste a distanza che ad andare presso i nostri testimoni che spesso sono in altre regioni in altri continenti. è molto più rapido. E non hanno notato delle difficoltà o delle timidezze, anche da quelli più anziani, nel relazionarsi con il mezzo.
D’altro canto, a fronte dell’efficienza di questa strumentazione, ci siamo chiesti che cosa comporti tutto ciò, cioè che cosa perdiamo di quello che noi abbiamo sempre praticato, ma anche pensato da un punto di vista epistemologico. La particolarità della storia orale è quella di stabilire una relazione con una persona con cui si condivide, almeno per un po’, lo stesso luogo, con cui si respira la stessa aria, con cui ci si guarda negli occhi, come non è possibile fare attraverso lo schermo. Non è solo una questione romantica: credo davvero sia epistemologica. Può realizzarsi una storia orale decontestualizzata? Smaterializzata? Digitalizzata? In parte sì, ma ho l’impressione che perdiamo le cose più ricche, che non sono solo le parole dette. Che poi magari attraverso gli algoritmi possono essere testualizzate senza che noi ricercatori ci poniamo di fronte a quella prova, che è impegnativa ma che è straordinariamente intensa e arricchente, dell’ascolto per trascrivere. Cosa vuol dire ascoltare per trascrivere? Bisogna ascoltare in profondità. Si diceva che filologia è leggere lentamente: per noi storia orale è ascoltare lentamente, ascoltare in profondità. Poi cosa vuol dire non avere un luogo condiviso? Tutto quello che è una fatica, una spesa, cioè andare verso, attraversare spazi, vedere ambienti, entrare nelle case, è ricchissimo per noi di informazioni: è fondamentale direi. I due esempi che vengono fuori dal libro, in particolare da Giovanni Starace e Alessandra Dino, sono straordinari: Alessandra Dino fa una intervista che dura un sacco di tempo a Gaspare Spatuzza e in realtà il risultato testuale dell’intervista è miserrimo perché ipercensurato dall’autore. Eppure lei ci scrive un libro su questa storia di una intervista, e cosa è che rende interessante il suo libro? Tutto ciò che sta intorno al testo, ciò che ha potuto pensare, riflettere, negoziare.
Gabriella Gribaudi: Io ho avuto una esperienza opposta. Noi avevamo finito già da un po’ la ricerca sul centro storico di Napoli, la dovevamo presentare e siamo stati bloccati dal lockdown del Covid. Intanto avevamo iniziato una ricerca, come sempre interdisciplinare, su San Giovanni a Teduccio, che è una periferia napoletana molto estesa nell’ex zona industriale della città. Due miei colleghi sociologi hanno provato a fare interviste a distanza, ma a chi? Soprattutto a esponenti di associazioni che noi avevamo già contattato, o a figure di questo tipo. Noi invece eravamo andati nei rioni di case popolari, quei grandi alveari che rimandano alle immagini di Scampia, alle fiction incentrate sulla camorra. In realtà stavamo facendo interviste molto interessanti, molto particolari, che ci riportavano storie molto diverse da quelle che ci aspettavamo e da quelle che vengono continuamente proposte dai media. E questo non lo puoi fare con l’intervista a distanza… tu devi essere lì in quelle scale buie, in quelle strade. Perdi il dialogo diretto e perdi il luogo.
Io che sono una vecchia storica orale ho interrotto la ricerca per il Covid. Spero di ritornare questo autunno. Ecco… penso che la distanza ci faccia perdere il rapporto con certi gruppi e certe persone. Poi, per altri aspetti, si potranno fare delle interviste importanti, si potrà anche superare quel limite del confine, del contesto, di cui si è parlato. Una limitazione che spesso i giovani soffrono. Spesso, come si è detto, lavoriamo con le fonti orali in contesti circoscritti e ravvicinati; invece l’intervista a distanza renderà possibile anche fare altre ricerche, avere altri tipi di relazioni. E studieremo come avverranno.
Mi ritrovo con quello che diceva Alessandro, sulla conservazione delle fonti. Ho fatto le prime interviste negli anni 70, a Eboli. Conservo i nastri nel mio studio in alcune scatole di cartone… quando ho provato a riascoltarne uno, si sentiva malissimo. Temo che andranno perduti ma sarebbe molto complicato salvarli. Ho poi fatto un’altra grande raccolta di interviste sul tema della guerra a partire dagli anni 90. I primi anni abbiamo lavorato con registratori analogici. Per salvare le interviste e renderle disponibili alla consultazione abbiamo cominciato un grande lavoro di trasposizione in digitale e abbiamo pubblicato le registrazioni nell’archivio on line memoriedalterriorio.it, ma i risultati sono ancora limitati. Il fondo più esteso presente nell’archivio riguarda un altro filone di ricerca, quello sui terremoti, perché in quel caso abbiamo lavorato interamente con il digitale. Il digitale cambia le cose perché immediatamente puoi rendere disponibile l’intervista, è facile e quindi scatta anche un meccanismo diverso. In questo caso abbiamo reso pubbliche quasi tutte le interviste che abbiamo fatto.
Giulia Sbaffi: Mi sembra ascoltandovi che manchi un solo passaggio in questo dialogo sulla storia orale, quello della restituzione[ref]4. Chi fa storia orale deve saper prendere ma saper anche restituire: condividere la fatica che si costruisce nel lavoro; coinvolgere – come è stato per la costruzione di questo dialogo – tutte le parti dialoganti nella trascrizione e redazione finale scritta dell’intervista; riconsegnare i supporti audio, video e/o testuali alle comunità, luoghi, istituzioni, realtà all’interno delle quali il dialogo è nato, si è nutrito ed è stato pensato.[/ref]. Allora anche in maniera un po’ conclusiva, che ruolo ha la restituzione, inteso anche come tassello di un rapporto e terreno di incontro tra due soggetti, nella storia orale?
Gabriella Gribaudi: La restituzione è sicuramente importante. Nella nostra ricerca sul centro di Napoli stavamo preparando un lavoro di restituzione, un momento pubblico in cui volevamo invitare i nostri testimoni e raccontare quello che era emerso. Purtroppo il giorno era fissato nel mese di marzo e quindi è saltato tutto. Questo ovviamente è un aspetto importante, anche se non affatto facile, perché molto spesso noi lavoriamo su queste interviste, ci riflettiamo, le interpretiamo ma non sempre questa nostra interpretazione, le nostre riflessioni sono accolte bene anzi magari confliggono con le sensibilità delle persone intervistate.
Con l’archivio è più semplice, perché tu in fondo rimetti all’archivio completamente l’intervista senza fare delle valutazioni. Quando scrivi, fai delle valutazioni, rielabori, lavori sulle interpretazioni che la gente ti offre e non sempre le persone intervistate sono d’accordo con quello che tu dici o come tu hai interpretato il loro pensiero. In un lavoro in cui abbiamo intervistato più di 100 persone nel centro storico di Napoli, ci siamo chiesti – quando preparavamo l’evento che poi è saltato – come facciamo? Quali pezzi facciamo vedere? Non era facile pensare a come riportare la complessità del mondo osservato, come restituire le individualità, la soggettività e le storie che ci erano state raccontate, non è semplice rendere giustizia a una pluralità di voci.
Alessandro Casellato: Dico anche io due parole sulla restituzione ma a partire dalla collana, perché la collana, per noi che ne abbiamo discusso come comitato scientifico, ha anche un valore sperimentale, per alcuni aspetti, per esempio i diversi generi di testo che potrà accogliere: non solo atti di convegni e monografie di ricerca, ma anche eventuali strumenti, perché manca in Italia una manualistica che consenta di calare la storia orale in attività specifiche come la scuola, come fare didattica o il lavoro di comunità.
Le ricerche di storia orale hanno a che fare con la comunità; il prossimo volume sarà una ricerca sul terremoto in Irpinia del 1980 di Gabriele Moscaritolo. Ecco, la modalità sperimentale qui è nel modo di sostenere la pubblicazione. Questo non è un aspetto banale in una collana; perché possa reggere e durare nel tempo, è necessario che i libri trovino degli acquirenti, un mercato. Il libro quindi avrà anche dal punto di vista del sostegno economico, una soluzione “su misura”, un po’ come la storia orale è sempre una soluzione su misura di contesti, situazioni, momenti specifici. In questo caso, il libro di Gabriele Moscaritolo sta cercando di finanziarsi attraverso il crowdfunding, una modalità che coinvolga non solo i colleghi, i compagni, ma anche le persone del territorio, che possa anticipare con una piccola somma il libro che poi verrà dato loro. È una modalità di pensare la restituzione, attivando anche progetti di partecipazione sul territorio.
Gabriella Gribaudi: Un esempio significativo è quello di Giovanni Starace, e in questo libro c’è un piccolo stralcio del lavoro che lui ha fatto. Giovanni ha lavorato con 10 detenuti: registrava le conversazioni, le trascriveva e le rimandava loro; poi scriveva mano mano un testo che di nuovo inviava a loro, loro lo rileggevano, lo rimandavano con pensieri e appunti, e ne ridiscutevano. È stato un lavoro di restituzione, ma meglio forse di dialogo lunghissimo. Non sempre questo si può fare.
Alessandro Casellato: Capita anche già durante l’intervista che il nostro testimone sia curioso di sapere quale sia la nostra posizione, per poi posizionarsi a sua volta. Quando l’intervista funziona e il rapporto è di fiducia, c’è anche curiosità da parte del nostro testimone, di capire quale è il nostro punto di vista, quasi lo chiede perché questo lo aiuta a mettere ordine, diciamo così. Noi usiamo categorie storiografiche, cronologie che non sono quelle del vissuto della persona, ma il fatto poi di vedere la propria storia – che poi è la storia di vita vissuta in maniera tumultuosa e spesso inconsapevole – messa in ordine in occasione dell’intervista, vederla trascritta, incorniciata e fatta diventare un pezzo di storia che ha un valore, dà soddisfazione a chi ce l’ha raccontata. Ed è bello quando succede.
Gabriella Gribaudi: A me è capitato con la ricerca sulla guerra che un signore mi contattasse, dopo aver letto i miei libri, per condividere la sua storia, una storia molto drammatica. Lui veniva dal salernitano e aveva visto morire sotto i suoi occhi tutta la sua famiglia travolta da un bombardamento durante lo sbarco di Salerno degli Alleati e ci teneva che la sua storia diventasse pubblica, che la memoria della sua famiglia emergesse dal silenzio, voleva in qualche modo offrire loro quella che De Certeau ha definito una “tomba scritturale”. Mi ha scritto, sono andata a casa sua, ho raccolto la sua storia ed è una delle storie dell’archivio on line. Poi anche su questa storia e sui modi attraverso cui è giunta a me ho riflettuto nei testi scritti.
Alessandro Casellato: Restituire anche in un contesto cognitivo, poi, che è diverso da quello dei nostri testimoni. Questo è delicato: noi non dobbiamo raccogliere quello che ci viene detto e restituirglielo pari pari, a specchio, perché non serve a niente, è un lavoro anche dal punto di vista “civile” non produttivo. Il nostro mestiere è comunque quello di fare un lavoro critico sulle fonti e interpretarle, metterci dentro le nostre domande e conoscenze, ed è questo che fa crescere sia noi che loro. Quando qualcuno restituisce di me un punto di vista diverso di quello che io riesco a comprendere, posso capire delle cose di me stesso, e così i gruppi sociali con cui noi lavoriamo. Questo è fondamentale per noi ricercatori: non abdicare, per ottemperare ad una facile restituzione, alla nostra funzione che è critica.