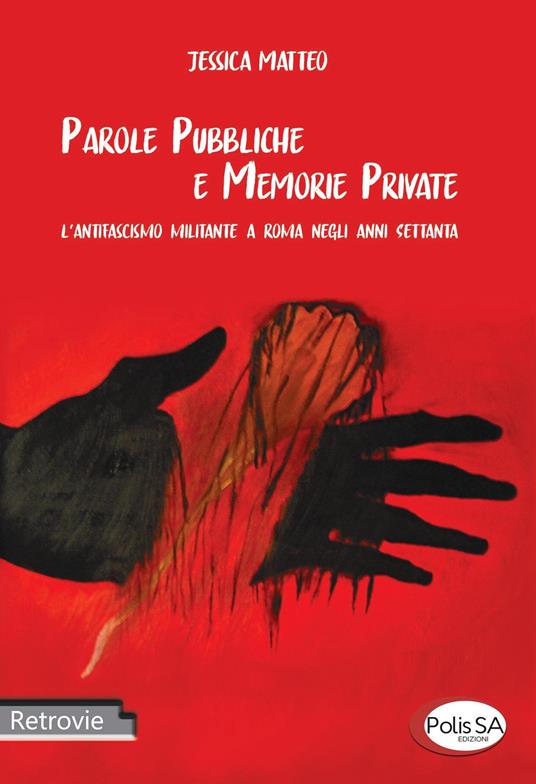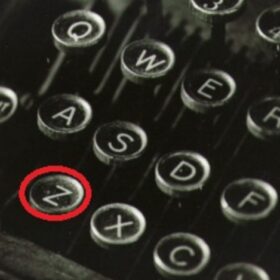Jessica Matteo, Parole pubbliche e memorie private. L’antifascismo militante a Roma negli anni Settanta, Polis SA Edizioni, 2020, pp. 218
12 dicembre: strage di piazza Fontana, a Milano, ma è anche superfluo dirlo.
Per ricordarci di questo anniversario, pubblichiamo oggi la recensione di Giovanni Pietrangeli al libro di Jessica Matteo sull’antifascismo militante, da breve ri-edito.
«e penso al 12 dicembre ’69…»
Giovanni Pietrangeli
L’antifascismo militante negli anni settanta è uno dei nervi più sensibili della storia repubblicana. Tanto parte della storiografia accademica, quanto il fiorente genere delle pubblicazioni polemiche, ne hanno fatto una sorta di simbolo della violenza fine a se stessa, in continuità con la lotta armata ed equiparandolo con lo stragismo neofascista degli stessi anni. Negli ultimi due decenni, lo spazio pubblico, dalle città ai media, è stato sovraccaricato di manifestazioni, simboli, linguaggi che hanno teso alla decontestualizzazione – e quindi alla perdita di senso – dell’esercizio della violenza politica negli anni sessanta, settanta e ottanta.
Le ragioni politiche più profonde di questa tendenza sono varie e complesse. Sicuramente ha avuto un suo peso la forza acquisita dai partiti eredi del Movimento sociale italiano, con una dirigenza formatasi dentro quella storia. Il ricordo delle proprie vittime, «trincea» ed elemento identitario del neofascismo italiano, è uscito dal recinto e si affermato come memoria pubblica, influenzando il calendario civile repubblicano e aprendosi al dibattito mainstream. In generale, il cosiddetto paradigma vittimario ha molto influenzato la riflessione sul periodo che va dagli anni sessanta agli anni ottanta, catalizzando e schiacciando l’attenzione sugli aspetti più traumatici di una stagione di forte tensione e importanti innovazioni.
Il libro di Jessica Matteo Parole pubbliche e memorie private, uscito nel 2020 e ora ripubblicato, affronta dunque una questione sempre calda, che si riapre ciclicamente con l’avvicinarsi degli anniversari e delle commemorazioni. Lo fa anche con gli strumenti della storia orale, che più di altre pratiche di ricerca mette al centro la testimonianza e la relazione con il/la testimone.
È una scelta importante, perché, riportando le parole dell’autrice, vuol dire «dare spazio alla memoria dei protagonisti degli anni Settanta a Roma e comprendere quanta e quale parte ha avuto l’esperienza antifascista nel vissuto dei militanti» (p. 89). Significa ripercorrere passaggi traumatici dell’esistenza personale, passaggi sui quali, in alcuni casi, può vigere ancora una “regola del silenzio” condivisa tra i/le testimoni. La scelta di mantenere l’anonimato nelle testimonianze – i nomi sono sostituiti da sigle – potrebbe essere stata dettata da questo problema, per quanto non esplicitato. Esistono, nella storiografia sui movimenti rivoluzionari, precedenti problematici su questo aspetto.
Altra ragione per cui è significativa la scelta delle fonti orali, è che significa inserire a pieno titolo la memoria di collettività oggi demonizzate e marginalizzate nella narrazione della storia nazionale.
Sulle scelte – più o meno obbligate – che Jessica Matteo ha dovuto compiere nell’identificazione dei testimoni, nei primi approcci e nella raccolta delle interviste, sono assai interessanti i primi paragrafi del secondo capitolo. In quelle pagine si racconta come una persona, distante anagraficamente e non solo dal gruppo dei testimoni, è riuscita a destare l’interesse e a raccogliere la fiducia dei testimoni, pur con tutte le difficoltà che emergono comunemente in questo genere di lavori – a esempio nell’assenza di voci femminili (pp. 92-94). È quindi un utile strumento per la cassetta degli attrezzi di chi si approccia alla storia orale, specie su tematiche conflittuali. Le biografie umane e politiche dei testimoni, brevemente riassunte in una appendice, sono assai varie: c’è chi ancora prosegue l’attività politica e chi si è affermato come professionista, chi è passato per il carcere, chi ha elaborato un punto di vista estremamente critico verso la propria esperienza militante e chi partecipa attivamente al dibattito sulla storia degli anni settanta.
Il titolo del volume, tuttavia, rende chiaro fin da subito che il perimetro entro cui vuole muoversi l’autrice travalica la dimensione privata, intima, della memoria. Affianca infatti le interviste con i linguaggi adottati nella stampa della sinistra rivoluzionaria dell’epoca. La testata «Lotta continua» è stata utilizzata come fonte principale per quanto riguarda l’analisi delle parole pubbliche del titolo. Il giornale, analizzato dal 1970 al 1976, dedica ampio spazio alla cronaca e all’analisi degli scontri tra neofascisti e militanti della propria organizzazione e non solo. Particolarmente attenta nel giornale è la cronaca delle vicende giudiziarie: dal processo per la strage di piazza Fontana, quando è ancora imputato Pietro Valpreda, ai vari procedimenti nei confronti di militanti coinvolti in fatti di violenza politica. Come riporta l’autrice, la retorica del giornale «Lotta continua» viene definita «militarizzata» e dunque in continuità con chi ha visto nell’antifascismo militante un «fondamento della lotta armata» (p. 19). Per il sentire odierno, i titoli suonano iperbolici. Era la cifra della comunicazione politica dell’epoca, non solo di quella della sinistra rivoluzionaria, che – per inciso – espresse anche alti livelli di analisi socio-economica, guardando al mondo del lavoro e della produzione con un occhio lungimirante e articolato. Nonostante la posizione dell’autrice sulla continuità tra antifascismo militante e lotta armata sia esplicitamente critica (p. 202), la centralità data dalla narrazione alla violenza che in più di un passaggio sembra essere fine a sé stessa o del tutto depoliticizzata, mina l’impianto teorico generale del libro. Manca infatti, dal punto di vista di chi scrive, il confronto con la storiografia che rilegge la genealogia della violenza nel lungo ’68: da una parte rifiutando lo spartiacque della strage di piazza Fontana del 1969 come cesura per la radicalizzazione delle pratiche, dall’altro riconoscendo allo stragismo fascista un grado di autonomia differente rispetto al paradigma della “strage di stato”. In un articolo del 2018, su questa stessa pagina web, Tommaso Rebora offriva un utile excursus sulla letteratura che affronta la «mancata elaborazione della temporalità» rispetto alla violenza politica[1].
Sul secondo punto – l’autonomia dello stragismo e dello squadrismo negli anni settanta – è stato invece Marco Grispigni a fornire puntuali osservazioni. Prima di tutto, sull’ “eccezione” italiana nel Mediterraneo: va ricordato infatti che fino alla metà dei settanta Spagna, Portogallo e Grecia erano retti da dittature di destra, tutte e tre per altro attive nel sostegno ideologico, politico e logistico alle organizzazioni neofasciste italiane e ai reduci del collaborazionismo saloino[2]. Un contesto in cui matura anche il tentativo di golpe di Junio Valerio Borghese. Il 1973 è l’anno del colpo di stato in Cile: un evento con un forte impatto traumatico per il nostro paese, nonostante la distanza, dove matura anche l’ipotesi del compromesso storico. Inoltre, sull’autonomia dello stragismo, propone la lettura, condivisa anche con Mirco Dondi, sulle «stragi di intimidazione» per tutto il periodo successivo al 1973. Prendere in mano queste letture avrebbe permesso anche di approfondire quanto ricorda uno degli intervistati sui soli militanti e simpatizzanti di sinistra assassinati tra l’omicidio di Paolo Rossi nel 1966 e il 1976: ben 25, escluse dunque le vittime delle stragi (p. 139).
Nel raccontare Roma e i conflitti nelle scuole e nei quartieri, il libro ci fa incuriosire sulle possibili ragioni, sociali, economiche, biografiche, per cui ci si avvicinava al campo dell’antifascismo o a quello della destra radicale, ma si ferma a registrare il dato. Per concludere, il volume è un esperimento importante di entrare su un “campo minato” della storiografia e della storia pubblica e ci entra grazie a una delle metodologie più difficili da seguire: fare interviste, tanto più su una stagione così densa di conflitti e traumi individuali e collettivi – tra stragi, tensioni politiche, carcere – richiede tempo e cura, certamente più che con gli archivi.
La scelta di collocare la pratica dell’antifascismo militante in una posizione autonoma rispetto al quadro generale, italiano e mediterraneo, non chiarisce fino in fondo perché una generazione, cresciuta al tramonto della golden age postbellica, demograficamente straripante, al centro di conflitti più o meno espressi tra stati, blocchi, partiti di massa, si sia messa in gioco in maniera così radicale da segnare per i decenni successivi il rapporto tra politica ed esercizio della violenza e l’intera interpretazione di una stagione di intense trasformazioni politiche e sociali.
[1] Tommaso Rebora, Colmare gli oblii della memoria per rinunciare al paradigma vittimario, http://storieinmovimento.org/2018/09/05/paradigma-vittimario-rebora/
[2] Marco Grispigni, Sull’abuso del concetto di «strategia della tensione», https://www.machina-deriveapprodi.com/post/sull-abuso-del-concetto-di-strategia-della-tensione