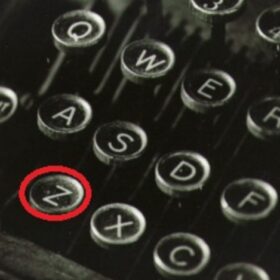La sera 13 dicembre se n’è andato Mario Dondero. Lo vogliamo salutare rileggendo un suo intervento pubblicato su «Zapruder», n. 2 (settembre-dicembre 2003).
Obiettivi bellici. Raccontare la guerra con le immagini (di Mario Dondero)
Due stracci bianchi posati in una rozza trincea su indumenti polverosi e membra dislocate che devono essere stati degli uomini… degli uomini: soldati iracheni che si arrendevano. Sbrigativamente soppressi, viene da pensare, dall’armata d’invasione per il solito eccesso di prudenza. Una scena illuminante proposta al centro della prima pagina di “El Pais” in una domenica d’aprile. Una foto banale in fondo, di nessuna spettacolarità, deliberatamente ignorata da molti media in quanto scomoda e folgorante denuncia come solo sa esserlo la fotografia. Viene da chiedersi come un’immagine così efficacemente rivelatrice abbia potuto superare una serie di ostacoli censori che non erano soltanto quelli frapposti dalla macchina bellica in avanzata, ma anche quelli successivi in seno alle redazioni. In un piccolo volume che si propone come un manuale per orientarsi nella nebbia di notizie che ha avvolto la guerra (cfr. Roberto Reale, Non sparate ai giornalisti. Iraq: la guerra che ha cambiato il modo di raccontare la guerra, prefazione di Ilvo Diamanti, Nutrimenti, 2003) si esaminano le importanti “novità” che hanno caratterizzato questo secondo volano della “guerra del petrolio”. La foto sulla copertina del libro, scattata l’8 aprile del 2003 all’hotel Palestine di Baghdad da Patrick Baz dell’Agenzia France-presse, un teleobiettivo insanguinato, racconta da sola, più di mille parole, avrebbe detto Walter Benjamin, la cruda realtà.
Le immagini della presunta fraternizzazione fra i “nostri” – cioè gli americani – e i civili iracheni, che hanno invaso le prime pagine della stampa italiana e straniera, hanno palesato evidenti indizi di forzatura, lasciando filtrare la domanda se le foto dei marines con i bambini in braccio non fossero artificiali messe in scena. Nella Baghdad bombardata senza nessuna cautela per le vite umane (con bombe anche da mille chili), non si è manifestata – secondo il racconto di molti testimoni – alcuna forma di tripudio da parte degli iracheni, se non la gioia di essere scampati alla morte. Sulla piazza del Paradiso, dove con scarsa furbizia gli americani hanno abbattuto la statua di Saddam Hussein, non c’era ad assistere allo spettacolo che un’esigua presenza di curiosi in una metropoli di cinque milioni d’abitanti. Lo hanno visto moltitudini di telespettatori.
Se la prima guerra del Golfo, un grosso business riservato principalmente ai grandi network anglosassoni, è stata seguita con difficoltà da giornalisti e fotografi, la guerra in Iraq ha avuto una copertura mediatica molto più grande, sia al seguito dell’armata d’invasione che sotto il cielo di Baghdad. Approcci e storie sempre drammatiche, in condizioni ben differenti. Ci sono stati così gli embedded, aggregati alle unità della Coalizione (embedded letteralmente “a letto con”) e un contratto da rispettare che impegnava i media ad obbedire ad un certo numero di regole di base. Il Pentagono prevedeva in un primo tempo di inglobare fra le sue forze circa 500 operatori dell’informazione che finirono con l’essere quasi il doppio. Un’avventura stars and stripes, con il gusto tutto americano delle pubbliche relazioni, in cui si mescolavano grande etica giornalistica e conformismo autocensorio, nel vento “patriottico” che accompagnava l’imperiale armata americana nel deserto iracheno.
Tuttavia non tutti gli embedded erano lì per occuparsi unicamente del soldato Ryan o più precisamente della soldatessa Jessica Linch. I fotografi poi, potendo intervenire in modo agile e rapido, sono riusciti, anche in quel contesto, a produrre talune immagini fortemente significative come quella citata all’inizio, spiragli di verità nella rappresentazione war game prevalente. Così quella agghiacciante pubblicata il 14 aprile da “Le Monde”, scattata da un veterano della fotografia di guerra – il belga Laurent Van der Stocht dell’Agenzia Gamma ma sotto contratto per il supplemento del “New York Times” – che mostra, ad esempio, il corpo esanime di un uomo disteso nella polvere. Un morto senza nome che non è un soldato. La didascalia chiarisce che si tratta di un vecchio che stava camminando lentamente su un marciapiede, ucciso dai Marines. Van der Stockt ha reso a “Le Monde” il racconto della sua esperienza di embedded con un battaglione di fucilieri di marina americani nell’avanzata verso Baghdad, in cui narra di aver visto uccidere dei civili. “Gli snipers hanno ricevuto l’ordine di uccidere tutto ciò che avanzava verso di loro”. Come si vede, anche la più sofisticata delle censure non riesce a imbavagliare le voci libere, persino quando gli spazi d’autonomia sono quasi totalmente repressi.
Così, nonostante i ripetuti ammonimenti di Bush, che invitavano i media internazionali ad abbandonare Baghdad e il popolo iracheno alla sua sorte, un gran numero di operatori dell’informazione sono rimasti, malgrado le difficoltà che opponevano le stesse autorità irachene. Se abbiamo potuto apprendere tante cose lo dobbiamo a loro. Donne e uomini magnifici che hanno scritto con la penna, con le immagini, con la voce, belle pagine di libertà.