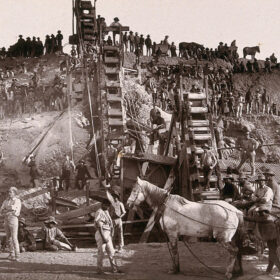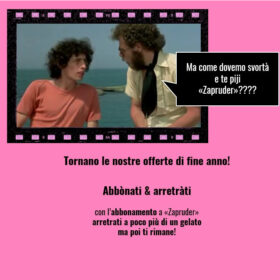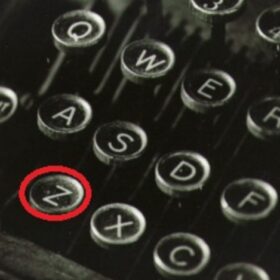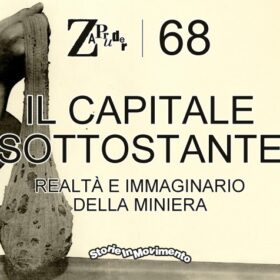In occasione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione e per cominciare ad affrontare i temi del dialogo dal titolo “Ottant’anni dopo“, che si terrà venerdì 25 luglio al SIMposio (programma e iscrizioni qui), abbiamo chiesto ad Andrea Tappi – uno dei dialoganti insieme a Luca Baldissara, Mirco Carrattieri, Chiara Colombini e Santo Peli – cosa pensa in particolare della trattazione della Resistenza a scuola oggi.
Andrea Tappi è co-auore insieme a Javier Tébar Hurtado de “La Resistenza e la Transizione spagnola a scuola. Storia e memoria del passaggio dalle dittature alla democrazia” (Carocci 2025), che sarà presentato a Napoli il 20 maggio (maggiori informazioni qui).
Una Resistenza non banale per decine di migliaia di giovani
Nel vostro libro proponete un bilancio della storia politica dell’insegnamento della Resistenza alle superiori…
La Resistenza in Italia (come la Transizione postfranchista degli anni settanta in Spagna di cui pure parliamo nel libro) catalizza l’attenzione degli storici ed è oggetto di frequenti riferimenti nel discorso pubblico e istituzionale. La prospettiva in cui ci siamo collocati mira a concentrarsi sulle modalità che il dibattito storiografico e le narrazioni pubbliche assumono nell’ambito del contesto scolastico. Un contesto quantitativamente e qualitativamente importante, in quanto coinvolge ogni anno decine di migliaia di giovani cittadini in formazione. L’attuale panorama politico sembra, del resto, alimentare i timori di una deriva populista e di una netta virata identitaria, attestata, nel caso italiano, dalla revisione dei programmi di storia e di educazione civica da parte del ministro Valditara (di cui avevamo già parlato qui). Un antidoto a questa deriva è insistere su un atteggiamento che tenda maggiormente a una lettura problematizzante dei fenomeni storici e ne restituisca l’ampiezza e la complessità. Invece, l’assimilazione passiva delle informazioni rischia di far scivolare la trattazione della storia in facili banalizzazioni – che è indubbiamente quanto di più dannoso possa avvenire a scuola – e che riproduca e alimenti letture funzionali a un uso del passato fuorviante e strumentale. Negli anni cinquanta, un compatto fronte anticomunista guidato dalla Dc ostacolò fino al 1960 l’inserimento della storia successiva alla Prima guerra mondiale nei programmi e nei libri di testo. Anche le vicende della Resistenza cominciarono lentamente a essere trattate, ma era una Resistenza “moderata” a prevalere, fortemente de-ideologizzata e perfettamente coerente con il discorso pubblico ufficiale, diffuso in ambito scolastico da specifiche disposizioni ministeriali. Substrato di questa narrazione era la tesi della guerra partigiana come secondo Risorgimento, con un intero popolo unanimemente votato a combattere la tirannia straniera. Una guerra partigiana, quindi, depotenziata degli elementi conflittuali e divisivi interni, insiti nell’opzione antifascista sulla quale si era basata la pedagogia civile della Resistenza, sostenuta prevalentemente dal Pci, a fondamento della costituzione repubblicana ma anche del rinnovamento della scuola italiana. Accanto al mito della Resistenza tradita, la polemica contro la retorica che accompagnava questa narrazione fu uno degli elementi principali dell’atteggiamento assunto dalla generazione del Sessantotto: la generazione dei “nati dopo”, che non aveva vissuto la guerra e che, secondo un’inchiesta di metà anni sessanta, aveva difficoltà a dare una forma concreta a cosa fossero la Resistenza e la guerra partigiana. Di qui anche l’esigenza, sentita soprattutto a sinistra, di colmare lo scarto generazionale, assecondando le istanze degli studenti e proponendo nelle scuole e nelle università una lettura della Resistenza che, lungi dalla sua monumentalizzazione, fosse funzionale all’analisi e alla critica della società industriale e capitalistica. Nel corso degli anni ottanta, la Resistenza andò perdendo importanza nel dibattito pubblico; nelle aule, quando veniva studiata, sembrava ormai qualcosa di lontano e poco interessante. Andò diminuendo anche la frequenza di indagini volte a monitorare la trattazione della Resistenza nei manuali, dopo che tre grandi inchieste di respiro nazionale, maturate nell’ambito di affollati convegni e di un’ampia collaborazione tra storici accademici e insegnanti medi, si erano succedute a distanza ravvicinata tra il 1964 e il 1971. Da quel momento in poi, tali convegni, promossi dall’Istituto nazionale per la storia del movimento di Liberazione in Italia dall’Associazione nazionale partigiani d’Italia, lasceranno il posto a poche circoscritte indagini, normalmente affidate a docenti di scuola e non a storici di professione. In ultimo, che l’interesse per la Resistenza a scuola non si sia mai affermato del tutto lo testimonia il fatto che rarissime volte è stata oggetto di un quesito specifico agli esami di stato, anche dopo che, nel 1996, per effetto del decreto Berlinguer, lo studio del Novecento è divenuto oggetto esclusivo dell’ultimo anno delle superiori.
A seguito della caduta del muro di Berlino e della fine della cosiddetta Prima repubblica, anche il paradigma antifascista su cui essa si era fondata venne rimesso in discussione e da quel momento la Resistenza fu sottoposta a un feroce attacco mediatico con toni da Guerra fredda. Soltanto in anni più recenti, anche per l’impegno della presidenza Ciampi (1999-2006), la Resistenza sembra aver riguadagnato una qualche credibilità e il 25 aprile appare aver recuperato una centralità perduta nel 2015, in occasione della celebrazione del 70° della Liberazione. Ciò è avvenuto, in ogni caso, all’insegna di una Resistenza, che nel discorso pubblico è presentata come fenomeno inclusivo, corale e ancora una volta patriottico, appiattito sulla dimensione di una indistinta “gente comune”: una categoria di scarsissimo valore euristico sul piano della ricostruzione storica.
Come viene raccontata la Resistenza nei libri di testo delle superiori?
Nonostante che negli ultimi decenni la storiografia abbia compiuto fondamentali passi in avanti sulla strada di una comprensione più ampia e approfondita della Resistenza, condizionamenti, soggettività, sfumature, differenze di ogni genere e classe che nei venti mesi della guerra partigiana caratterizzarono le scelte e gli atteggiamenti di chi vi aderì non trovano grande riscontro a scuola. Basti pensare, ad esempio, che negli ultimi quarant’anni solo due volte la Resistenza è stata oggetto di un quesito specifico all’esame di maturità. Per il resto, soltanto sparuti riferimenti tangenziali e fuori fuoco: difficilmente si può affermare che essa abbia avuto una qualche rilevanza tra le centinaia di quesiti e documenti proposti ai candidati. I curricoli, gli esami e, in particolare, i manuali svolgono un ruolo decisivo di mediazione tra il senso comune storiografico e le memorie pubbliche. Dunque, il senso dell’operazione che abbiamo condotto nel libro è stato quello di concentrarci sulle superiori a partire dai limiti dei manuali in uso attualmente, sia di contenuto che di metodo, per rivendicare invece una loro funzione attiva che colmi il ritardo rispetto alla storiografia sulla Resistenza, quale antidoto contro letture edulcorate e stereotipi diffusi. La Resistenza e la guerra partigiana raccontata nei manuali, di fatto, acquisiscono soprattutto un’importanza strumentale entro un paradigma antitotalitario e vittimario, che trova riscontro nell’accento posto sulle ricadute della guerra sulla popolazione civile, inerme e innocente. Viene, invece, sacrificata la principale specificità della Resistenza italiana, ovvero che si sviluppò a partire dal rifiuto generalizzato della guerra in un paese che, dopo aver dato i natali al fascismo e vissuto le sue reboanti campagne militari, precipitò in una profonda crisi morale e in una drammatica discrasia istituzionale. Inoltre – e questo è un aspetto su cui i manuali continuano a indulgere – presentano una generalizzata attenuazione di qualsiasi fattore divisivo interno (la Resistenza come fondamento della democrazia in Italia e il nesso logico tra questa e una Costituzione dalla matrice antifascista; la componente di classe e la tensione rivoluzionaria, volte al rinnovamento sociale e politico; la preminenza accordata alla lotta di liberazione del suolo patrio dallo straniero occupante). Lo scarto rispetto alla storiografia è misurabile anche nei termini dell’assenza di un’analisi puntuale delle opzioni e delle diversificate moralità della Resistenza, tanto più che, continuando a privilegiare la dimensione politico-militare della guerra partigiana, i manuali rendono arduo il compito di comprendere a fondo il carattere problematico di una Resistenza molto più diffusa, multiforme e mutevole. Pochissimi, poi, sono ancora oggi i testi che si soffermano, per esempio, su una vicenda controversa come quella degli Internati militari italiani, protagonisti di una “Resistenza senza armi”, o quelli che si discostano dallo stereotipo della donna partigiana combattente. Più in generale, si ha la sensazione che l’attuale generazione di manuali tenda sempre più a semplificare all’estremo processi storici complessi, anche per mezzo di un vocabolario poco appropriato e specifico. Inerziali consuetudini e imperativi editoriali fanno il resto: imprecisioni, omissioni, reticenze più o meno intenzionali sono all’ordine del giorno e da ciò a fornire una lettura potenzialmente rassicurante e conformista il passo è veramente breve.