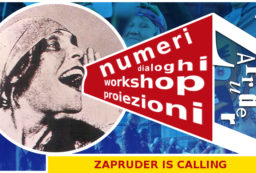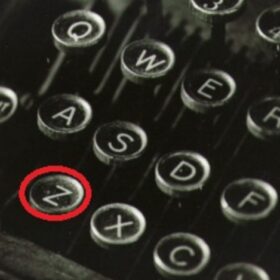Il nuovo numero di «Zapruder», “Anime in pena” (guarda l’indice qui), vuole analizzare in che modo e secondo quali traiettorie i soggetti sottoposti a determinati trattamenti disciplinari, la comunità civile e i movimenti sociali abbiano contribuito alla sopravvivenza, alla riforma, al superamento o all’abolizione dei differenti regimi e dispositivi di pena, coercizione o correzione.
Poiché ci occupiamo di storia e storie, ma viviamo anche noi qui e ora, per accompagnare l’uscita di questo numero pubblichiamo – in tre puntate – un contributo di I.B. che analizza l’intreccio tra carceralità, ingegneria degli spazi, operazioni infrastrutturali e colonialità nell’oppressione del popolo palestinese per mostrare come le infrastrutture abbiano costituito un pilastro fondamentale nella realizzazione e nel consolidamento del progetto europeo sionista in Palestina.
«Come si scrive mentre è in corso un genocidio?»
Infrastruttura della colonizzazione, infrastruttura della resistenza
(parte prima | la seconda parte la puoi leggere qui | la terza qui)
I.B.
Infrastrutture eoloniali e carceralità
«Come si scrive mentre è in corso un genocidio?» (cfr. Salamanca et al. 2024). Mi associo alle perplessità di quanti si interrogano sui limiti epistemologici, analitici e rappresentazionali della scrittura e della ricerca di fronte a una violenza tanto persistente quanto sistematica. Eppure, come ha recentemente osservato Nicki Kattoura (2024), è proprio attraverso una produzione incessante di parole che il progetto sionista è riuscito a costruire e consolidare, almeno in Occidente, l’immagine dei palestinesi come “esseri subumani” (cfr. Brown 2015); ed è proprio grazie alle parole e alle azioni dei palestinesi e dei loro compagni che il movimento per la liberazione è cresciuto e continua a crescere. In questo contesto – per quanto inadeguato possa apparire di fronte alla portata della distruzione in atto – questo contributo si inscrive in quello sforzo collettivo di non smettere di continuare a parlare, scrivere e organizzarci contro la violenza dell’infrastruttura coloniale e dei suoi processi di razzializzazione.
La colonialità delle infrastrutture
Le infrastrutture vanno intese come quelle strutture «destinate a diventare invisibili» (Hetherington 2016, p. 62), come suggerisce il prefisso “infra-”, che indica un funzionamento spesso “al di sotto” della soglia di consapevolezza degli utenti. Proprio questa loro invisibilità ha permesso ai colonizzatori europei di costruire un «sublime coloniale» (Larkin 2008, p. 16), attribuendo alle infrastrutture un significato tangibile e simbolico che sostenesse il progetto coloniale attraverso i tropi dello sviluppo, della modernità e del progresso. Pertanto, il processo di decostruzione di tale sublime richiede un’“inversione infrastrutturale” (Bowker 1994), ovvero un esercizio analitico volto a portare alla luce le relazioni sociali di violenza coloniale e capitalista, segnate da espropriazione indigena e differenziazione razziale, incorporate e diluite nella matrice materiale fatta di cemento, cavi e tubature. Attraversando lo spazio e il tempo, le infrastrutture trasportano nel presente le asimmetrie di potere del passato, cementandone la riproduzione (Cowen 2017); comprenderle come archivi, ci consente di leggerle come una vera e propria cartografia del potere imperiale. Furono infatti proprio le infrastrutture a facilitare l’incorporazione di ampie parti del mondo nei circuiti della circolazione globale, contribuendo così all’espansione del capitalismo su scala planetaria. Questo processo non fu né neutrale né spontaneo, ma, come osserva Marx (1990[1867], p. 874), «il capitalismo viene al mondo grondante sangue e sporcizia dalla testa ai piedi, da ogni poro». A tal proposito, rielaborando la tesi marxiana dell’accumulazione originaria, l’attivista e studioso della Yellowknives Dene First Nation Glen Coulthard (2014b, p. 58) definisce il colonialismo come una “forma di espropriazione strutturata” e, partendo dall’idea di accumulazione originaria come «trasformazione violenta di forme di vita non capitaliste in forme capitaliste» (ibidem), ritiene che il colonialismo, sottraendo alle comunità indigene i mezzi di sussistenza – in primo luogo la terra –, ha sostenuto le relazioni capitalistiche di produzione in almeno due modi: da un lato, promuovendo la privatizzazione delle terre comuni attraverso la recinzione dei territori e delle risorse; dall’altro, nel tempo, subordinando il lavoro alle logiche di sfruttamento del mercato attraverso processi di “proletarizzazione” (ibid.). In tal senso, il processo “originario” – fatto, secondo Marx (1990[1867], p. 874), di «conquista, rapina, assassinio» – ha rappresentato una forza strutturante nella riproduzione delle relazioni capitaliste.
Analogamente, in Palestina, così come in altri contesti coloniali, l’appropriazione della terra indigena e la conseguente espropriazione dei fallaheen – agricoltori o contadini delle comunità rurali palestinesi – si sono configurate come elementi determinanti nel processo di formazione dell’enclave coloniale di insediamento e nell’accesso dei coloni sionisti europei alla terra (Abdo 2024). In molte economie indigene, infatti, la forza lavoro è intrinsecamente legata alla terra attraverso pratiche consuetudinarie e relazioni che non sono mediate dalla logica proprietaria; in tali contesti, terra e lavoro non sono ancora separati né reciprocamente alienati (Coulthard 2014a). Per rompere questo rapporto indissolubile, è stato necessario un processo sistematico di privatizzazione e mercificazione sia della terra che del lavoro (Quiquivix 2013). In questo quadro, la British Land Law del 1920 ha rappresentato un momento cruciale introducendo per la prima volta in Palestina la privatizzazione fondiaria, inclusa l’appropriazione delle terre mushaa’ – ovvero i terreni agricoli collettivi, detenuti congiuntamente dalla comunità e soggetti a una tassazione flessibile secondo il Codice fondiario ottomano del 1858 (Hope-Simpson 1930). Sebbene inizialmente rallentato dalla forte resistenza palestinese, questo processo ha progressivamente disarticolato le relazioni indigene con la terra e la comunità, relazioni fondate su concezioni della proprietà come forma di affetto, responsabilità e appartenenza collettiva. Tali legami sono stati sistematicamente sovvertiti dagli “eurocoloni” (cfr. Okoth-Ogendo 2008) attraverso la riduzione della terra e delle sue relazioni a una semplice cartografia bidimensionale, composta da lotti numerati, titolati e regolati da regimi giuridici basati sulla proprietà individuale. Le mappe catastali, in questo contesto, non solo servirono a tracciare i diritti fondiari, ma reificarono la frammentazione della territorialità indigena, disarticolandola in unità spaziali separate e giuridicamente individualizzate (Kain & Baigent 1992; Gavish & Kark 1993). Tali assetti vennero successivamente consolidati dalle riforme agrarie e dai processi di israelizzazione delle terre tra il 1948 e il 1960. Progressivamente, le mappe divennero strumenti accessibili quasi esclusivamente ai letterati e agli amministratori coloniali, risultando invece opache o inaccessibili per le comunità rurali e poco alfabetizzate. È infatti evidente che, in Palestina come altrove, la produzione cartografica imperiale svolse un ruolo centrale nei processi di colonizzazione. Basti considerare che, sebbene il mandato britannico sia stato ufficialmente istituito nel 1922, già tra il 1871 e il 1877 il British Palestine Exploration Fund aveva condotto un’indagine cartografica della Palestina occidentale (cfr. Gavish 2005). Presentata formalmente come un’impresa accademica e religiosa, questa esplorazione era però sin dall’inizio strettamente intrecciata con gli interessi strategici dell’impero britannico, il cui coinvolgimento diretto rivela come le tecnologie cartografiche fossero impiegate non solo per fini conoscitivi, ma soprattutto come strumenti di gestione e controllo territoriale. Questo accesso privilegiato a informazioni dettagliate sul territorio si tradusse, in seguito, in un vantaggio tecnologico decisivo per il movimento sionista, agevolando la pianificazione militare e logistica durante la Prima guerra mondiale e, più tardi, nei processi di espropriazione e insediamento della Nakba del 1947-48[1].
Attraverso l’imposizione di uno sguardo scientifico di matrice occidentale, la cartografia coloniale perpetrò l’eliminazione epistemica delle comunità indigene palestinesi, rappresentando il territorio secondo il paradigma della terra nullius e veicolando l’ideale sionista di «una terra senza popolo per un popolo senza terra» (cfr. Abdo & Yuval-Davis; Sa’di 2023). Perciò, ciò che si presentava come una mera rappresentazione neutrale del territorio si tradusse, di fatto, in un dispositivo di imposizione dell’ordine coloniale sulle relazioni indigene locali. Parallelamente, la cartografia svolse un ruolo cruciale anche nella costruzione dell’identità nazionale, attraverso un processo sistematico di “giudaizzazione” del paesaggio (Falah 1989; Yiftachel 1999). Già nel 1925 fu istituito un comitato incaricato di assegnare nomi ebraici agli insediamenti coloniali, alle infrastrutture e all’immaginario territoriale, attingendo a fonti bibliche, talmudiche e sioniste. Tale operazione fu intensificata con la creazione, nel 1948, della Commissione governativa per i nomi voluta da Ben-Gurion, con l’obiettivo di radicare simbolicamente il popolo ebraico alla terra (Abu El-Haj 2002). La trasformazione coloniale del paesaggio palestinese non si è limitata però a un’operazione di rinominazione toponomastica, ma ha implicato un processo violento di espropriazione e disconnessione della popolazione indigena dalle proprie terre, per fare spazio all’insediamento dei coloni. Emblematica di questa strategia è stata l’estirpazione sistematica degli ulivi – alberi dalle radici profonde e dal lento fruttificare, simbolo storico di sumud [resilienza], radicamento e resistenza palestinese – sostituiti con specie non autoctone, come il pino europeo[2]. Promossa dal Fondo nazionale ebraico, questa riforestazione artificiale mira a ridisegnare il paesaggio secondo un immaginario biblico europeo, funzionale alla narrazione del “ritorno” sionista e alla legittimazione della presenza coloniale (Sasa 2023). La manipolazione ecologica del territorio si configura così come uno strumento politico di cancellazione materiale e simbolica della memoria indigena, parte integrante del processo definito da Masalha (2015) come “memoricidio”. In questo modo, come avviene in altri contesti simili, tali artifici contribuiscono a«rendere naturali le gerarchie costitutive del colonialismo d’insediamento» (Coulthard 2014b, p. 152).
Nell’ambito delle attività di rilevamento cartografico, l’amministrazione britannica promosse anche un’ampia indagine sulle reti di trasporto esistenti nella regione. In questo contesto, le strade preesistenti — molte delle quali risalenti all’epoca romana — furono ripavimentate ed estese durante il mandato britannico, nell’ambito dei programmi denominati “strade di sicurezza” e “strade militari” (ZA 1922). Tali interventi miravano a garantire nodi logistici affidabili per il rifornimento di truppe e merci lungo le arterie strategiche dell’Impero, nonché a facilitare il flusso continuo di risorse umane e materiali tra i territori colonizzati e il centro metropolitano. Questo ci ricorda come, al di là della loro apparente neutralità o funzionalità tecnica, le infrastrutture siano profondamente intrecciate alle storie coloniali di guerra, commercio e carceralità. La nozione di carceralità si fonda su una consolidata letteratura accademica (Gilmore 2002; Milhaud 2017; Moran et al. 2012; Philo 2012; Turner 2016), che definisce la “geografia carceraria” come un’indagine critica degli spazi, delle pratiche e delle esperienze legate alla reclusione e al controllo coercitivo. Tale concetto si estende oltre le forme di detenzione tradizionali, comprendendo regimi lavorativi, ingegneria e vincoli spaziali, restrizioni alla mobilità, nonché il controllo dei corpi e della natura. L’obiettivo di questi dispositivi non è semplicemente punitivo, ma eminentemente disciplinare: essi mirano a esercitare forme di dominio, inscrivendo nello spazio relazioni di potere di matrice coloniale e capitalista.

L’intreccio tra carceralità, ingegneria spaziale, operazioni infrastrutturali e colonialità emerge chiaramente nel processo di colonizzazione della Palestina storica, dove – come in altri territori sotto dominio coloniale – lo sviluppo delle infrastrutture si fondava in larga misura sul lavoro carcerario forzato. A tal proposito, la documentazione conservata negli archivi coloniali, quali l’Archivio di stato di Israele e gli Archivi sionisti, evidenzia come, durante il mandato britannico in Palestina, siano stati istituiti numerosi campi di lavoro a carattere detentivo, destinati prevalentemente all’internamento e sfruttamento di dissidenti politici e oppositori del regime coloniale. Molti dei detenuti erano contadini palestinesi, incarcerati dopo l’occupazione dei loro villaggi, ma tra loro vi erano, seppure in minoranza, anche comunità ebraiche — un dato che ricorda come, prima dell’ascesa del sionismo, ebrei e palestinesi convivevano pacificamente in terra santa (ISA 1934-45; ISA 1936-44). Le fonti d’archivio degli anni venti e trenta mostrano come entrambi i gruppi venissero sottoposti a regimi carcerari simili, e per lo più impiegati in lavori forzati: dallo spaccamento delle pietre in cave vicine alla realizzazione delle infrastrutture, fino alla costruzione degli stessi campi di detenzione (ZA 1922; ISA 1933-38; ISA 1936-39). Il lavoro forzato carcerario rispondeva ad una duplice logica coloniale: da un lato, era uno strumento per ricucire la “geografia imperfetta” dell’impero, fatta di «un tessuto pieno di buchi, cucito insieme da pezzi, un groviglio di fili» (Benton 2010: 2) attraverso lo sviluppo di nodi logistici; dall’altro, aveva una funzione disciplinare, mirata a neutralizzare le energie politiche dei detenuti (ISA 1935-37; ISA 1936-39).
Leggere le infrastrutture come archivi materiali permette di esplorare anche come i cambiamenti geopolitici si riflettessero nella quotidianità delle strutture detentive, modificandone le dinamiche interne. Negli anni trenta, per esempio, la persecuzione antisemita in Europa contribuì ad intensificare il progetto sionista europeo di fondare uno stato ebraico in Palestina, sostenuto dall’impero britannico; al contempo, la Grande rivolta araba contro il mandato britannico (1936–1939) e la dura repressione che ne seguì portarono le autorità coloniali a percepire i palestinesi sempre più come una minaccia all’ordine imperiale. Questi due processi in particolare contribuirono a ridefinire le dinamiche di razzializzazione all’interno delle carceri, influenzando profondamente la gestione dei detenuti e le loro condizioni materiali, con un crescente divario nel trattamento riservato ai prigionieri arabo-palestinesi e a quelli ebrei. Se inizialmente i detenuti venivano impiegati in modo pressoché analogo, dagli anni quaranta emerse una netta differenziazione: ai palestinesi venivano attribuite “propensioni naturali” ai lavori manuali e faticosi, mentre ai detenuti della comunità ebraica venivano assegnati compiti di supporto agli ufficiali britannici, come la distribuzione dei pasti o la pulizia degli ambienti (ISA 1936-44; ISA 1942-47). Anche nell’assegnazione dei contratti infrastrutturali si osserva un cambiamento significativo. Mentre nei decenni precedenti si tendeva a bilanciare la ripartizione tra famiglie arabe palestinesi e famiglie ebree per evitare tensioni locali, con l’avvicinarsi agli anni quaranta i contratti più remunerativi iniziarono a essere affidati in prevalenza a imprenditori ebrei, relegando i palestinesi a ruoli di mera manodopera, giustificati ideologicamente attraverso discorsi razziali sulle “abilità naturali” dei corpi (ZA 1922; ISA 1935-37; ISA 1942-47). Il rovesciamento delle dinamiche razziali si consolidò con la Nakba del 1947–48 e la creazione dello stato di Israele, quando i campi di lavoro forzato carcerario vennero progressivamente dismessi e i detenuti ebrei liberati. Le popolazioni palestinesi e arabe, al contrario, furono trasferite in nuove strutture detentive, dove continuarono ad essere incarcerate e costrette a svolgere lavori forzati, ora sotto l’autorità del nuovo apparato statale israeliano (ISA 1947-48). Nelle strutture carcerarie del neonato stato coloniale d’insediamento, le autorità sioniste israeliane sottoponevano i detenuti palestinesi ad atti arbitrari di violenza, spesso ricalcando le pratiche dei funzionari britannici, talvolta con la complicità di civili/coloni provenienti dagli insediamenti limitrofi. Come documentato negli archivi della Croce rossa, una delle poche organizzazioni autorizzate a condurre ispezioni all’interno delle strutture detentive negli anni quaranta, un giovane ex prigioniero racconta: «Adulti e bambini ebrei provenivano dai kibbutz vicini per osservarci mentre eravamo schierati nudi e ridevano. Per noi era la cosa più degradante» (in Abu Sitta 2014: 24).
[1] Il termine al-Nakba (in arabo: “la catastrofe”) indica l’insieme delle operazioni che resero possibile, e successivamente consolidarono, l’espulsione violenta del popolo palestinese dalla propria terra indigena. Tale processo include le operazioni condotte nel 1947 in diverse aree della Palestina storica da milizie paramilitari sioniste — Haganah, Irgun e Lehi, poi confluite nell’esercito israeliano — in stretta collaborazione con le potenze imperiali, in particolare quella britannica. A ciò seguì la cosiddetta “guerra d’indipendenza israeliana” del 1948, che portò alla creazione di uno Stato coloniale d’insediamento sul 78% della Palestina mandataria, alla distruzione di circa 530 villaggi palestinesi, e allo sfollamento forzato di circa 970.000 palestinesi (Abu Sitta 2010). A ciò si aggiungono anche i successivi dispositivi giuridici e politici che hanno consolidato lo status dei coloni come autoctoni/cittadini e quello dei palestinesi come stranieri/rifugiati (Khalidi 1992; Kohen 2000; Zurayq 1956).
[2] Dal 1967, Israele ha distrutto circa 800.000 ulivi palestinesi. Parallelamente, ha introdotto almeno 166 specie arboree nell’intera Palestina storica, tra cui oltre 50 risultano oggi invasive o ecologicamente dannose quando piantate al di fuori del loro habitat originario (EPPO 2025). Tra queste si annoverano il pino, l’eucalipto e la prosopis, specie note per la loro elevata infiammabilità e per il rischio ambientale che comportano, come dimostrato, ad esempio, dall’incendio divampato nei pressi di Gerusalemme nell’aprile 2025.
Bibliografia
Abdo, Nahla & Nira Yuval-Davis
(1995) Palestine, Israel and the Zionist Settler Project in Nira Yuval-Davis & Daiva S. Stasiulis (eds.), Unsettling Settler Societies: Articulations of Gender, Race, Ethnicity and Class, Sage, London.
Abu El-Haj, Nadia
(2002) Producing (Arti)Facts: Archaeology and Power during the British Mandate of Palestine, «Israel Studies» 7(2): 33-61.
Abu Sitta, Salman H.
(2010) The Atlas of Palestine 1917-1966, Palestine Land Society, London.
Abu Sitta, Salman H.
(2014) The ICRC and the Detention of Palestinian Civilians in Israel’s 1948 POW/Labour Camps, «Journal of Palestine Studies» 43(4): 11-38.
Benton, Lauren
(2010) A Search for Sovereignty: Law and Geography in European Empires 1400-1900, Cambridge University Press, Cambridge.
Bowker, Geoffrey
(1994) Information Mythology and Infrastructure in Lisa Bud-Frierman (ed.), Information Acumen: The Understanding and Use of Knowledge in Modern Business, Taylor and Francis.
Brown, John
(2015) Next Head of ‘Civil Administration’ Said Palestinians are Sub-human, «+972 Magazine»: https://www.972mag.com/next-head-of-civil-administration-said-palestinians-are-sub-human/ (ultimo accesso 15 giugno 2025).
Coulthard, Glen
(2014a) From Wards to the State to Subjects of Recognition? Marx, Indigenous Peoples, and the Politics of Dispossession in Denendeh in Audra Simpson & Andrea Smith (eds.), Theorising Native Studies. Durham, Duke University Press.
Coulthard, Glen
(2014b) Red Skin, White Masks: Rejecting the Colonial Politics of Recognition, University of Minnesota Press.
Cowen, Deborah
(2017) Infrastructures of Empire and Resistance, «Verso Blog Post»: https://www.versobooks.com/blogs/news/3067-infrastructures-of-empire-and-resistance?srsltid=AfmBOopLkCMUVbCl8QZz3zCo5FHWDB1l2cVdk1nWz_tHi1XYumhJNp_6 (ultimo accesso 15 giugno 2025).
EPPO
(2025) EPPO Global Database. European and Mediterrean Plant Protection Organisation (EPPO):
https://gd.eppo.int (ultimo accesso 15 giugno 2025).
Falah, Ghazi
(1989) Israeli ‘Judaization’ in Galilee and its Impact on Local Arab Urbanisation, «Political Geography Quarterly», 8(3): 229-253.
Gavish, Dov
(2005) The Survey of Palestine Under the British Mandate, 1920-1948, Routledge, London.
Gavish, Dov & Ruth Kark
(1993) The Cadastral Mapping of Palestine, 1858-1928, «Geographical Journal», 159(1): 70-80.
Gilmore, Ruth Wilson
(2002) Fatal Couplings of Power and Difference: Notes on Racism and Geography, «The Professional Geographer», 54(1): 15–24.
Hetherington, Kregg
(2016) Surveying the Future Perfect: Anthropology, Development and the Promise of Infrastructure in Penelope Harvey, Casper Bruun Jensen & Atsuro Morita (eds.), Infrastructures and Social Complexity: A Companion, Routledge, London.
Hope-Simpson, John
(1930) Palestine: Statement of Policy by His Majesty’s Government in the UK. United Nation, The Question of Palestine: https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-205977/ (ultimo accesso 15 giugno 2025).
ISA (1933-38) Road from Karkur Through Wadi Ara, Musmus Pass and Lajjun to Afula, Israel State Archive, British Mandate. Files 4180/10-17.
ISA (1934-45) Jail Labour Camp No. 1 Nur esh Shams, Israel State Archive, Palestine Government 349/9.
ISA (1935-37) Jail Labour Camp No. 1 Nur esh Shams – Roads, Israel State Archive, Palestine Government 16652/10.
ISA (1936-39) Jail Labour Camp No. 2 Athlit – Quarries, Israel State Archive, Palestine Government 16605/5.
ISA (1936-44) Jail Labour Camp No. 2 Athlit – Conditions, Israel State Archive, Palestine Government 1341/19.
ISA (1942-47) Road from Karkur Through Wadi Ara, Musmus Pass and Lajjun to Afula, Israel State Archive, British Mandate. Files 4108/11-17.
ISA (1947-48). Jail Labour Camp No. 2 Athlit, Israel State Archive, Palestine Government 4102/6.
Kain, Roger J. P. & Elizabeth Baigent
(1992) The Cadastral Map in the Service of the State, University of Chicago Press, Chicago.
Khalidi, Walid
(1992) All that Remains. The Palestinian Villages Occupied and Depopulated by Israel in 1948, Institute of Palestine Studies, Washington DC.
Kattoura, Nicki
(2024) A Thousand Eulogies Are Exported to the Comma’. Of Syntax and Genocide:
https://lithub.com/a-thousand-eulogies-are-exported-to-the-comma-of-syntax-and-genocide/ (ultimo accesso 15 giugno 2025).
Kohen, Hillel
(2000) The Present Absentee: Palestinian Refugees in Israel Since 1948. Jerusalem: The Van Leer Jerusalem Institute. Jerusalem: Israel State Archives. Files 17027/3.
Larkin, Brian
(2008) Signal and Noise Media, Infrastructures and Urban Culture in Nigeria. Durham, Duke University Press.
Marx, Karl
(1990[1867]) Capital, Volume I. Penguin, New York.
Masalha, Nur
(2015). Settler Colonialism, Memoricide and Indigenous Toponymic Memory: The Appropriation of Palestinian Place Names by the Israeli State, «Journal of Holy Land and Palestine Studies» 14(1): 3-57.
Milhaud, Olivier
(2017) Séparer et Punir: Une Géographie des Prisons Françaises,CNRS, Paris.
Moran, Dominique, Laura Piacentini & Judith Pallot
(2012) Disciplined Mobility and Carceral Geography: Prisoner Transport in Russia, «Transactions of the Institute of British Geographers» 37(3): 446–460.
Okoth-Ogenda, H. W. O.
(2008) The Nature of Land Rights Under Indigenous Law in Africa in Aninka Claassens & Ben Cousins (eds.). Land, Power, and Custom: Controversies Generated by South Africa’s Communal Lands Rights Acts, UCT Press, Cape Town.
Philo, Christopher
(2001) Accumulating Populations: Bodies, Institutions and Space in Special Issue: (Re)theorising Population Geography. Edited by Elspeth Graham and Paul Boyle, «International Journal of Population Geography» 7: 473–490.
Quiquivix, Linda
(2013) When the Carob Tree Was the Border: On Autonomy and Palestinian Practices of Figuring Out, «Capitalism Nature Socialism» 24(3): 170-189.
Sa’di, Ahmad H.
(2023) Towards a Decolonisation of Palestine Studies in Ahmad H. Sa’di & Nur Masalha (eds.), Decolonising Study of Palestine: Indigenous Perspectives and Settler Colonialism after Elia Zureik, Bloomsbury Publishing, London.
Salamanca, Omar Jabary, Punam Khosla & Natasha Aruri
(2024) It’s Been 164 Days and a Long Century: Notes on Genocide, Solidarity and Literation: https://antipodeonline.org/2024/04/11/notes-on-genocide-solidarity-and-liberation/ (ultimo accesso 15 giugno 2025).
Sasa, Ghada
(2023) Oppressive Pines: Uprooting Israeli Green Colonialism and Implanting Palestinian A’wna, «Politics» 43(2): 219-235.
Turner, Jennifer
(2016) The Prison Boundary: Between Society and Carceral Space, Palgrave Macmillan, London.
Yiftachel, Oren
(1999) Ethnocracy’: The Politics of Judaizing Israel/Palestine, «Constellations» 6(3): 364-390.
ZA (1922) Roman Roads – Wadi Arah, Zionist Archive.
Zurayq, Constantine
(1956) The Meaning of Disaster, Khayat, Beirut.