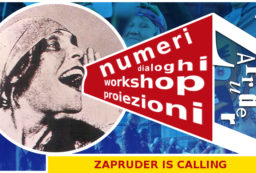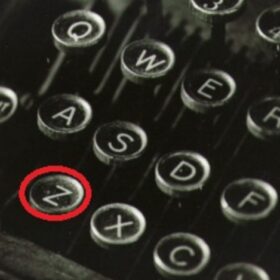Il nuovo numero di «Zapruder», “Anime in pena” (guarda l’indice qui), vuole analizzare in che modo e secondo quali traiettorie i soggetti sottoposti a determinati trattamenti disciplinari, la comunità civile e i movimenti sociali abbiano contribuito alla sopravvivenza, alla riforma, al superamento o all’abolizione dei differenti regimi e dispositivi di pena, coercizione o correzione.
Poiché ci occupiamo di storia e storie, ma viviamo anche noi qui e ora, per accompagnare l’uscita di questo numero pubblichiamo – in tre puntate – un contributo di I.B. che analizza l’intreccio tra carceralità, ingegneria degli spazi, operazioni infrastrutturali e colonialità nell’oppressione del popolo palestinese per mostrare come le infrastrutture abbiano costituito un pilastro fondamentale nella realizzazione e nel consolidamento del progetto europeo sionista in Palestina.
«Come si scrive mentre è in corso un genocidio?»
Infrastruttura della colonizzazione, infrastruttura della resistenza
(parte seconda | la prima parte la puoi leggere qui | la terza qui)
I.B.
Le infrastrutture svolgono un ruolo centrale nei processi di colonizzazione d’insediamento, operando non solo come strumenti materiali di connessione e organizzazione dello spazio, ma anche come dispositivi politici e simbolici che plasmano rapporti di potere, territori e soggettività. Lungi dall’essere elementi neutri o puramente tecnici, esse incarnano e riproducono le logiche coloniali, radicando nella materialità dei luoghi regimi di controllo e gerarchie di accesso alle risorse. In Palestina, la costruzione infrastrutturale è stata parte integrante di un più ampio progetto di ingegneria territoriale e demografica, che mira a consolidare la sovranità coloniale israeliana attraverso pratiche di appropriazione, dislocazione forzata e frammentazione spaziale. L’intreccio tra carceralità, ingegneria spaziale, operazioni infrastrutturali e colonialità è reso evidente dalle modalità con cui lo spazio palestinese viene organizzato, governato e disciplinato, tanto nei suoi aspetti più visibili – come strade, muri e reti idriche – quanto in quelli più invisibili, quali i regimi legali e burocratici che ne definiscono l’uso. Tali dinamiche non riguardano unicamente la gestione tecnica del territorio, ma si configurano come pratiche di dominio che inscrivono nello spazio relazioni di potere razzializzate e strutturalmente violente. È in questo quadro che si inserisce la seguente analisi della matrice di dominazione spaziale in Palestina, volta a mostrare come le infrastrutture abbiano costituito un pilastro fondamentale nella realizzazione e nel consolidamento del progetto europeo sionista in Palestina.
La Matrice della Dominazione Spaziale
Nei tre decenni successivi all’insediamento statale, il progetto israeliano ha perseguito un regime di dominio spaziale orientato alla realizzazione di obiettivi politici e ideologici di natura territoriale e demografica. Questo processo si è articolato attraverso l’adattamento e la strumentalizzazione di dispositivi giuridici ereditati dall’impero ottomano e dal mandato britannico, in particolare in ambito fondiario e urbanistico, con l’intento di nazionalizzare i diritti d’uso e accesso alla terra (Erakat 2015). Tali strumenti normativi hanno consentito allo stato israeliano di consolidare la proprietà pubblica sulle terre indigene palestinesi, inscrivendo l’appropriazione coloniale all’interno di un paradigma di sviluppo capitalistico. Parallelamente, si è intensificato il trasferimento di terre indigene a istituzioni sioniste come il Fondo nazionale ebraico, l’Agenzia ebraica, e l’Organizzazione sionista mondiale, le quali, in sinergia con le strutture statali, hanno promosso un’aggressiva politica di colonizzazione delle aree periferiche e dei territori a maggioranza palestinese (cfr. Khalidi 1992; Masalha 2007). Questa strategia, definita nella letteratura come “ingegneria demografica” (McGarry 1998), è stata funzionale a rafforzare la presenza ebraico-israeliana e, contestualmente, a frammentare e contenere le forme di continuità territoriale, politica e culturale palestinese. In tale cornice, le infrastrutture hanno assunto un ruolo cruciale nella materializzazione delle aspirazioni ideologiche e cartografiche del sionismo. Benché spesso percepite come elementi tecnici o neutri, strade, acquedotti, reti elettriche, foreste pianificate, sistemi di confine e apparati burocratici si configurano come strumenti centrali all’organizzazione della vita quotidiana palestinese. La loro funzione non è puramente logistica, bensì eminentemente politica ed economica: attraverso le infrastrutture si facilita l’acquisizione di terre, si promuove una dipendenza strutturale dell’economia palestinese e si istituiscono regimi di controllo differenziale, ossia sistemi gerarchici di accesso, mobilità e distribuzione delle risorse che contribuiscono alla costruzione di un ordine sociale razzializzato (cfr. Alatout 2006; Stamatopoulou‑Robbins 2020; Zeitoun 2008). In definitiva, l’infrastruttura emerge non come sfondo, ma come architettura centrale della progettualità coloniale israeliana.
Questa logica è stata ulteriormente rafforzata dai tanto celebrati Accordi di Oslo (1993) e dal Protocollo Economico di Parigi (1994), che hanno formalizzano il sistema di controllo infrastrutturale ed economico israeliano (Turner & Shweiki 2014). Attraverso tali accordi, Israele ha consolidato il proprio monopolio sulle principali infrastrutture di confine, mantenendo il controllo esclusivo su tutti i varchi d’ingresso e uscita e garantendosi l’autorità sulle dinamiche commerciali palestinesi, in particolare in materia di importazioni ed esportazioni, comprese merci essenziali come dispositivi medici, materiali edili e impianti di depurazione (Khalili 2019). Un ulteriore livello di controllo riguarda le risorse vitali, come l’acqua, il cui accesso è monopolizzato dalla compagnia idrica nazionale israeliana Mekorot, che gestisce e ridistribuisce le risorse idriche palestinesi deviandole in maniera sistematica verso gli insediamenti coloniali (Dajani 2017). Inoltre, nei territori occupati del ’67 (Striscia di Gaza e Cisgiordania) ai palestinesi è sistematicamente negato l’accesso a tecnologie mobili avanzate come il 4G e il 5G, a differenza dei coloni israeliani che godono di connessioni ad alta velocità. A ciò si aggiunge la distruzione sistematica del settore delle telecomunicazioni nella Striscia di Gaza da parte di Israele (Hurani 2025; Tawil-Souri 2021). Tali pratiche non solo rafforzano la dipendenza economica palestinese, ma amplificano anche le capacità di sorveglianza dello stato israeliano, che continua ad utilizzare la Palestina sia come terreno di sperimentazione per nuove tecnologie militari sia come centro di esportazione di tattiche di contro-insurrezione (Khalili 2013).
Parallelamente, la continuità spaziale e sociopolitica palestinese è stata frammentata in una serie di enclavi territoriali disconnesse. La stessa Striscia di Gaza, va ricordato, costituisce una costruzione coloniale israeliana, la cui separazione territoriale rappresenta una diretta conseguenza della pulizia etnica del 1948. In tale contesto, un territorio originariamente esteso per circa 28.000 chilometri quadrati venne progressivamente ridotto a soli 365 chilometri quadrati, mentre la popolazione residente triplicò. I profughi provenivano da Bir al-Sabe’, al-Ramleh, Yaffa, al-Quds, al-Khalil, nonché da villaggi e terre tribali circostanti, dove Israele ha successivamente insediato una serie di colonie, tra cui Sderot, Kfar Azza, Kisufim, Be’eri, Erez e Nahal Oz (Issa 2023). A partire dai primi anni Novanta, Gaza è stata sottoposta a crescenti restrizioni alla libertà di movimento imposte da Israele, culminate nel 2007 con un embargo totale che ha progressivamente paralizzato l’economia locale, rendendo l’intera popolazione dipendente dagli aiuti esterni (Pappé 2017). Analogamente, anche in Cisgiordania ai palestinesi è stato imposto un regime di controllo poliziesco fondato su un articolato sistema di permessi e restrizioni alla mobilità[1]. Questo dispositivo è culminato nella costruzione del “muro dell’apartheid” che, oltre a violare il diritto internazionale, non segue nemmeno il tracciato della Green Line stabilita dall’armistizio del 1949, consolidando di fatto l’annessione unilaterale di ampie porzioni dei territori palestinesi occupati (Kotef 2015). A ciò si aggiungono circa 700.000 coloni insediati in Cisgiordania, oltre il muro di separazione, distribuiti in circa 150 insediamenti ufficiali e 128 avamposti; le infrastrutture che li collegano bypassano e risultano inaccessibili alla comunità palestinese, la quale invece è sottoposta a checkpoint e chiusure che rendono anche brevi spostamenti lunghi, imprevedibili, e a volte fatali (Falah & Al-Nawaiseh 2024). Pur avendo come prerogativa l’occupazione della terra indigena e il genocidio della sua popolazione per la creazione di una nuova società coloniale, l’impossibilità di eliminare completamente i palestinesi fa sì che sotto il colonialismo d’insediamento essi vengano integrati nel sistema di capitalismo razziale israeliano come sottoproletariato. Il regime carcerario israeliano regola strettamente la mobilità quotidiana dei lavoratori palestinesi, i quali sono costretti ogni giorno a varcare il confine per accedere ai “Territori del ‘48”/Israele[2]; limitati dalla durata delle ore lavorative, essi devono spesso attendere assembrati nei valichi di confine in un sistema di tunnel e “gabbie”, per essere impiegati per poche ore in condizioni di caporalato, principalmente nei settori agricolo e edilizio (Farsakh 2002). A questa situazione si aggiunge poi la condizione della diaspora palestinese, che conta oggi oltre sei milioni di persone, e dei circa 1,5 milioni di palestinesi ancora residenti nei campi profughi gestiti dall’Unrwa in Giordania, Libano e Siria, a testimonianza della persistenza dell’esilio forzato e dell’assenza del diritto al ritorno, diritto invece garantito alla comunità ebraico-israeliana (Badil 2022).

Per completare il quadro, è fondamentale includere anche la situazione dei cosiddetti “Palestinesi del ’48” – ovvero coloro che, pur essendo rimasti all’interno dei confini dello stato di Israele dopo la Nakba, vivono oggi come “cittadini israeliani”. Nonostante la cittadinanza formale, tali comunità sono sistematicamente sottoposte a forme strutturali di discriminazione, sia sul piano giuridico sia su quello socio-economico, che ne determinano una condizione persistente di subalternità rispetto alla popolazione ebraico-israeliana. Dal punto di vista sociale, i palestinesi del ‘48 sono oggetto di profonde disuguaglianze: il sistema scolastico è segregato, con programmi che omettono o negano la storia palestinese; gli investimenti pubblici nelle loro comunità sono significativamente inferiori rispetto a quelli destinati alle aree ebraiche-israeliane; si verificano frequenti espropri di terre, mentre l’accesso a risorse essenziali, come acqua ed elettricità, risulta spesso limitato (Plonski 2017; Robinson 2013). Anche la rappresentanza politica è soggetta a restrizioni dirette e indirette. Basti pensare che più di 65 leggi israeliane discriminano i palestinesi, sia all’interno dello stato che nei territori occupati. Particolarmente significativa è la legge sullo “stato-nazione” del 2018, che sancisce il carattere esclusivamente ebraico dello stato, negando di fatto il riconoscimento dell’identità palestinese (Ben-Youssef & Tamari 2018). A questo si aggiungono provvedimenti legislativi approvati nel novembre 2024, che autorizzano la revoca della cittadinanza e la deportazione di cittadini palestinesi-israeliani accusati – o i cui familiari siano accusati – di “terrorismo”, termine spesso definito in maniera vaga e arbitraria (Addameer 2024). Le nuove disposizioni consentono inoltre la detenzione di minori palestinesi al di sotto dei 14 anni in carceri per adulti. Ciononostante, durante l’“insurrezione dell’unità” del 2021 – un momento di mobilitazione collettiva che ha coinvolto Gaza, la Cisgiordania, Gerusalemme Est e le comunità palestinesi all’interno di Israele – i palestinesi del ’48 hanno sfidato la frammentazione imposta, riaffermando la propria appartenenza ad un popolo coeso che lotta unito per la liberazione (Hawari 2021). La risposta dello stato israeliano è stata caratterizzata da una repressione sistematica: leader comunitari sono stati perseguiti penalmente o cooptati dai servizi di sicurezza, mentre la polizia è stata ripetutamente accusata di negligenza, o addirittura di complicità, nel favorire l’espansione della criminalità organizzata nei quartieri palestinesi, contribuendo a un drammatico aumento del numero di omicidi negli ultimi anni. Tale contesto ci ricorda che, al di là delle narrazioni liberali incentrate su principi quali “integrazione”, “partecipazione” e “riconoscimento” all’interno delle strutture dello stato coloniale d’insediamento, l’unica prospettiva per una pace duratura risiede in un processo fondato sull’auto-riconoscimento, la giustizia e la decolonizzazione (cfr. Coulthard 2014; Simpson 2017). Ciò implica, tra le fondamentali rivendicazioni, lo smantellamento del regime coloniale d’insediamento, la redistribuzione delle terre, l’affermazione della sovranità secondo i parametri stabiliti dalle stesse comunità indigene palestinesi, e l’attuazione di forme concrete di riparazione storica – inclusi il diritto al ritorno dei rifugiati palestinesi e il riconoscimento delle rivendicazioni della diaspora.
In definitiva, l’attuale accelerazione del colonialismo d’insediamento in Palestina ci ricorda che la violenza capitalista non si fonda esclusivamente su un momento di “accumulazione originaria”, ma si manifesta anche attraverso processi continui di espansione e appropriazione. Essa mira a concretizzare l’aspirazione ad una sovranità coloniale assoluta, che si impone e si sovrappone alla molteplicità di forme e sistemi di sovranità indigena, tramite la predazione costante di nuove frontiere, spazi esterni e scale territoriali. Considerata la natura intrinsecamente “incompiuta” e “imperfetta” del colonialismo d’insediamento, tali sforzi vanno letti come meccanismi continui volti a ridefinire e rendere tangibile la dominazione, instillando un senso di inevitabilità, permanenza e immutabilità alle relazioni predatorie di stampo coloniale (cfr. Blatman-Thomas & Porter 2019; Pasternak 2014).
[1] Bisogna ricordare, inoltre, che a seguito degli Accordi di Oslo, la Cisgiordania è stata suddivisa in tre aree amministrative (A, B e C). L’area A, sotto pieno controllo dell’Autorità Palestinese (AP), copre circa il 18% della Cisgiordania. L’area B, caratterizzata da controllo civile palestinese ma da un controllo congiunto israeliano-palestinese in ambito di sicurezza, rappresenta circa il 22%. L’area C, invece, è interamente sotto controllo israeliano e comprende il restante 60%, inclusi gli insediamenti israeliani e la maggior parte delle terre fertili della Cisgiordania. Israele continua a negare ai Palestinesi l’accesso al 99% delle terre dell’area C, comprese le loro proprietà agricole e private.
[2] Se, come illustrato in precedenza, le pratiche coloniali di rinominazione rientrano in un più ampio processo di cancellazione dei legami che le popolazioni indigene intrattengono con la terra e tra di loro — inscrivendo al contempo la presenza coloniale nello spazio come naturale e inevitabile — allora il recupero o la preservazione dei toponimi indigeni assume un significato politicamente rilevante, configurandosi come atto di resistenza e di rinascita. Tale gesto si inserisce quindi nei processi di decolonizzazione del sapere e di riattivazione delle epistemologie indigene. In questo quadro, il termine “Israele” risulta contestato e, nelle nomenclature indigene e decoloniali, il territorio corrispondente viene spesso indicato come “Palestina del ’48”, una definizione che richiama esplicitamente la pulizia etnica compiuta durante la Nakba e ne valorizza la memoria storica dal punto di vista delle popolazioni indigene. I discendenti dei palestinesi che rimasero nei territori occupati dopo il 1948 — o che furono sfollati internamente ma non espulsi e che acquisirono la cittadinanza israeliana — rivendicano oggi la propria esistenza come “Palestinesi del ’48”, riaffermando così un’esperienza indigena che precede e oltrepassa la costituzione dello stato coloniale di insediamento. Questa rivendicazione mette in discussione le narrazioni liberali che li descrivono come una semplice “minoranza” all’interno dello Stato. In questo quadro, la Cisgiordania e la Striscia di Gaza sono comunemente designate come “Territori Occupati del ’67”, in riferimento all’occupazione militare israeliana avvenuta a seguito della guerra dei Sei giorni del 1967.
Bibliografia
Alatout, Samer
(2006) Towards a Bio-Territorial Conception of Power: Territory, Population, and Environmental Narratives in Palestine and Israel, «Political Geography» 25(6): 601-621.
Al-Jazeera
(2023) Hamas Had Not Planned to Attack Music Festival Israeli Report Says, «Al-Jazeera»:
https://www.aljazeera.com/news/2023/11/18/hamas-had-not-planned-to-attack-israel-music-festival-israeli-report-says (ultimo accesso 15 giugno 2025).
Badil
(2022) Survey of Palestinian Refugees and Internally Displaced Persons 2019-2021 Volume X, BADIL: Resource Centre for Palestinian Residency and Refugee Rights: https://badil.org/cached_uploads/view/2022/10/31/survey2021-eng-1667209836.pdf (ultimo accesso 15 giugno 2025).
Ben-Youssef, Nadia & Sandra Samaan Tamari
(2018) Enshrining Discrimination: Israel’s Nation-State Law, «Journal of Palestine Studies» 48(1): 73-87.
Blatman-Thomas, Naama & Libby Porter
(2019) Placing Property: Theorising the Urban from Settler Colonial Cities, «International Journal of Urban and Regional Research», 43(1): 30-45.
Coulthard, Glen
(2014) Red Skin, White Masks: Rejecting the Colonial Politics of Recognition, University of Minnesota Press, Minneapolis.
Dajani, Muna
(2017) The ‘Apolitical’ Approach to Palestine’s Water Crisis, Al-Shabaka: https://al-shabaka.org/briefs/the-apolitical-approach-to-palestines-water-crisis/ (ultimo accesso 15 giugno 2025).
Erakat, Noura
(2015) Whiteness as Property in Israel: Revival, Rehabilitation, and Removal, «Harvard Journal on Racial and Ethnic Justice» 1-31.
Falah, Ghazi-Walid & Samer Al-Nawaiseh
(2024) The Geopolitics of Israel’s ‘Seam Zone’ in the West Bank of Palestine, «The Arab World Geographer» 27(1): 1-20.
Farsakh, Leila
(2002) Palestinian Labour Flows to the Israeli Economy: A finished Story?, «Journal of Palestine Studies» 32(1): 13-27.
Hawari, Yara
(2021) Defying Fragmentation and the Significance of Unity: A New Palestinian Uprisin, Al-Shabaka: https://al-shabaka.org/commentaries/defying-fragmentation-and-the-significance-of-unity-a-new-palestinian-uprising/ (ultimo accesso 15 giugno 2025).
Hurani, Raheeq
(2025) The Destruction of Gaza’s Telecommunications Infrastructure and the Eroded Internet Accessibility, Palestine Economic Policy Research Institute (MAS): https://mas.ps/en/publications/12403.html (ultimo accesso 15 giugno 2025).
Issa, Perla
(2023) Real Names of Stolen Villages, Illegal Settlements of the Gaza Perimeter, Institute for Palestine Studies: https://www.palestine-studies.org/en/node/1654492 (ultimo accesso 15 giugno 2025).
Khalidi, Walid
(1992) All that Remains. The Palestinian Villages Occupied and Depopulated by Israel in 1948, Institute of Palestine Studies, Washington DC.
Khalili, Laleh
(2021) Sinews of War and Trade: Shipping and Capitalism in the Arabian Peninsula, Verso Books, London.
Khalili, Raja
(2019) The Structural Transformation of the Palestinian Economy after Oslo in Mandy Turner (ed.), From the River to the Sea: Palestine and Israel in the Shadow of “Peace”, Bloomsbury, London.
Kotef, Hagar
(2015) Movement and the Ordering of Freedom: On Liberal Governances of Mobility, Duke University Press, Durham & London.
Masalha, Nur
(2007) The Bible and Zionism: Invented Traditions, Archeology and Post-colonialism in Palestine-Israel. Vol. 1, Zed Books, London.
McGarry, John
(1998) Demographic Engineering’: The State-Directed Movement of Ethnic Groups as a Technique of Conflict Regulation, «Ethnic and Racial Studies» 21(4): 613-638.
Pappé, Ilan
(2017) The Biggest Prison on Earth: A History of Gaza and the Occupied Territories, Simon & Schuster, London.
Pasternak, Shiri
(2014) Jurisdiction and Settler Colonialism: Where do Laws Meet?, «Canadian Journal of Law and Society» 29(2): 145-161.
Plonski, Sharri
(2017) Palestinian Citizens of Israel: Power, Resistance and the Struggle for Space, Bloomsbury, London.
Robinson, Shira N.
(2013) Citizen Strangers: Palestinians and the Birth of Israel’s Liberal Settler State”, Stanford University Press, Stanford, CA.
Simpson, Leanne Betasamosake
(2017) As We Have Always Done. Indigenous Freedom Through Radical Resistance, University of Minnesota Press, Minneapolis, MN.
Stamatopoulou‑Robbins, Sophia
(2020) Waste Siege: The Life of Infrastructure in Palestine, Stanford University Press, California.
Tawil-Souri, Helga
(2012) Digital Occupation: Gaza’s High-tech Enclosure, «Journal of Palestine Studies» 41(2): 27-43.
Turner, Mandy & Omar Shweiki
(2014) Decolonising Palestinian Political Economy: De-development and Beyond, Springer, London & New York.
Zeitoun, Mark
(2008) Power and Water in the Middle East: The Hidden Politics of the Palestinian-Israeli Water Conflict, IB Tauris, London.