Come avrete appreso dalle pagine dei giornali, Luca Rastello ci ha lasciati/e lunedì 6 luglio. Per noi si tratta di un vuoto difficile da colmare. Vogliamo rendere omaggio a questo straordinario compagno rileggendo insieme un’intervista pubblicata su «Zapruder» (n. 20) del 2009, a tre anni dalla pubblicazione del suo romanzo Piove all’insù.
Ma l’amor mio non muore

Il Settantasette, roba da fantascienza. Intervista sul romanzo Piove all’insù (di Luca Rastello e Marco Revelli, a cura di Marco Scavino).
Luca Rastello è nato nel 1961, vive a Torino e fa il giornalista. Oltre a lavorare per «la Repubblica», ha collaborato con «Diario» come inviato in diversi paesi dell’ex-Jugoslavia, dell’Asia centrale, dell’Africa e dell’America latina. È stato direttore di «Narcomafie» e de «L’Indice», e attualmente dirige la testata on line «Osservatorio Balcani». Nel 1998 ha pubblicato per Einaudi il volume La guerra in casa, sui conflitti nella ex-Jugoslavia, e quest’anno – per Chiarelettere – Io sono il mercato, un’inchiesta sul rapporto tra il commercio illegale degli stupefacenti e l’economia mondiale. Piove all’insù (Bollati Boringhieri, 2006) è stato il suo primo romanzo. È ambientato a Torino ed è scritto in prima persona; il protagonista (di cui solo verso la fine si conoscerà il nome: Pietro Miasco) scrive a un’amica, forse la sua compagna, dopo che quest’ultima è stata licenziata dall’azienda in cui lavorava, e inizia a raccontarle brani della sua infanzia e della sua adolescenza, tra la metà degli anni sessanta e la fine degli anni settanta, ricostruendo poco a poco (e con continui salti nel tempo) un quadro in cui si intrecciano i primi ricordi infantili, i rapporti con i genitori (in particolare con il padre, un militare coinvolto in qualche modo nella “strategia della tensione”, ma che se ne ritrae indignato e ne denuncia le trame ai superiori), la scuola e le vacanze estive, la passione per la fantascienza e le letture di «Urania», la curiosità adolescenziale per l’universo femminile e i relativi turbamenti ormonali, e infine l’ingresso – quasi uno scivolamento esistenziale – nei collettivi studenteschi e nei circoli del proletariato giovanile, quindi nel “movimento” del Settantasette, raccontato “dall’interno” (ma in modo originale, nient’affatto retorico o “militante”) in tutta la sua parabola sino alla fine del decennio, alla sconfitta e alla dissoluzione nella lotta armata, nell’eroina, oppure nel ritorno all’egoismo proprietario e affettivo, alla carriera, a qualsiasi cosa potesse riempire il vuoto lasciato dal sogno – svanito – di cambiare radicalmente il mondo. La chiacchierata con l’autore, alla quale ha preso parte anche Marco Revelli, è avvenuta lunedì 25 maggio 2009 al Centro studi Piero Gobetti di Torino.
Piove all’insù è un romanzo, ma da molti è stato letto invece come un libro di memoria, se non proprio di storia. Mi sembra importante, quindi, capire prima di tutto come è stato costruito e quali erano i tuoi obiettivi quando l’hai scritto. C’è una componente autobiografica? È una fusione di ricordi personali e di memoria collettiva? Hai fatto delle ricerche? In che rapporto stanno, nel racconto, la fantasia e la realtà, così – almeno – come tu l’hai vissuta in quegli anni?
LR. Be’, il libro è nato in maniera strana, mettendo insieme cose diverse. All’inizio non avevo in mente un romanzo, ma un’inchiesta sul golpe Borghese, perché mi ero fatto la convinzione, leggendo dei libri e rielaborando degli elementi di memoria, che la tesi ufficiale su quei fatti (quella per cui i responsabili erano un pugno di fanatici e sradicati, al comando di un personaggio un po’ da operetta come il “principe nero”) non fosse plausibile, ma che tutto l’esercito italiano in qualche modo doveva esservi coinvolto. Per cui volevo approfondire la cosa e mi sono messo alla ricerca di quello che era disponibile, a partire dagli atti della Commissione parlamentare sulle stragi. Senonchè, mentre procedevo a quel lavoro, mi tornavano alla mente delle cose, dei pezzi di memoria personale che avevano a che fare con quello che stavo cercando di ricostruire. Cose strane, che riguardavano la mia famiglia, mio padre e il suo lavoro nell’esercito (per un certo periodo era stato aggregato all’arma dei carabinieri); mi ricordavo ad esempio una vacanza in Jugoslavia, alla fine degli anni sessanta, durante la quale ci eravamo spinti sino ai confini con l’Albania (che non era una scelta qualsiasi, per la famiglia di un ufficiale); oppure mi ricordavo di come mio padre, in maniera molto misteriosa, alla vigilia di quel famoso 8 dicembre del 1970 si fosse raccomandato con una mia cugina di 16 anni, militante dell’estrema sinistra, perché non uscisse di casa. Mio padre non c’era più, non potevo chiedergli spiegazioni, ma – dato che la mia famiglia è fatta di militari, da generazioni e generazioni – ho chiesto ad altri parenti, in particolare a uno zio che aveva lavorato a Verona con il colonnello Amos Spiazzi, ed è venuto fuori che, in effetti, per quella notte dell’Immacolata c’erano degli ordini di mobilitazione generale dell’esercito, ad esempio i reparti di stanza sul confine orientale dovevano spostarsi a Sesto San Giovanni. Insomma, anche se a piccoli pezzi, veniva fuori un po’ tutto il quadro della strategia della tensione, che si incastrava con i miei ricordi dell’epoca, con la memoria dei movimenti di quegli anni. Parallelamente, però, è successa una cosa che mi ha portato su una strada diversa. In quel periodo (siamo nel 2002) una persona che mi sta molto a cuore aveva perso il lavoro, era stata licenziata, e si trovava in una situazione difficile, di smarrimento – si potrebbe dire – della propria identità sociale. E quindi capitava che, parlandone insieme, ci ponessimo delle domande che ci riportavano al passato, agli anni settanta, a come eravamo allora e a quello che era successo dopo, a noi e a tanti nostri amici e compagni. Ci chiedevamo: «ma come siamo diventati così?», «perché accettiamo e subiamo delle cose per cui un tempo ci saremmo ribellati?». E da lì sono venuti fuori ricordi, impressioni, una sorta di colata lavica della memoria. A quel punto ho deciso che volevo fare un lavoro diverso, provando a intrecciare tutti questi elementi. Ho preso sei mesi di permesso per paternità (sono stato il primo a chiederlo, a «la Repubblica») e mi sono messo a rielaborare tutto quello che avevo in mente. Un po’ ho fatto riferimento a fatti e a persone reali (cambiando i nomi; ci sono solo due compagni, Ciccio e Albertino, tutti e due morti, purtroppo, che nel libro hanno i loro nomi veri), un po’ ho fuso in certi personaggi i caratteri di varie persone (nella figura del padre del protagonista, ad esempio, non c’è solo mio padre, ma ci sono anche degli zii e degli altri militari). E poi mi sono divertito a usare gli «Urania», i racconti di fantascienza (una mia passione), come le famose briciole di Pollicino, per andare indietro nel tempo e ritrovare certe immagini, certi linguaggi dell’epoca, ai quali sono molto legato. Così ne è venuto fuori un libro che in parte è un romanzo (ci sono due storie: quella del padre, a partire dal 1958, quando è all’accademia militare, e quella del figlio), in parte vuole riflettere un percorso collettivo, di “movimento”, e quindi si riferisce a fatti realmente accaduti, alle vicende politiche e sociali di quegli anni, ma anche a episodi e circostanze vere. Chiaramente, però, non è un libro di storia, anche se sono andato a documentarmi su certe cose. E non è neppure un libro autobiografico, anche se perlopiù racconta di fatti che ho vissuto davvero (in particolare, non sono vere – purtroppo – le storie di sesso… ).
Puoi spiegare meglio qual è stato in quel periodo il tuo percorso politico?
LR. Come tanti altri compagni, ho iniziato a interessarmi di politica al liceo, attorno al 1975. Si può dire che facessi parte, genericamente, del “movimento”. L’anno dopo, quando sono nati i circoli del proletariato giovanile, ho iniziato a frequentare il circolo Barabba, che aveva la sede in centro, vicino all’università. Gran parte delle cose raccontate nel libro si riferiscono a quel giro di compagni e quasi tutti i personaggi sono abbastanza chiaramente identificabili, anche se i nomi sono cambiati (anzi, ce n’è uno, quello che ho descritto come “futuro deputato democristiano”, che se l’è presa a morte e mi ha tolto il saluto). Nel ’77, comunque, sono rimasto fuori (non so mica bene perché: forse non davo abbastanza affidamento) dalla svolta militarista che ha coinvolto diversi compagni del Barabba, finiti quasi tutti in Prima linea. E in quel periodo, mentre gli altri andavano verso la lotta armata, ho iniziato a frequentare l’Mls, Movimento lavoratori per il socialismo, che aveva un piccolo gruppo a Torino (è il gruppo marxista-leninista che compare nel libro). Dopo, quando è finita quella stagione politica, sono stato nel Pdup e ci sono rimasto sino alla confluenza nel Pci. Quella era una prospettiva che non condividevo e che non mi interessava (per me il Pci restava quello che nel ’77 ci avrebbe voluto mettere tutti in galera), per cui ho smesso di fare politica.
Uno degli aspetti che mi hanno colpito di più, nel libro, è il fatto che il protagonista, i suoi compagni e le sue compagne sembrino vivere quel periodo, la seconda metà degli anni settanta e in particolare il ’77, con un senso non solo di profonda rottura nei confronti della stagione politica precedente, ma anche di diffidenza, se non addirittura di risentimento, verso i militanti più “vecchi” (quelli del ’68, per intenderci). È un atteggiamento che hai inserito intenzionalmente, nel senso che riflette anche la tua esperienza personale? E secondo te questa può essere una chiave di lettura di quegli anni anche sul piano storico?
LR. In un certo senso sì, credo che allora ci fosse davvero in molti compagni giovani (me compreso) la sensazione di vivere una fase nuova, del tutto diversa da quella del dopo-’68, e al tempo stesso di non avere più dei rapporti forti con chi aveva fatto politica negli anni precedenti. Era come se un solco, una sorta di faglia tettonica ci separasse da quello che si era espresso prima a livello sociale e politico, compresi i gruppi rivoluzionari (che non c’erano più, o si stavano sbandando tutti). Basta considerare la composizione sociale del “movimento del ‘77”, la distanza – di tipo quasi antropologico – che lo separava dalle vecchie forme dell’azione collettiva. E credo ci fosse davvero, più o meno consapevolmente, del risentimento, del tipo “i vecchi ci hanno fregato”: hanno dato il via a tutto ’sto casino, e adesso che i giochi si fanno duri si tirano indietro, scoprono di avere un lavoro e una famiglia, non se la sentono più di rischiare, o addirittura si mettono a farti le prediche perché non sei bravo com’erano loro nel ’68. A pensarci bene, mi viene persino da dire che gli anni settanta non esistono, come periodo storico: c’è la prima metà del decennio, legata agli effetti del ’68, e c’è la seconda metà, dopo il ’76, che è stata tutta un’altra cosa.
MR. A me questo sembra un elemento decisivo. Quando era uscito Piove all’insù avevo detto che lo trovavo il più bel libro sugli anni settanta, ma adesso direi che è qualcosa di più: è forse l’unico libro, che io conosca, che ci dice davvero qualcosa di importante su quel periodo, proprio perché riesce a tematizzare quel senso di rottura, di discontinuità. Luca è riuscito là dove ancora oggi falliscono tanto la storiografia, quanto la memorialistica sulla “stagione dei movimenti”, proprio perché entrambe non riescono a fare i conti sino in fondo con il dato della “faglia”, di cui parlava appunto Luca. Non è un caso, che la seconda metà del decennio continui a restare in un cono d’ombra, dal punto di vista storico: se ne parla molto, persino troppo, in termini di terrorismo, di crisi del sistema politico, eccetera, ma per quanto riguarda la storia dei movimenti il tutto sembra un po’ misterioso, inspiegabile. Piove all’insù invece ci racconta proprio quella storia, e lo fa grazie alla “felice” collocazione personale del protagonista, che io definirei “coinvolto e innocente” allo stesso tempo, capace di uno sguardo che agli storici risulta ancora difficile. Ho l’impressione che la storiografia continui a riflettere, tutto sommato, il punto di vista degli apparati (gli apparati di stato, che mimavano la guerra fredda, e gli apparati di movimento, che mimavano la rivoluzione o la Resistenza), ma non riesca a dar conto dell’esperienza – che non esiterei a definire “tragica” – di persone come quelle che animano il romanzo di Luca. Persone, cioè, sospese fra un immaginario collettivo tutto definito attorno ai valori, ai simboli, ai linguaggi della civiltà industriale, e una realtà che invece stava andando a passi da gigante verso una dimensione post-industriale.
LR. Sono d’accordo sulla “tragicità” di quell’esperienza. Noi (ecco che mi identifico con il protagonista del libro) vivevamo la politica in una dimensione fortemente segnata dall’idea di “desiderio”, eravamo l’espressione di una trasformazione in atto a livello sociale della quale però non eravamo in grado di cogliere tutte le conseguenze. Davamo dei nomi vecchi, sbagliati, a cose nuove, che forse intuivamo – sia pure confusamente – ma senza comprenderne davvero la portata. Capivamo che il potere non era più un “luogo” da conquistare con la forza, che esisteva la “microfisica del potere” di cui parlava Foucault, ma poi continuavamo a parlare di rivoluzione comunista, quasi senza renderci conto di quanto quest’espressione avesse perso di significato (oppure ce ne rendevamo conto, ma non avevamo alternative neppure a livello linguistico). Penso anche all’importanza della comunicazione nei processi produttivi sociali, con i quali il movimento del ’77 ha cercato, senza riuscirci, di confrontarsi (e credo non sia un caso, che diversi ex compagni anni dopo abbiano trovato lavoro con facilità nei giornali, nelle televisioni, nelle radio). Per me quel periodo è stato davvero tutto all’insegna della contraddizione: di contraddizioni che noi non riuscivamo a controllare.
Da quello che avete detto mi sembra che emerga un’immagine di quegli anni, in particolare del movimento del Settantasette, quasi disperata. Un’immagine secondo cui, sostanzialmente, gli esiti della “stagione dei movimenti” erano segnati; detto in maniera un po’ sbrigativa: non poteva che finire com’è finita. È così? Oppure secondo voi era ancora possibile, alla fine degli anni settanta, uno sbocco sociale e politico diverso?
MR. No, secondo me non c’era nulla che potesse cambiare l’esito di quella stagione. Il che non significa negare, o minimizzare, gli errori che sono stati fatti, in qualche caso anche terribili, ma prendere atto che nella seconda metà degli anni settanta (e il discorso non riguarda solo l’Italia, ovviamente) non esisteva più nessuna “unità”, né politica, né culturale, dei gruppi sociali che erano stati i protagonisti della conflittualità nell’epoca fordista. Erano le prime avvisaglie, se vogliamo, di quello che si è poi pienamente realizzato nei decenni successivi, in forme eclatanti già dagli anni ottanta. C’è un episodio, in Piove all’insù, che descrive bene questo passaggio; è quello degli scontri al Palasport per il concerto di Santana, quando il protagonista e i suoi compagni toccano con mano (e quasi con stupore) l’ostilità dei proletari di Borgo San Paolo, incazzati perché gli sono state incendiate le macchine, e trovano invece solidarietà e complicità nei “coatti” del quartiere. È un rovesciamento totale di quello che succedeva invece dopo il ’68, che era successo in corso Traiano il 3 luglio e in tante altre occasioni, quando tra gli operai di Mirafiori e il sottoproletariato urbano si stabilivano relazioni forti di complicità. Nel Settantasette invece non c’è più un orizzonte condiviso, non c’è più un linguaggio che sappia parlare a tutti, che sappia far parlare tutti. Ci sono linguaggi vecchi, che una parte crescente della società non capisce più (e soprattutto non condivide più).
LR. Credo anch’io che nel Settantasette non ci fossero più spazi. Io, d’altra parte, forse perché figlio di un militare (quindi con una qualche conoscenza della forza repressiva dello stato), non ho mai creduto, nemmeno allora, che il movimento potesse “vincere”. Non si capisce neppure che cosa volesse dire, per quel movimento, “vincere”. All’idea classica della rivoluzione in realtà nessuno credeva più, e non penso che allora si ragionasse granché in termini di “sbocco” delle lotte o dei movimenti. D’altra parte i primi mesi di quell’anno furono tutto un tagliarsi i ponti alle spalle. Prima c’è il 17 febbraio, la cacciata di Lama dall’università di Roma (una cosa enorme: una rottura con la storia del Novecento!); poi c’è il 12 marzo, dopo l’uccisione di Lorusso, con gli scontri di massa a Bologna e a Roma, che segnano un altro punto di non ritorno. Io c’ero quel giorno a Roma, ne ho un ricordo pazzesco: gente che svaligiava le armerie e gente che si metteva a suonare jazz per la strada, persone che non si conoscevano e si mettevano insieme per attaccare la sede di qualcosa, corpi lanciati all’attacco, un insieme di festa e di dramma. Da un fatto così nessun movimento può tornare indietro, non è che dopo una giornata di quel tipo puoi fare finta di niente, e pensare che ci siano ancora spazi per “fare intervento” (come si diceva allora) alla maniera tradizionale. Non è che ti presenti tranquillo davanti ai cancelli di Mirafiori, perché trovi quelli del Pci che ti massacrano. Eri accerchiato, insomma, e non è un caso che quando il “movimento” cerca di darsi ancora, disperatamente, un contenuto politico-sociale, l’unico terreno praticabile resta quello della lotta all’eroina, agli spacciatori. E a quel punto, come logica, purtroppo si finisce alla manifestazione del 1° ottobre, all’Angelo Azzurro, dove viene bruciato un ragazzo di 22 anni, Roberto Crescenzio (che peraltro non c’entrava niente con lo spaccio).
Ecco: l’Angelo Azzurro, il bar considerato un luogo di spaccio che fu assaltato e incendiato con un’azione “militante” e che si risolse nel dramma che sappiamo. L’episodio ha un ruolo importante nel libro, a me è sembrato come una cappa di morte, che segna una cesura netta anche nei ricordi del protagonista. C’è un punto in cui Pietro Miasco dice che, ancora a distanza di tanti anni, non riesce a perdonare il cinismo e l’incoscienza di quelle compagne che facevano dell’ironia sull’accaduto, parafrasando una canzone di successo in quel periodo, di Umberto Balsamo: “Se sei tu l’Angelo azzurro / questo azzurro non mi piace. / Era sabato mattina / e sei diventato brace”. Anche quello è un punto di non ritorno, no?
LR. Be’, non è un caso che dopo quel giorno a Torino non ci siano più stati cortei di movimento. Non era più possibile, davvero, da nessun punto di vista. Per molti compagni quello che era successo è stato un autentico trauma, che ha messo in crisi certezze, arroganze, modi di intendere la militanza, di stare dentro il movimento. C’erano degli elementi, nel fatto dell’Angelo Azzurro, che mi sembravano emblematici di tutte le contraddizioni in cui ci si dibatteva allora. E la cosa della canzone di Umberto Balsamo, purtroppo, è vera, non me la sono inventata.
MR. La cosa più impressionante di quel corteo, secondo me, è l’aria di morte che vi si respirava, ancora prima dell’assalto all’Angelo Azzurro. Io ne ho un ricordo assolutamente cupo, disperato. Il movimento era davvero in un vicolo cieco, a quel punto, da cui non poteva e non sapeva più come uscire, e di cui l’episodio in cui morì Crescenzio fu – se vogliamo – la tragica ma logica conseguenza. Nessuna altra città ha vissuto nel ’77 un’esperienza come quella.
Un’ultima domanda. Voi che giudizio date delle proposte, che affiorano ogni tanto nel dibattito pubblico, per un’opera di “riconciliazione” che valga a chiudere definitivamente i conti con quella stagione?
LR. Io non ci credo, mi sembrano tutte operazioni di bassa politica, rivolte a legittimare questo o quel settore del sistema attuale dei partiti. Non credo ci possa essere nessuna “riconciliazione”, se prima non cessa la damnatio memoriae che continua a gravare sulla storia dei movimenti.
MR. A me dà molto fastidio sentire parlare di “riconciliazione” delle memorie, che è un’assurdità totale. Si possono riconciliare le persone, se lo ritengono giusto, ma non le memorie, che per loro natura non possono che essere divise. E mi ha anche indignato il modo con cui è stata presentata l’iniziativa del presidente della Repubblica, che ha fatto incontrare Licia Pinelli e Gemma Calabresi. Nessuno che abbia avuto il coraggio di ricordare che per il delitto Calabresi ci sono stati un processo e delle condanne (qualunque giudizio se ne voglia dare), mentre per la morte di Pinelli, così come per la strage di piazza Fontana, sul piano giudiziario è stato tutto insabbiato, o si è risolto come sappiamo. Su queste basi, parlare di “riconciliazione” mi sembra davvero una presa in giro.








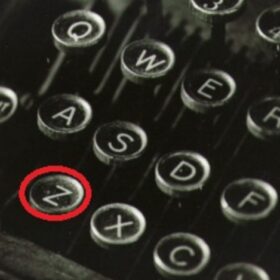







1 commento
Pingback
3 Agosto 2015 at 0:02