Un inedito dialogo con Luca Rastello, realizzato ad aprile 2015; un’analisi critica di esperienze in cui il conflitto pare pacificato, mentre vi si realizzano pratiche e linguaggi di nuova soggezione ed erosione dei diritti. Lo presentiamo anche come anticipazione del numero di «Zapruder» attualmente in lavorazione (n. 38, Io sto bene io sto male. Innovazione dal basso e welfare contemporaneo).
I buoni. Evoluzione, potere e contraddizioni del terzo settore.
(a cura di Elanor Cattaneo, revisione di Franco Pezzini)
Luca Rastello (1961-2015), giornalista e scrittore italiano, recentemente scomparso. Per molti anni ha lavorato nel campo della cooperazione internazionale e delle organizzazioni no profit. È stato direttore di «Narcomafie», inviato di «Diario» ed è stato collaboratore di «la Repubblica»; a seguito delle sue collaborazioni ha lavorato nei Balcani, in Asia centrale, in Africa e in Sud America. All’attivo ha pubblicazioni che riflettono il suo lavoro, da La guerra in casa (Einaudi, 1998) a Binario morto (Chiarelettere, 2013, con Andrea De Benedetti). Nel suo primo romanzo, Piove all’insù (Bollati Boringhieri, 2006), ha affrontato storie degli anni settanta riannodandole alle contraddizioni del presente; I buoni, secondo romanzo, è ambientato all’interno del mondo della cooperazione (Chiarelettere, 2014).
 Hai lavorato per molti anni nel terzo settore e al centro del tuo romanzo c’è l’onlus In punta di piedi, perciò hai utilizzato e interrogato una realtà che conosci per raccontare una storia. Perché hai deciso di raccontare questa storia, e quanto ha pesato conoscere dall’interno il mondo della cooperazione e ciò che le onlus fanno nei loro progetti?
Hai lavorato per molti anni nel terzo settore e al centro del tuo romanzo c’è l’onlus In punta di piedi, perciò hai utilizzato e interrogato una realtà che conosci per raccontare una storia. Perché hai deciso di raccontare questa storia, e quanto ha pesato conoscere dall’interno il mondo della cooperazione e ciò che le onlus fanno nei loro progetti?
L’ambientazione non è casuale, però non si tratta di un libro sulle onlus. Ci sono due aspetti che mi piace sempre chiarire: è un romanzo ma non è un romanzo a chiave, e ho scelto lo strumento romanzo perché l’idea era di stanare alcuni argomenti che solo il romanzo raggiunge. In particolare credo che sia un libro sul linguaggio, sulla costruzione sociale della realtà e sulla costruzione dei rapporti di potere attraverso il linguaggio. Quindi l’onlus è un’ambientazione utile perché è un luogo dove precipitano le contraddizioni in maniera più visibile e vistosa, ed è un’ambientazione opportuna per me perché è il luogo dove ho passato, in realtà diverse, un trentennio della mia vita. Però parlo di fenomeni che si verificano e di dispositivi che si mettono in movimento anche in altri ambienti, in tutti i tipi di comunità umana, ma in particolare nelle comunità chiuse, e poi, ancora più in particolare, nelle comunità finalizzate. Cioè i meccanismi di potere messi in moto dal linguaggio sono più pervasivi e più influenti dove c’è un fine etico, perché questo fine determina l’uso che si fa del linguaggio e dei valori all’interno di una comunità.
Utilizzi una narrazione molto forte, scomoda, soprattutto nella parte centrale del libro, in cui è evidente come padroneggiare il linguaggio definisca l’orizzonte dei diritti delle persone. Quale è la relazione che c’è tra il potere, le sue dinamiche e l’utilizzo del linguaggio? Penso ad esempio all’utilizzo che fai di alcune formule – la telefonata convocazione, la frusta dell’oltre – che in un certo senso addolciscono la parola ma dietro nascondono un significato più forte e negativo.
Il linguaggio è pericoloso e sono convinto che l’igiene del lessico sia una necessità fondamentale, che si debba partire da lì, senza concedersi un vocabolario solo perché è un vocabolario acquisito. Hai citato la frusta dell’oltre che è sostanzialmente quel pungolo che ti impone di lavorare senza essere pagato, cioè di farti sfruttare, e sentirti anche virtuoso perché credi di avere degli orizzonti più vasti e più alti. Dopodiché però nessuno si preoccupa di definire quegli orizzonti – in nome di che cosa sacrifichiamo alcuni diritti – e soprattutto di dimostrare che sono più alti. Allora il linguaggio diventa fondamentale. Nei dibattiti e nelle discussioni seguite al libro ho travato degli esempi che hanno chiarito la situazione meglio di quanto potrei fare io: una signora durante una presentazione si alza quasi in lacrime e racconta di aver subito un trattamento scandaloso in occasione della maternità, come quelli raccontati nel libro, ma di non riuscire ad avviare una vertenza per denunciare, di non riuscire nemmeno a parlarne. Al personaggio del libro a cui accade una simile vicenda capita di andare ad un’assemblea e di essere travolta, colpevolizzata con quel sistema di linguaggio: «tu non senti la frusta dell’oltre, tu non senti i valori più alti per cui noi lavoriamo, tu sei qui per uno stipendio».
Come se il lavoro nel terzo settore fosse una missione…
Esatto. E da qui tutta la marea retorica che nasce da espressioni come bisogna sporcarsi le mani, metterci la faccia, il passo lento del montanaro con cui noi raggiungiamo l’oltre. Cioè tutte quelle espressioni che servono a fare in modo che tu non abbia voce per esprimere un disagio che provi nei confronti di un ordine di valori che non è enunciato, ma che è implicito nelle regole della comunità in cui ti trovi. Succede una cosa simile a quella di chi subisce violenza in un contesto dominato da linguaggi maschili, fatti per togliere completamente la voce e il vocabolario per dire non solo che hai subito un abuso, ma anche che quello che hai subito è un abuso. Immagina comunità indiane in cui non esiste il concetto di violenza sessuale, per cui non puoi averla subita, è una cosa naturale. Ma a volte la tua esperienza personale e il tuo disagio si trovano in contrapposizione con tale ordine di valori, e non hai le parole per dirlo. Cresci in una comunità che è determinata dal linguaggio che parla, perché il linguaggio è un codice di riconoscimento reciproco formidabile, è un codice di appartenenza – se noi parliamo la stessa lingua e usiamo le stesse espressioni è perché condividiamo gli stessi valori, e in base a questi valori abbiamo scelto questo tipo di vita e quindi apparteniamo a questa comunità; e se poi la comunità è anche orientata ad un fine etico diventa discrimine tra il bene e il male. Appartenere significa avere senso, non appartenere significa non avere senso. Quindi se sei in rotta di collisione con i valori di quella comunità, sei in rotta di collisione col senso della vita, allora sei fuori, non esisti. Questo è un meccanismo coercitivo micidiale: chi controlla il linguaggio con la retorica controlla l’esistenza perché su ciò si basano il riconoscimento, l’appartenenza, le coordinate e il perimetro della comunità, i valori e i diritti che possono essere esercitati e che esistono. Cioè ha in mano la parola che crea: ciò che il linguaggio dice esiste, ciò che il linguaggio non dice non esiste. Ora accade che in un altro dibattito la presidentessa di un circolo Arci racconta di aver applicato alle sue dipendenti, oltre che a se stessa, lo stesso trattamento di maternità perché convinta di avere una missione più alta. Ma quale è questa missione più alta e perché è più alta? Rendiamoci conto che il terzo settore oggi è additato dai poteri come il luogo virtuoso, il laboratorio della società migliore. E siccome è additato come esempio, l’esempio poi si sparge, e se tu togli alcuni diritti dall’orizzonte contrattuale scrivi la bozza del prossimo contratto di Marchionne. La tutela della maternità, la parità fra uomo e donna sul lavoro, la tutela della dignità del lavoro dipendente, tutto questo sacrificato in nome di valori superiori.
Il concetto di “legalità” è un altro tema forte. La legalità è il fondamento e il centro dell’azione solidale dell’organizzazione, la stessa che poi all’interno ha però ben poco rispetto per i suoi collaboratori. Questa contraddizione è ancora più evidente col crescere dell’importanza della stessa organizzazione e con l’aumentare del potere che si trova a dover gestire. Cosa significa legalità e come spieghi questa contraddizione?
Si tratta di parole d’ordine feticizzate. Se devo sacrificare il diritto alla tutela del lavoro, la maternità, la parità tra uomo e donna al culto della “legalità”, allora cerchiamo di capire cos’è: la legalità è un valore se e solo se siamo nel migliore dei mondi possibili. Se abbiamo realizzato la società perfetta e ideale allora la legalità – cioè il metodo per far rispettare il patto sociale che produce quella società – è un valore, altrimenti è uno strumento, un metodo, nelle mani di sacerdoti che legittimano se stessi, la loro leadership, attraverso la sacralizzazione di qualcosa che sacro non è. Ogni progresso della civiltà umana avviene per rotture di legalità, da sempre. La legalità è determinata dai rapporti di forza e dalle ideologie vigenti nel momento in cui si stringe il patto sociale, di cui quella forma di legalità è il guardiano. E quei rapporti di forza molto spesso sono rapporti violenti, rapporti di dominazione: allora la legalità va superata. Se la legalità è un valore, allora la società è arrivata a un punto di giustizia assoluta; ma se la legalità non è un valore i suoi sacerdoti che la erigono a valore, che la insegnano nelle scuole, che arruolano folle nel suo nome, sono persone che legittimano la propria posizione di potere per usarla secondo rapporti di forza e ideologia storicamente determinati, e non certo eterni come un valore. L’esempio è la procura di Torino, quando Giancarlo Caselli fa incriminare dai suoi Pm a trent’anni di galera per terrorismo chi ha bruciato un compressore, e a sei anni per incendio doloso chi ha cercato di bruciare i bambini rom della Continassa. Questa è ideologia, lui ha delle idee precise che mette in campo, ma che santifica col crisma di un valore assoluto all’interno del quale tutti devono stare. Ogni dissenso in questa società deve sottostare ai confini della legalità, perché l’ha deciso il linguaggio, e quel linguaggio serve a santificare quelli come Caselli e a farne degli intoccabili sacerdoti della norma. Se si costituisce una casta di sacerdoti guardiani della norma, la quale norma è organizzata secondo gerarchie di valori che devono uniformare a sé la società e i ruoli della società, l’esercizio di diritti, il modo in cui si lavora, addirittura la contrattualizzazione, allora qui abbiamo una situazione di graduazione dell’arruolamento alla norma. Penso all’ormai classica critica di Foucault alla società panottica, penso a Sorvegliare e punire. Si individuano le grandi istituzioni: la prigione, l’ospedale, la caserma e la scuola, che costituiscono una norma che diventa sentire comune. La moralizzazione delle classi povere nell’Ottocento tende a portare la disciplina sotto forma di norma all’interno di tutti i comportamenti della società, la prigione si espande, così come l’essere esposti ad una sorveglianza, ad una custodia. Oggi noi siamo ad un gradino ulteriore, noi introiettiamo la norma attraverso queste gerarchie di valori e attraverso l’arruolamento ad un frammento percepito, o presentato come il migliore di una società, capace di sacrificare tutte le conquiste fatte in duecento anni in nome di valori astratti; noi introiettiamo la disciplina, introiettiamo la norma, siamo arruolati a una società del controllo che parte da dentro. Il panopticon l’abbiamo inghiottito e ce l’abbiamo dentro. La guardia siamo noi stessi, attraverso un’ideologia che ci fornisce una gerarchia di valori che fa di noi i controllori di noi stessi, quindi di noi i controllori della norma e fa della norma il controllore universale della società. E il lavoro sociale diventa la quinta istituzione totalitaria di questo mondo dominato dalle telecamere. Ho parlato di graduazione dell’arruolamento alla norma perché si parte dalla buona intenzione ma anche dal volontariato innocuo, visto che la parola volontario già ti arruola ad un ordine di valori, e da quell’ordine di valori fino a negare la maternità. Si percorre una scala graduale che determina la società su rapporti di forza, che sono anche rapporti di violenza, mascherati da un linguaggio che parla di solidarietà, e che quindi ti fa introiettare e fa di te il migliore guardiano dei rapporti che sei nato per scardinare.
Don Silvano è l’incarnazione del rapporto che c’è tra carisma e potere, in un certo senso è un idolo, a lui e alle sue parole abbiamo delegato le nostre lotte, la cura dei più deboli, la lotta contro le mafie, perché Don Silvano si fa carico di conoscere, capire e costruire il bene.
Purtroppo siamo la caricatura dell’idea brechtiana «sfortunato il paese che ha bisogno di eroi». Cioè l’azione civica trasferita nel simbolico, per cui valori-feticcio sono di fatto i pilastri di un ordine simbolico che sostituisce l’ordine reale, l’ordine dell’azione. Dove la domanda del Novecento è «che fare?» – io mi pongo il problema del mio ruolo entro la società ponendomi il problema del mio orizzonte di azione – la domanda del XXI secolo sarà molto più querula e sembra suonare «chi sono?». È una domanda di identità, capire a quale orizzonte appartengo, resuscitare una memoria che mi legittimi, che mi renda appartenente, ma che di fatto vanifica il che fare. L’orizzonte simbolico “appartenere ad un sistema di valori” – l’antimafia dei simboli, il lavoro sociale, la cooperazione, l’essere migliore – sostituisce la necessità di agire politicamente per la trasformazione. Questa sostituzione in realtà è anche un forte generatore di infelicità, perché toglie destino e destinazione. La domanda «che fare?» in fondo definiva delle traiettorie che potevano dare senso anche alla vita quotidiana. Adesso non voglio riesumare la militanza del Novecento, però voglio dire che era più facile vivere con un orizzonte di trasformazione abbastanza strutturato a cui tendere. Oggi questo manca, c’è solo un orizzonte di appartenenza: io sto con “i buoni”. E nota che molto spesso la risposta è una risposta di morte. Che cosa è l’antimafia dei simboli incarnata da Libera? Un culto dei morti, un elenco di nomi di vittime, peraltro scelti in base a criteri aberranti, tipo la Giornata delle vittime innocenti di mafia. Poi bisognerebbe ragionare su cosa significa innocenti. Significa che io ho il diritto di dare la titolarità di innocenza, quindi certifico solo la mia innocenza e la mia titolarità. Cos’è una vittima innocente di mafia? Ci vuole il gran sacerdote che decide chi è innocente e chi non lo è, ma non importa a nessuno della vittima, importa l’arruolamento nell’ordine simbolico di cui il concetto di vittima è guardiano. Quell’orizzonte simbolico ti dà una tessera di appartenenza, risponde alla domanda «chi sono?». Mentre «che fare?» è già chiaro, l’ha deciso il capo per me, l’ha deciso il testimonial, lo decide l’adesione totale all’orizzonte di valori e simboli… e a quel punto c’è una delega. Io ho bisogno di eroi civili per poter continuare la mia vita di tutti i giorni, ho bisogno che ci sia qualcuno che certifica che le battaglie che sento come indispensabili stanno venendo portate avanti: ho bisogno dell’eroe, del portabandiera, faccio click su “I like” e mi iscrivo nella lista dei fan su Facebook dei vari Saviano, Caselli, Ciotti. Ci sono eroi per ogni situazione, di fatto la logica postmoderna è quella del testimonial; è il meccanismo di comunicazione postmoderna che fa sì che ci siano i portavoce della sofferenza, della soluzione alla sofferenza, della battaglia contro la sofferenza, e ognuno viene consegnato al suo orizzonte individuale, parcellizzato, in cui il compito è sorvegliare solo se stesso attraverso l’introiezione di valori virtuosi.








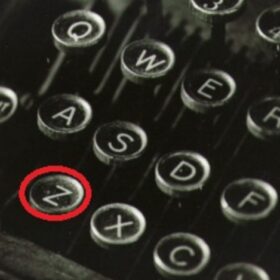






1 commento
Pingback
5 Settembre 2015 at 23:17