Note sul discorso mediatico intorno al colonialismo italiano
di Valeria Deplano
Era il 1995 quando il «Corriere della Sera» ospitò sulle sue pagine l’ultimo capitolo di un contenzioso che vedeva contrapposti Angelo Del Boca e Indro Montanelli: il primo, giornalista ormai diventato storico, denunciava sulla base di documenti d’archivio l’uso di armi chimiche, proibite dalla convenzione di Ginevra, durante la guerra d’Etiopia; il secondo, giornalista-testimone, negava tutto sulla base di ciò che lui in prima persona, da militare, (non) aveva visto[ref]1. La lunga polemica è ricostruita dallo stesso Del Boca in Id., I gas di Mussolini. Il fascismo e la guerra d’Etiopia, Editori Riuniti, Roma, 1996, pp. 28-48[/ref]. Da quel famoso dibattito, conclusosi con l’ammissione del proprio errore da parte di Montanelli, è passata molta acqua sotto i ponti[ref]2. Indro Montanelli, Gas in Etiopia: i documenti mi danno torto, «Corriere della Sera», 13 febbraio 1996[/ref]. Nel frattempo, è cresciuta la diffusione degli studi storici sul colonialismo, che hanno definitivamente dimostrato l’inconsistenza della tesi dell’italiano colonizzatore buono; ed è aumentata anche la presenza di questi temi nel discorso pubblico. Allo stesso tempo è però evidente che in Italia permane ancora una certa difficoltà – che in molti casi è esplicita ostilità – a concepire l’occupazione coloniale come un evento strutturalmente criminoso e razzista, e inevitabilmente dannoso e doloroso per le popolazioni che la subiscono. È all’interno di questa contraddizione – tra gli innegabili cambiamenti sollecitati anche dallo sviluppo storiografico, e la resistenza di un paradigma interpretativo autoassolutorio – che va letto il discorso pubblico attuale sul colonialismo.
In questi ultimi decenni è cambiato in primo luogo l’atteggiamento nei confronti delle violenze praticate dagli italiani, che ora appare più difficoltoso negare tout court, come faceva Montanelli. È ormai diversa, soprattutto, la posizione ufficiale dell’Italia nei confronti delle proprie responsabilità coloniali. Aveva iniziato Scalfaro, nel 1997, primo capo di Stato italiano a fare una visita ufficiale ad Addis Abeba e primo a riconoscere ufficialmente il portato criminale dell’occupazione coloniale. Si trattò di un gesto importante, decisamente di rottura sia per quanto riguarda i rapporti con l’Etiopia sia per quanto riguarda l’autorappresentazione dell’Italia: qua il discorso pubblico era ancora impostato sull’idea che gli italiani fossero diversi dagli altri colonizzatori europei, più umani, non violenti, e incapaci di fare profitto a scapito dei colonizzati.
Eppure proprio nel discorso di Scalfaro si possono rintracciare i semi di quello che in questi ultimi due decenni si è affermato come il nuovo discorso sul colonialismo: «Il lavoro degli italiani si mescolò a quello del popolo dell’Etiopia, ma si trattava di una fraternità che partiva dalla costrizione e non da una libera scelta», disse il presidente della Repubblica. In questo modo Scalfaro ammetteva finalmente la struttura violenta del rapporto coloniale, ma contemporaneamente mitigava il portato di tale ammissione riproponendo uno dei temi principali del mito degli italiani brava gente: quella che ignorava deliberatamente la situazione di privilegio in cui si trovavano i coloni, e li riduceva a semplici lavoratori, naturalmente bendisposti nei confronti dei colonizzati. L’intento dell’incontro era inoltre quello di «superare delle pagine di questo secolo che non sono state d’amicizia, ma purtroppo di sangue»[ref]3. Scalfaro chiede scusa all’Etiopia, «La Repubblica», 25 novembre 1997[/ref]. L’ammissione di colpevolezza tardiva veniva quindi immediatamente accompagnata dalla richiesta di lasciarsi il passato alle spalle: neanche un evento epocale come quello si trasformò in un momento in cui gli italiani furono chiamati soffermarsi su quel passato nazionale che, evidentemente, era stato presentato loro in maniera parziale e distorta. Questo sarà il paradigma discorsivo che accompagnerà altri incontri istituzionali tra le autorità italiane e quelle libiche ed etiopiche: ad esempio la visita di Sergio Mattarella ad Addis Abeba nel 2016, nel corso della quale il presidente delle Repubblica ha stretto la mano ad alcuni dei partigiani che combatterono nella resistenza antitaliana, nella simbolica piazza di Arat Kilo. Anche in questo caso la stampa italiana, se non ha potuto più ignorare i racconti dei crimini, ha contestualmente sottolineato la necessità di “guardare avanti” piuttosto che (ri)pensare il passato e la maniera in cui era stato a lungo raccontato. Inoltre, la consapevolezza delle violenze non era accompagnata da una più ampia messa in discussione dei temi centrali che sostengono il mito degli “italiani brava gente”, in particolare quello della civilizzazione e del progresso portato dalla presenza italiana. Anzi, in un certo senso si può leggere questa dichiarazione di colpevolezza accompagnata da un’immediata autoassoluzione come un rafforzamento dello stesso discorso: nello specifico della visita del 2016, infatti, guardare avanti significava sugellare una nuova amicizia che permettesse alle aziende italiane di operare in un clima favorevole nell’interesse – si suggeriva – di entrambe le nazioni.
Come ammissione di colpa e smantellamento del mito civilizzatore non vadano di pari passo era emerso anche alcuni anni prima, nel 2008. L’occasione era la firma del trattato di amicizia tra l’allora premier Silvio Berlusconi e il leader libico Mu’ammar Gheddafi, che includeva da parte italiana un risarcimento per i crimini coloniali.«Il passato che con questo trattato vogliamo mettere alle spalle – sostenne Berlusconi – è un passato di cui noi, figli dei figli, sentiamo una colpa di cui chiedervi perdono». Il risarcimento doveva porre fine ad un contenzioso che da 40 anni contrapponeva Libia e Italia, aprendo una stagione di nuovi rapporti – specialmente economici – tra i due paesi. In cambio del risarcimento di 5 milioni di dollari, spiegava infatti il presidente del Consiglio, l’Italia otteneva dalla Libia «più petrolio e meno immigrati». Di nuovo dunque, ammissione di colpa finalizzata a chiudere scomode discussioni (peraltro aperte solo sul fronte dei rapporti internazionali, e non su quello interno), in vista di nuovi interessi economici e politici. È interessante notare però che quella superficiale ammissione di colpa – superficiale perché, come sottolineò allora Del Boca, dal trattato i crimini coloniali erano praticamente assenti – fu sufficiente per accendere polemiche in Italia.
Non furono solo le associazioni dei profughi italiani della Libia, quelli cacciati nel 1970 dallo stesso Gheddafi, a non digerire le dichiarazioni di Berlusconi, ma una platea variegata. I telespettatori di SkyTg24 furono interrogati sulla faccenda (come se un’emittente tedesca chiedesse il parere dei suoi spettatori rispetto alle ammissioni di colpa del governo per le stragi naziste) e risposero al 74% di non essere d’accordo con Berlusconi. Negli stessi giorni su vari siti di informazione o opinione online l’inopportunità delle dichiarazioni fu messa in connessione proprio con il presunto portato “civilizzatore” del colonialismo. Il sito Polisblog scrisse allora che «i benefici portati dalla colonizzazione italiana sono stati ben superiori ai danni». Sul sito “Storia in rete” un lungo articolo spiegava che dopotutto la Libia deve molto all’Italia “a cominciare dal nome”, e riteneva che la decisione del premier ledesse “la dignità nazionale italiana”.
Le argomentazioni utilizzate non si distaccavano dal discorso coloniale originale, vale a dire quello che accompagnò l’occupazione coloniale dalla fine dell’Ottocento alla fine del fascismo, ma ne riesumavano (se mai fossero stati sepolti) invece due temi portanti. In primis quello della civilizzazione e della modernizzazione, secondo cui per quanto violento il colonialismo convenne ai colonizzati, che beneficiarono non solo del “know-how” ma anche della benevolenza degli occupanti. Secondo questa interpretazione gli interventi degli italiani, specialmente nell’ambito dell’edilizia e delle infrastrutture, avrebbero introdotto le popolazioni africane alla modernità del XX secolo – ad esempio favorendone gli spostamenti – e ne avrebbero migliorato automaticamente le condizioni di vita. A smentire l’altruismo sotteso a questa lettura sono le carte e le pubblicazioni dell’epocache rivendicano apertamente come infrastrutture e opere pubbliche fossero finalizzate a favorire l’afflusso di beni e persone verso i territori occupati, per consentirne una migliore colonizzazione.
L’altro argomento, connesso in qualche modo con il primo, e caro in maniera più evidente alle varie realtà di destra ed estrema destra, è quello delle dignità nazionale e della grandezza dell’Italia. Esattamente come nel 1896 o nel 1935, la grandeur italiana viene ancora connessa alla presenza coloniale. Quella passata, per cui criticare la storia coloniale italiana significa peccare di poco patriottismo; ma anche quella presente. Si colloca in questa dimensione l’idea espressa dal segretario di Casa Pound all’inizio del 2018, di realizzare un protettorato sulla Tripolitania. Di Stefano definiva il progetto come una «politica sensata per ridare all’Italia la centralità nel Mediterraneo», realizzabile – manco a dirlo – grazie alla «nostra tradizione di civiltà e di costruzione materiale delle infrastrutture».
Una proposta politica sicuramente surreale, ma che suonerebbe più risibile se non si nutrisse di un discorso che è molto meno marginale e politicamente collocabile di quello della stessa Casa Pound. Un discorso che subordina le violenze accertate del colonialismo italiano ad una supposta civilizzazione, e che è allo stesso tempo proposto con toni aggressivi da altri ambienti riconducibili alla destra, (uno degli esempi più recenti è l’articolo uscito il 31 luglio 2018 su «La Verità», quotidiano diretto da Maurizio Belpietro), oppure suggerito con toni più moderati anche da media non politicamente collocati. Così, come l’articolo de «La Verità» rivendica che grazie al colonialismo ora si possa mangiare in Etiopia un ottimo piatto di spaghetti, a termine della puntata di «Il tempo e la storia» andata in onda il 5 maggio 2016 (ottantesimo anniversario dell’occupazione italiana di Addis Abeba) si suggeriva una visita ad un ristorante di Addis Abeba dove mangiare delle ottime tagliatelle alla bolognese. Il linea con il format del programma, il ristorante era stato scelto come luogo simbolo per pensare al colonialismo italiano in Africa, accanto ad un libro (Il deserto della Libia di Tobino) e un film (Lo squadrone bianco, premiato con la Coppa Mussolini nel 1936). «Anche quella è un’eredità», si commentava in studio, a proposito delle tagliatelle. Di sicuro, la riproposizione di un film di propaganda degli anni Trenta e la scelta di eleggere a luogo simbolo un ristorante italiano piuttosto che uno qualunque dei possibili “luoghi della memoria” – Debra Libanos, la stessa Arat Kilo, l’obelisco di Axum – rientra più nel campo delle eredità che in quello del ripensamento critico del passato coloniale e fascista.







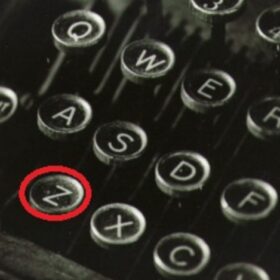










1 commento
Pingback
29 Agosto 2018 at 11:18