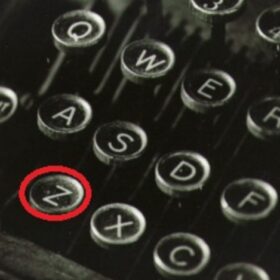Ripresentiamo, nella sua forma integrale, l’intervista di Andrea Brazzoduro a Enzo Traverso, uscita nel numero 44 di «Zapruder». Senza dubbio uno degli storici viventi più letti e discussi, Traverso dirige il dipartimento di Romance Studies a Cornell University (Ithaca, New York). I suoi libri, tradotti in numerose lingue, hanno un’influenza crescente, dentro e fuori l’università. Ricordiamo almeno: Il totalitarismo. Storia di un dibattito (Mondadori, 2002), La violenza nazista. Una genealogia (il Mulino, 2002), Il passato: istruzioni per l’uso. Storia, memoria, politica (ombre corte, 2006), A ferro e fuoco. La guerra civile europea, 1914-1945 (il Mulino, 2007), Il secolo armato. Interpretare le violenze del Novecento (Feltrinelli, 2012). Discutiamo con Enzo Traverso del 1917 come evento, come storia e come memoria in sponda al suo ultimo libro (Malinconia di sinistra. Una tradizione nascosta, Feltrinelli, 2017), pubblicato contemporaneamente in inglese, francese e italiano.
Nel libro-intervista con Régis Meyran (I nuovi volti del fascismo, ombre corte 2017) proponi un’analisi del fenomeno delle destre contemporanee attraverso la categoria di postfascismo, una sorta di precipitato del regime di storicità presentista dell’inizio del xxi secolo che ne spiegherebbe il «contenuto ideologico fluttuante, instabile, spesso contradditorio, nel quale si mescolano filosofie politiche antinomiche». Nel mondo completamente reificato, in cui la merce modella tutte le relazioni umane e sociali, dove il mercato e la competizione sono l’unico orizzonte di senso possibile e l’umanità non è più in grado di immaginarsi al di fuori di questo modello antropologico, il neoliberismo dominante si configura come un totalitarismo compiuto. Per affrontare questo nodo, mi piacerebbe cominciassimo dall’immagine della statua spezzata di Lenin che risale il Danubio, una sequenza dello Sguardo di Ulisse di Theo Angelopoulos (1995): nel tuo precedente libro (Malinconia di sinistra. Una tradizione nascosta, Feltrinelli 2017), dai una lettura particolarmente interessante di questo ritorno, come rinascita e reinvenzione.
Questa scena chiave del film, la statua smontata di Lenin che attraversa il Danubio, che ritorna verso l’Europa centrale, alle fonti del Danubio, Angelopoulos la presenta come un ritorno alle origini e quindi la promessa di una rinascita. Ma allo stesso tempo è una scena che rappresenta un funerale, è una scena di lutto: Lenin che abbandona la scena della storia, con la gente che si agglutina sulle rive del Danubio e si fa il segno della croce come per salutare la salma. L’idea è proprio quella: un’epoca è finita, il comunismo del Novecento è un’esperienza chiusa e bisogna inventare qualcosa di nuovo. Il ritorno alle origini è la rinascita di qualcosa che sarà diverso rispetto a quel che si è conosciuto. Il film di Angelopoulos è stato girato in piena guerra civile nei Balcani e sotto l’impatto molto forte della fine del comunismo, la fine dell’Unione sovietica, la caduta del muro di Berlino, la fine della guerra fredda e l’inizio del XXI secolo. Ora è già trascorso un quarto di secolo dal quel momento e la rinascita che sperava Angelopoulos è ancora difficilmente percepibile. Dal 1995 ad oggi ci sono stati movimenti molto importanti in tutto il mondo, dall’altermondialismo ai movimenti degli ultimi dieci anni: da Occupy Wall Street, Los Indignados, Gezi Park, Nuit Debout… In Italia ci sono stati movimenti sociali, i no tav… Poi le rivoluzioni del mondo arabo… Però la rinascita la stiamo ancora aspettando. Ci sono stati dei movimenti che annunciano un XXI secolo di conflitti e di lotte, di guerre e di rivoluzioni, però non c’è nulla che si possa paragonare a quel che è stato il comunismo nel XX secolo o il socialismo nel XIX secolo. Non è venuta fuori una nuova utopia, non è venuto fuori un nuovo progetto con un profilo riconoscibile e che sia in grado non dico di federare ma insomma di costituire un orizzonte per questo insieme di movimenti che ho indicato. Uno dei tratti salienti della situazione degli ultimi dieci anni è l’emergenza di tutta una serie di movimenti che hanno presentato fortissime potenzialità, inventività, creatività, sperimentazione di pratiche nuove, con una circolazione di idee straordinaria, ma che sono stati incapaci, tranne pochissime eccezioni, di strutturarsi in maniera stabile. Non si può dire che la debolezza di questi movimenti sia legata ad una insufficienza di riflessione critica o a limiti teorici. I quali sicuramente esistono, ma se pensiamo a cos’è oggi la produzione di pensiero critico in Europa e negli Stati uniti, in America latina o in Asia, non c’è paragone con il 1917!
Questi movimenti sono molto più “intelligenti”, molto più analiticamente profondi però sono movimenti effimeri, deboli, strutturalmente incapaci di proiettarsi nel futuro. E questa è una delle loro carenze ontologiche: questi movimenti sono nell’incapacità oggettiva di inscriversi in una continuità storica, da cui il loro carattere effimero. Sono fiammate. E questa è una differenza enorme rispetto al comunismo del XX secolo, un movimento che ha conosciuto sconfitte tragiche, disfatte terribili, massacri, ma che era in grado di risollevarsi perché tutti i protagonisti di questa vicenda erano coscienti di appartenere a un movimento che trascendeva il loro destino individuale. Erano un frammento di una forza che li superava, che li orientava e che li ispirava: `questa è la forza straordinaria che ha avuto il comunismo nel XX secolo e che non vedo oggi. In un certo senso si può dire che tutti questi movimenti sono culturalmente subalterni a un orizzonte antropologico che è quello del neoliberalismo. Quindi la precarietà della vita, l’assenza di un futuro, il presentismo, il vivere in un mondo rinchiuso nel presente… questo è un limite che abbiamo interiorizzato e che è diventato una specie di habitus mentale, antropologico di questo inizio di XXI secolo e che si è imposto agli stessi movimenti. Secondo me questo è il problema fondamentale.
Come si colloca il 1917 in questa articolazione temporale, in questa idea di storia?
La rivoluzione è al contempo un evento e un processo. È una rottura che presenta caratteri esplosivi, come la fissione dell’atomo – per dirla con una metafora benjaminiana – che sprigiona energie inimmaginabili. Una rottura che crea una situazione completamente nuova, l’evento che diventa autonomo, un evento che ha sicuramente le sue premesse che si possono studiare a posteriori ma anche un evento che le trascende, che crea una dinamica che non è riconducibile deterministicamente alle sue cause. Però la rivoluzione è al contempo un processo. Bisogna quindi vedere che cosa si intende per “Ottobre”: se intendiamo per Ottobre l’evento, con questo carattere fulmineo, dirompente, la “fissione dell’atomo”, o la rivoluzione come processo. Io penso che sia entrambe le cose, però a seconda della prospettiva che si adotta l’interpretazione della rivoluzione cambia. Io per esempio ho abbandonato una visione che aveva modellato il mio modo di vedere la storia per anni, eredità della mia formazione trockijsta che contrapponeva la rivoluzione bolscevica, quindi Lenin e Trockij, e la controrivoluzione staliniana. Se studiamo la rivoluzione russa come processo si possono distinguere due tappe. Perché i soviet del 1917 e poi durante la guerra civile non sono certo la stessa cosa del regime stalinista degli anni trenta: non sono la stessa cosa, è evidente, eppure c’è continuità tra i due. Ci sono mille fili che legano la rottura di Ottobre allo stalinismo degli anni trenta. C’è una continuità rivendicata non in modo del tutto illegittimo da parte di Stalin, e c’è un mutamento che non è una controrivoluzione. Perché lo stalinismo non è la restaurazione dell’antico regime. Sì, è la restaurazione di tendenze grandi-russe, nazionaliste, di forme di assolutismo autocratico che portano le tracce del passato zarista, però lo stalinismo è la costruzione di una società nuova le cui premesse sono nella rivoluzione. Lo stalinismo non è la restaurazione del capitalismo, la restaurazione della vecchia aristocrazia russa. Lo stalinismo è un prodotto della rivoluzione che ha mille fili che lo legano alle lotte anticoloniali, alla Resistenza, alla storia del comunismo nelle sue diverse dimensioni. La lettura dei lavori di storici come Sheila Fitzpatrick o Stephen Kotkin mi ha fatto cambiare idea, e oggi sono convinto che Isaac Deutscher abbia colto le tendenze generali, benché si sia fatto delle enormi illusioni a proposito della destalinizzazione.
Questa storicizzazione necessaria dello stalinismo, possibile oggi perché lo stalinismo non esiste più, non è un problema di conflitti politici tra correnti eretiche ed il comunismo ufficiale, questo è un problema ormai risolto e superato nei fatti. Ma questa storicizzazione non si può certo sospettare di intenti apologetici: non si tratta di riabilitare lo stalinismo ma di capire per esempio perché le eresie comuniste non hanno funzionato. Perché la fine del comunismo non è stata come alcuni speravano la rimozione di un enorme ostacolo e la rinascita del comunismo autentico. La fine del comunismo nel 1989 è stata la presa di coscienza della sconfitta delle rivoluzioni del Novecento, per il legame simbiotico che avevano con il regime nato dall’Ottobre.
Quindi la malinconia di sinistra di cui parlo ha anche una componente nostalgica – la nostalgia fa parte della struttura dei sentimenti del socialismo, come dice Raymond Williams – ma questa nostalgia ovviamente concerne l’evento e non il regime e non il processo. La malinconia è la memoria della rivoluzione come momento emancipatore, liberatore, come scatenamento delle energie liberate dalla “fissione dell’atomo”. La malinconia è il ricordo di momenti magici in cui gli oppressi diventano attori della storia, prendono in mano il loro destino e cambiano il mondo. La storia degli ultimi due secoli è una storia di questi capovolgimenti, rovesciamenti. Mi piace vederla come una dimensione chagalliana, come i personaggi dei quadri di Chagall – un attore della rivoluzione in campo estetico subito dopo Ottobre – che fluttuano nell’aria, che sono sospesi nel vuoto. Ecco, la rivoluzione è un po’ questo: ci sono una serie di costrizioni sociali, culturali, psicologiche… Freud e Elias lo definirebbero il “processo di civilizzazione”. La rivoluzione è il momento in cui si ha l’impressione di poter vincere le leggi di gravità e realizzare quello che in condizioni normali sembra impossibile. La malinconia si riferisce a questa dimensione della rivoluzione. Però l’Ottobre pensato storicamente è indissociabile dal processo che segue.
Rispetto all’Ottobre, e tenendo in mente quelle tre prospettive con cui apri il libro sulla guerra civile (A ferro e fuoco. La guerra civile europea, 1914-1945, il Mulino, 2008), e cioè la teoria politica, la storia sociale e la storia culturale, che sono poi da sempre i tuoi assi di ricerca, in che modo articoli il rapporto tra il paradigma della guerra civile, l’ethos della guerra civile e l’Ottobre: quanto quel tipo di ethos è costitutivo dell’evento e anche del processo che apre?
Intanto bisogna ancora una volta precisare metodologicamente alcune questioni. Se riprendiamo la distinzione braudeliana tra l’evento, il ciclo e la lunga durata, che mi sembra metodologicamente fruttuosa, Ottobre è l’evento, il ciclo varia a seconda delle regioni e delle aree geopolitiche e la lunga durata è il Novecento. Io sono molto attento alle considerazioni metodologiche che fa Jürgen Osterhammel nella sua storia dell’Ottocento (The Transformation of the World: A Global History of the Nineteenth Century, Princeton UP, 2014). Se vogliamo scrivere una storia globale dell’Ottocento, le frontiere cronologiche sono aperte, perché è un secolo che non nasce nello stesso momento in diverse parti del mondo, che apre processi che si concludono in momenti diversi a seconda delle aree geopolitiche e culturali. Per esempio in Europa c’è un ciclo che si apre con la Grande Guerra e l’Ottobre e si conclude nel 1945: ma visto nella lunga durata, l’Ottobre apre una sequenza che si conclude nel 1989-90. Quindi il comunismo può essere pensato in queste tre dimensioni: come evento, come ciclo e come epoca. Si inscrive in queste tre diverse temporalità storiche.
C’è però una matrice legata all’evento che mi sembra caratterizzare tutta la sequenza, pur con mutamenti e trasformazioni. Ed è il paradigma militare della rivoluzione, che è fortissimo dal principio, dal 17 al 45, e si prolunga nel Sud. Le rivoluzioni sono modellate, strutturate, articolate, sia in Asia che in America Latina, intorno a questo paradigma militare scaturito dalla simbiosi tra guerra e rivoluzione. Si tratta di un lascito della Grande Guerra e questo è un po’ il codice genetico del comunismo. La rivoluzione era vista come presa del potere, e la presa del potere era pensata in termini militari, tattico-strategici. Il comunismo era un movimento politico che si organizzava come un esercito di soldati che lottavano per la rivoluzione. Da questo punto di vista la percezione che ne hanno avuto alcuni liberali di sinistra come Bertrand Russell che paragonava il bolscevismo all’islam delle origini era un’intuizione non arbitraria, coglieva degli elementi reali: c’era una dimensione religiosa, nel senso delle religioni secolari del XX secolo. Il comunismo era un progetto politico, si fondava su una filosofia della storia e su un’analisi dell’economia e della società, aveva la pretesa in molte sue componenti di essere una scienza della società e della storia (c’è una componente positivista fortissima nel marxismo di quegli anni) però la forza di questo movimento era anche quella di una “fede”. Si aderiva al comunismo perché il comunismo incarnava il futuro e quindi si voleva partecipare alla costruzione del futuro ed era un movimento che riusciva a materializzare attese messianiche fortissime. Ricorrendo a una formula di Reinhart Koselleck, potremmo parlare di una “secolarizzazione inconscia di aspettative escatologiche”. E questa forza, che i comunisti italiani chiamavano la “forza propulsiva”, si dispiega su tutto il Novecento. Io ho conosciuto dal di fuori, dall’estrema sinistra, il comunismo degli anni settanta, che non era più rivoluzionario. In Italia il partito comunista era una grande forza politica e si proiettava come forza di governo (insomma col Pci non si discuteva della strategia e dell’insurrezione armata), però il movimento comunista continuava ad essere impregnato da queste attese messianiche. Senza parlare di altri continenti dove la rivoluzione si faceva. Pensare la rivoluzione attraverso un paradigma militare aveva tutta una serie di conseguenze in termini di gerarchie, di disciplina e discussione interna, in termini anche di genere.
Questa visione del comunismo è probabilmente molto più ricca di quanto non ci sia apparsa per lungo tempo: la storiografia del comunismo era occidentale, la teoria e le idee venivano dall’Europa essenzialmente. Per lungo tempo si è sottovalutata la capacità del comunismo di presentarsi per la prima volta nella storia come un’utopia globale. L’Ottobre russo è stato il punto di partenza della decolonizzazione del Novecento, le rivoluzioni coloniali sono nate dalla rivoluzione. Le rivoluzioni atlantiche – la rivoluzione americana, la rivoluzione francese, la rivoluzione haitiana – erano state parte di una dinamica globale: ma durante tutto l’Ottocento la rivoluzione haitiana è stata rimossa dall’immaginario, dal pensiero critico. Il socialismo si costruisce come una filosofia della storia e come un progetto di trasformazione del mondo che ha un centro in Europa, nei paesi capitalisticamente avanzati, un soggetto storico che è la classe operaia industriale, e la classe operaia industriale significa soprattutto l’Europa protestante, ma significa anche un soggetto di genere (maschio, bianco, europeo). È la rivoluzione d’Ottobre che rompe, almeno in parte, questo modello e apre la prospettiva di una rivoluzione internazionale come rivoluzione di classe, dei popoli colonizzati, dei popoli oppressi, delle razze sottoposte al dominio imperialista. È una rottura in termini teorici, pratici, e nell’immaginario collettivo. Il comunismo visto nelle sue diverse dimensioni può essere ricondotto a queste tre temporalità (evento, ciclo, lunga durata) sapendo che l’articolazione può variare a seconda dei continenti.
La disgiunzione, l’opposizione etica amico/nemico è del tutto inscritta in questo paradigma militare oppure trova lì la sua matrice per poi eccedere quella prospettiva come piano di immanenza etico, come divisione, come contrapposizione e costituzione del politico?
Secondo Schmitt, la dicotomia amico/nemico si inscrive nella sfera autonoma del politico ed è distinta dall’etica. Schmitt è certo uno dei grandi pensatori politici del Novecento ma è un reazionario, un fascista. La sua definizione presenta delle evidenti affinità sia con la concezione marxista della lotta di classe, sia con la visione bolscevica della rivoluzione come conflitto violento, armato, tra rivoluzione e controrivoluzione: la rivoluzione insomma come processo indissociabile dalla guerra civile. Si tratta di un’idea già presente in Marx, elaborata dopo il ’48 e soprattutto dopo la Comune di Parigi; un’idea che è stata ripresa da Lenin in Stato e rivoluzione e poi radicalizzata da Trockij in Terrorismo e comunismo in termini parossistici, durante la terribile guerra civile seguita alla rivoluzione russa. Se leggiamo questi classici del marxismo possiamo vedere perlomeno una simmetria con il pensiero della controrivoluzione. Rivoluzione e controrivoluzione sono radicalmente opposte l’una all’altra ma pensano in termini simmetrici la storia come conflitto. Durante la sequenza storica aperta dalla grande guerra e segnata dall’Ottobre, il pensiero politico più interessante è quello della rivoluzione e della controrivoluzione, cioè Gramsci, Trockij, Lenin, Rosa Luxemburg da un lato e dall’altro Schmitt, Jünger, Mussolini, ecc. Il pensiero liberale di quegli anni è povero, superato dagli eventi; riapparirà dopo la seconda guerra mondiale, col welfare state, la guerra fredda, la prosperità occidentale, quando diventerà possibile pensare alla democrazia liberale in termini di pluralismo, di etica della discussione, di agire comunicativo. Tutta la panoplia concettuale di Rawls, Habermas e Bobbio non funziona durante il ciclo di rivoluzione e controrivoluzione della guerra civile europea. Non funziona in America latina dopo la rivoluzione cubana. E neppure in Asia tra gli anni venti e gli anni settanta: le guerre rivoluzionarie in Cina e in Vietnam, la guerra di Corea, il terribile massacro dell’Indonesia… Il liberalismo classico non è molto utile per pensare queste vicende. Questa constatazione non significa che il paradigma militare della rivoluzione abbia neutralizzato la dimensione etica del comunismo, perché in realtà tutta la sua storia è costellata da dilemmi etici fondamentali: pensiamo ai processi di Mosca, allo stalinismo, a quel che scrive alla fine degli anni venti Victor Serge, uno dei primi pensatori di sinistra a concepire il totalitarismo come forma possibile di una tirannia che nasce dentro il comunismo. Pensiamo alla polemica tra Serge e Trockij: se vogliamo costruire una società di liberi ed uguali, possiamo crearla uccidendo gli ostaggi, creando la Ceka, accettando forme di giustizia extra-legali? È possibile far nascere dalla guerra civile, con la violenza che questa implica, una società libera? Questo problema si è posto anche durante la Resistenza e, per molti versi, è insolubile: organizzare attentati significa provocare le rappresaglie le quali colpiscono i civili. Tuttavia non possiamo rimanere passivi per timore delle rappresaglie. Ma allora, come dobbiamo agire? In quali circostanze la violenza è non solo legittima ma necessaria e in quali circostanze diventa dannosa? Questi dilemmi etici sono indissociabili dalla definizione della politica come lotta, conflitto, scontro che può assumere anche una forma violenta. Volevo insomma precisare che, a differenza della tesi di Schmitt, non esiste una politica totalmente dissociata dall’etica, benché la politica non possa essere dedotta dall’etica. Chi ha tentato questa via — penso a Camus o Ricœur durante la guerra d’Algeria — non ha ottenuto risultati molto brillanti. Altri, come Einstein o Simone Weil, si sono resi conto dei limiti di questa posizione e hanno accettato la violenza come scelta ineludibile. Altri, come Jean Améry e Frantz Fanon, hanno apertamente rivendicato la dimensione non soltanto emancipatrice, ma anche rigeneratrice, della violenza. È una discussione infinita, ma questo dilemma non si pone mai in termini astratti, si traduce sempre in scelte concrete.
Il tuo lavoro è sempre molto attento alla dimensione globale. Sei stato forse tra i precursori, tra quelli che per primi hanno avuto l’attenzione di uscire da un guscio centrato sull’Europa, su una vicenda che erroneamente è stata letta fino a qualche decennio fa come autonoma rispetto a una vicenda più ampia, e nel libro ci sono pagine molto belle sul mancato incontro tra il marxismo occidentale e il black marxism. Quando prima facevi riferimento alla seconda Scuola di Francoforte mi veniva in mente questo mancato incontro a cui ti riferisci e che rileggi dal presente, immaginando come avrebbe potuto essere…
Fai riferimento a un capitolo del libro centrato sul dialogo appena abbozzato e immediatamente naufragato tra il marxismo occidentale e il Black Marxism – così come l’ha definito Cedric Robinson (Black marxism. The making of the black radical tradition, North Carolina UP 1983) – ma potremmo dire il marxismo delle rivoluzioni anticoloniali. Questo vale anche per l’operaismo, non solo per la Scuola di Francoforte: quando Tronti dice con orgoglio “non siamo mai stati cinesi” ammette implicitamente che la sua corrente di pensiero ha sostanzialmente ignorato le rivoluzioni che stavano cambiando la faccia del mondo. La sua attenzione era rivolta esclusivamente a quel che l’operaismo considerava il momento avanzato del conflitto, ossia la classe operaia industriale del capitalismo fordista, “Lenin in Inghilterra”, non in Russia. Ma quello era un momento in cui le rivoluzioni si stavano dispiegando nel sud del mondo. Gli operaisti non sono stati i critici più acuti della rivoluzione culturale cinese o delle derive totalitarie dei Khmer Rossi in Cambogia. Se vogliamo storicizzare il marxismo e il comunismo, i limiti li troviamo dappertutto. L’operaismo è stato estremamente ricco sul piano teorico. Pensare il movimento operaio attraverso le sue articolazioni sociali e non attraverso le sue rappresentazioni politiche è un approccio che permette di cogliere aspetti generalmente ignorati dalla tradizione comunista dominante. Allo stesso tempo, l’operaismo ha i suoi limiti, come il trockijsmo o altre correnti. Dopo la sconfitta delle rivoluzioni del Novecento è più facile coglierli e inscriverli dentro una sequenza di cui si possono vedere oggi l’inizio e a la fine.
C’è un tuo libro che nell’edizione francese s’intitola La storia come campo di battaglia (Il secolo armato. Interpretare le violenze del Novecento, Feltrinelli, 2012) dove tocchi alcuni tra i dibattitti storiografici forse più salienti degli ultimi cinquanta anni. Quali sono le tendenze, gli elementi più significativi del 17 dopo il 17 e come li leggiamo, consapevoli come siamo che la storia non si oppone così radicalmente come Pierre Nora voleva farci credere alla memoria ma che c’è invece una matrice di memoria, e quindi di politica, anche nell’immaginazione storica e nel lavoro più rigoroso? Che è poi il punto di tensione di tutta la pratica storiografica.
Il problema del 17 dopo il 17 è un problema che si è posto e al quale ha tentato di rispondere Gramsci nei Quaderni. Il 17 dopo il 17 è anche l’illusione che questo modello possa funzionare come modello universale. Ed è anche la ragione per cui dopo la caduta del comunismo alla fine del Novecento questo modello è stato quasi integralmente respinto. Dirsi bolscevichi oggi è un inguaribile anacronismo o una specie di vezzo, come Tronti che vota il Job Acts da senatore ma vorrebbe farci credere che il partito democratico sia l’erede del partito bolscevico (questa è la parte di storicismo dell’operaismo italiano). D’altra parte, la fine del comunismo – e questa è una delle conseguenze fruttuose del mutamento intellettuale che ne è derivato – ha permesso di scoprire tradizioni che il comunismo aveva occultato o emarginato.
Per esempio oggi la Comune di Parigi viene ripensata in termini molto diversi da come si è fatto durante tutto il Novecento. Non è più la prefigurazione dell’Ottobre russo. La Comune – e mi sembra che questa sia una lettura storicamente più pertinente – non si inscrive più in una continuità storica teleologica: la prima tappa nel cammino verso la rivoluzione, il socialismo, il comunismo. La Comune di Parigi è un’esperienza di autoemancipazione effimera e meravigliosa nel suo carattere fulmineo e precario: è un’invenzione che non ha nessuna causalità deterministica e che apre prospettive diverse. Coesistono tendenze molto diverse nel suo seno e oggi la scopriamo molto vicina a una certa sensibilità che è quella delle forme di vita del XXI secolo. La Comune di Parigi non è un tentativo di costruzione di un potere proletario da parte degli operai della grande industria, che non esiste a Parigi nel 1871. Quando si studia la Comune di Parigi e si scopre che c’è dentro il ruolo della bohème, vale a dire di una intellighenzia di origine non aristocratica ma di borghesi che hanno rinnegato le loro origini o di scrittori e artisti di origini modeste. Che la Comune è stato un esperimento sociale al quale hanno dato vita dei lavoratori precari, questo proletariato sociologicamente molto eterogeneo, frammentario, tipico della Parigi della seconda metà dell’Ottocento. Si scopre l’assenza di un inquadramento ideologico, c’è una sensibilità piuttosto libertaria, anarchica se vogliamo; un socialismo che non ha nessuna connotazione ideologica codificata; ci sono tendenze come i blanquisti, quindi un volontarismo estremamente forte… Sono tutte caratteristiche che sembrano molto attuali, che ci fanno pensare a quel che si muove nel mondo di oggi. Una precarietà, un’eterogeneità, una “liquidità” del mondo sociale – per parlare con Zygmunt Bauman – che non è quella di una società preindustriale o quella della prima industrializzazione ma è quella di una società postindustriale. Però c’è una risonanza intellettuale, politica che mi sembra molto forte. Quindi capisco perfettamente che la tendenza sia, chiusa l’esperienza comunista, quella di riscoprire la prima internazionale, che è una federazione di partiti, movimenti, sindacati, personalità indipendenti, che non ha un’ideologia dominante, ufficiale: questo è quello di cui abbiamo bisogno oggi. Ma allo stesso tempo bisognerebbe anche riconoscere che l’esperienza comunista non è stata una parentesi sbagliata, una degenerazione o una deformazione, per cui ora si ritorna alle radici autentiche. L’esperienza comunista si è conclusa come sappiamo ma è stata un tentativo molto serio di rispondere alle esigenze dell’epoca e superare i limiti del socialismo dell’Ottocento, limiti che tra l’altro la Comune di Parigi aveva messo chiaramente in evidenza. Nel suo libro Communal Luxury: The Political Imaginary of the Paris Commune (Verso, 2016), Kristin Ross vorrebbe congedare sia la lettura repubblicana che quella bolscevica della Comune di Parigi. Tuttavia bisognerebbe chiedersi perché la Comune era così ossessivamente presente nella riflessione dei bolscevichi durante la guerra civile. Il fatto è che la Comune di Parigi si è conclusa con un massacro e i bolscevichi avevano in testa questa esperienza e temevano che la rivoluzione russa si concludesse allo stesso modo, cosa che era una possibilità perfettamente inscritta nelle condizioni dell’epoca. Bisognava evitare di ripetere la sconfitta della Comune di Parigi, e far sì che il regime sovietico fosse invece una Comune di Parigi vittoriosa. La guerra civile russa segue il massacro della rivoluzione spartachista a Berlino, la sconfitta della repubblica dei consigli in Baviera e in Ungheria, questo è il contesto. Non possiamo soltanto sorridere o adottare un atteggiamento di pietosa superiorità nei confronti dei bolscevichi che guardano alla Comune. La storia della Comune è molto interessante e anche ricca di insegnamenti: evacuare la storia del comunismo come un’esperienza che va solo dimenticata e per quanto possibile sotterrata in modo da neutralizzarla mi sembra un approccio non solo sbagliato ma pericoloso. Il problema di fondo che ci troviamo di fronte, come dicevo all’inizio, è quello di costruire un progetto nuovo sapendo che sarà diverso rispetto al comunismo ma storicizzando il comunismo, raccogliendo, elaborando la memoria dell’esperienza comunista, sapendo che elaborare la memoria del comunismo è un Trauerarbeit, è un’elaborazione del lutto delle rivoluzioni del Novecento. Ma non credo che saremo in grado di fare delle rivoluzioni nel XXI secolo dimenticando quelle precedenti. Il fatto che le rivoluzioni arabe avessero come unico modello il 1789 non era un elemento di forza, era un elemento di debolezza, anche se è chiaro che non potevano riprodurre un modello bolscevico o comunista.
Che cosa rimane di tutto il dibattito degli anni novanta, visto trent’anni dopo: il bicentenario della rivoluzione francese, lo scontro Hobsbawm-Furet… Riprendendo proprio Hobsbawm recentemente mi ha stupito il modo liquidatorio con cui tratta per esempio gli spartachisti, appunto perché hanno fallito.
Il libro di Hobsbawm sul Novecento (Il secolo breve, Rizzoli 1995) parte dalla premessa che il comunismo è fallito e conclude che non poteva finire diversamente, perché il suo fallimento era inscritto nelle sue premesse. Quando dice che il comunismo in Russia non poteva essere altro che una “forma di dispotismo asiatico tinto di rosso”, scrive come uno storico che ha interiorizzato la sconfitta. Ma Hobsbawm rimaneva biograficamente legato a questa esperienza e voleva salvare la memoria del comunismo nonostante il suo tragico epilogo. Alla fine Hobsbawm cosa dice? Che il comunismo era condannato a fallire ma era storicamente necessario — questo è il suo approccio apologetico – perché ci ha salvati da Hitler e perché ha costretto il capitalismo a umanizzarsi. Su questo punto sono d’accordo con lui. L’Unione sovietica ci ha salvato da Hitler, sacrificando più di venti milioni di esseri umani nella lotta contro il nazismo, una dimensione che spesso è rimossa dalla memoria occidentale. È vero anche che il capitalismo si è “umanizzato” perché posto di fronte all’alternativa comunista, e una volta che questa alternativa è caduta esso è ridiventato selvaggio. Per la prima volta, in un mondo che non è mai stato così ricco, tutti riconoscono che le nuove generazioni saranno più povere di quelle che le hanno precedute, le loro condizioni di vita saranno peggiori. La socialdemocrazia di oggi non ha più niente a che vedere con quella del dopoguerra che ridistribuiva la ricchezza, creava lo stato sociale e l’università di massa. La socialdemocrazia di oggi è la trojka che impone l’austerità alla Grecia e promulga leggi che precarizzano le nuove generazioni. Da questo punto di vista, Hobsbawm ha ragione. Il problema è che in fondo ti dice: sì, siamo stati generosi, è stata una bella esperienza, ci abbiamo messo passione e coraggio ma non c’è niente da fare, non si può cambiare il mondo. Questo è il problema degli anni novanta, che sono il decennio in cui si prende coscienza della sconfitta e della conclusione di una sequenza storica. Ma questa sconfitta implica inevitabilmente la vittoria del capitalismo sul piano culturale, ideologico…
…antropologico…
…sul piano antropologico. La seconda metà degli anni ottanta in Italia sono gli anni di incubazione del berlusconismo. Sono gli anni in cui «la Repubblica» aveva inventato la formula dell’“azienda Italia”. Riesci a immaginare negli anni settanta parlare di «azienda Italia», nel momento in cui le fabbriche sono occupate? Negli anni ottanta, il capitalismo ha vinto come modello culturale, antropologico, di individualismo competitivo, possessivo, il capitalismo come forma di vita. Tra gli anni ottanta e gli anni settanta c’è una cesura radicale.
Sono gli anni dell’affermarsi del paradigma presentista. Non ti sembra che la tesi di François Hartog (Regimi di storicità, Sellerio, 2007) rischi di apparire in qualche modo compiaciuta dell’esistente? In che misura pone un problema nel momento in cui non considera tutto ciò che sfugge, che si organizza, anche al di fuori della centralità del mondo occidentale? Ho l’impressione che pur nella sua estrema raffinatezza, il presentismo di Hartog abbia una sorta di retrogusto compiaciuto nei confronti del presente… Condividi questa sensazione?
Io condivido la tua ammirazione per il lavoro di Hartog e non mi sembra che questo compiacimento nei confronti del regime di storicità presentista sia immediatamente deducibile dai suoi libri. Ma forse una certa subalternità al presentismo è implicitamente inscritta nel suo modo di lavorare. Ho visto in questi giorni che Hartog è un entusiasta difensore di Emmanuel Macron, e questo in un certo senso conferma la tua perplessità o il tuo disagio.
In che misura Hartog si discosta da Fukuyama?
Leggendo i suoi lavori, la formulazione della sua idea di presentismo non appare ispirata da un desiderio di idealizzare l’ordine dominante. Scrive da storico. E l’idea di un regime di storicità presentista mi sembra che catturi bene lo stato delle cose. Probabilmente proprio perché la sua preoccupazione non è una critica del neoliberalismo la sua analisi non va molto lontano. Si ferma alla descrizione di un regime di storicità ossia di una percezione e rappresentazione del tempo, che è quella del mondo di oggi rinchiuso nel presente. Io cerco di andare un po’ oltre questa definizione e la ricollego al concetto di storia di Koselleck, che ha teorizzato la storia come un rapporto simbiotico tra il passato e il futuro in cui il presente è solo il momento di connessione tra il campo di esperienza e l’orizzonte d’attesa. Se adottiamo il concetto di presentismo come regime di storicità che corrisponde al mondo di oggi allora dobbiamo riconoscere che la dialettica storica teorizzata da Koselleck si è rotta e che un mondo rinchiuso nel presente è un mondo incapace di proiettarsi nel futuro. E questo va ricollegato a un ordine socio-economico dominante, che è quello del capitalismo neoliberale, che ci ha sottoposti a un regime di accelerazione permanente e parossistico, dove tutto cambia molto rapidamente e ci dà l’illusione di un mondo che sta correndo verso il futuro ma si tratta di un’accelerazione permanente rinchiusa dentro un ordine economico e sociale fisso. Un’accelerazione permanente che riconosce come insormontabili le barriere del capitalismo. Il regime di storicità presentista nasce dalla naturalizzazione del capitalismo, che è in fondo la più terribile sconfitta del comunismo.
Che è però la fine della storia…
È la fine della storia se si accetta l’idea che il presentismo sia ineluttabile e che non ci sia più nulla da fare. La fine del Novecento ha avviato una fase di dominio assoluto del capitalismo nella sua forma neoliberale. Se vogliamo storicizzare, nel XX secolo c’è una forma totalitaria che è certo orribile, e nel XXI secolo c’è una forma neoliberale che socialmente è anche più devastante, ma che non ha preso le forme dell’universo concentrazionario e dei campi di sterminio, anche se significa guerre e violenza in alcuni continenti. La fine del comunismo ha sotterrato, credo definitivamente, ogni visione teleologica della storia e l’idea della fine della storia è stata criticata sin dall’inizio, quando venne formulata da Fukuyama nell’89. Il problema oggi non è tanto quello di cercare di convincere la gente che bisogna muoversi, agire, organizzarsi, mobilitarsi, perché questo avviene in tutto il mondo. Abbiamo superato la fase della passività, non siamo più paralizzati come all’inizio degli anni novanta, quando Hobsbawm scrisse Il secolo breve, sotto shock di fronte al carattere immane della sconfitta. Il problema è che è già trascorso un quarto di secolo e non è venuta fuori una prospettiva comune. Tutti questi movimenti sono dei rivoli, delle fiammate che stentano a costruirsi. In un mondo che è completamente integrato, c’è una trama che lo unifica e che fa sì che le idee circolino molto più rapidamente di quanto avvenisse in passato, insomma non c’è più bisogno dell’Internazionale comunista per collegare movimenti in paesi e continenti diversi. Oggi questo avviene attraverso internet e paradossalmente rende la comunicazione molto più rapida e più efficace. Eppure non c’è una prospettiva comune, non c’è un collegamento organico, non c’è la capacità di creare un movimento all’altezza dei problemi della nostra epoca. E questo è un limite enorme. C’è una nuova generazione che non è ancora riuscita a produrre questa convergenza e una vecchia che non è riuscita a gestire il passaggio da un secolo all’altro. Parlavamo di modelli antropologici: le nuove generazioni hanno interiorizzato la precarietà, l’eterogeneità, la frammentarietà, il carattere effimero del mondo di oggi. E le vecchie – tra cui la mia – che non sono state capaci di gestire il passaggio da un secolo all’altro (chiedendosi cosa non ha funzionato, di cosa abbiamo bisogno). Non sono riuscite ad allacciare esperienze diverse costruendo una continuità storica che non sia più legata all’illusione teleologica del socialismo, del comunismo classico, ma che sia una continuità fatta di trasmissione di esperienze e di riflessione critica. Questo è mancato. Il pensiero critico di oggi non è più organicamente legato ai movimenti sociali e politici come avveniva in passato, basti pensare al nesso che esisteva tra i libri di Frantz Fanon, la loro ricezione e il ruolo che egli ha svolto in Algeria. Non è una cosa da poco. Da un lato gli studi postcoloniali dominano le università e, dall’altro, sono rimasti drammaticamente assenti nelle rivoluzioni arabe. Vuol dire che c’è una discrepanza fortissima tra l’elaborazione del pensiero critico e la costruzione dei movimenti sociali, che questo pensiero non è capace di tradursi in azione.