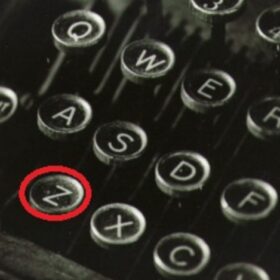Il 25 luglio, al termine di un’intensa giornata di proteste in tutto il paese, il presidente della repubblica tunisina Kaïs Saïed ha sospeso l’attività parlamentare e destituito il primo ministro. Un episodio che ha destato preoccupazione a livello internazionale, appannando l’immagine dell’«unica democrazia» emersa dalle cosiddette primavere arabe. Come per le rivolte di gennaio scorso, l’attuale crisi politico-istituzionale e i suoi possibili esiti si prestano a molteplici letture. Abbiamo chiesto ad Andrea Calabretta della redazione di «Zapruder» di darcene un’interpretazione a caldo.
Appunti sulla crisi del 25 luglio e sul suo passato
di Andrea Calabretta
Nella notte tra il 25 e il 26 luglio 2021 l’attenzione mediatica internazionale si è nuovamente concentrata sulla Tunisia e questa volta non per riportare la notizia di un ennesimo naufragio di migranti.
A fare notizia è stata la decisione del presidente della repubblica, Kaïs Saïed, d’invocare l’articolo 80 della Costituzione per bloccare le attività parlamentari e arrivare alla formazione di un nuovo governo. La decisione, arrivata dopo una pessima gestione dell’emergenza sanitaria da parte dell’esecutivo e alla fine di un’intensa giornata di proteste in tutto il Paese, ha allarmato media e cancellerie internazionali, abituati a etichettare la Tunisia come unica democrazia nata dalle “primavere arabe”. Diversi leader politici europei, così come molta stampa mainstream, partendo da una prospettiva nettamente eurocentrica e che vede nella democrazia liberale occidentale l’unico tipo di democrazia possibile, hanno condannato immediatamente la decisione di Saïed e nelle giornate successive al 25 luglio si sono susseguiti inviti per un “ritorno all’ordine”.
Un decennio di promesse mancate
Senza negare la problematicità delle modalità e del contenuto delle decisioni presidenziali, occorre necessariamente situarle in un contesto più ampio per coglierne la genesi e l’impatto sulla Tunisia di oggi. Questo sforzo ermeneutico deve iniziare dal periodo della rivoluzione quando le richieste economiche e sociali delle zone più depauperate della Tunisia, già insistenti sin dai moti di Gafsa del 2008, si fondono con le proteste della classe media nel resto del Paese, soffocata dalla repressione poliziesca e in difficoltà per l’aggravarsi della crisi economica. Quest’effimero blocco storico riuscirà nei primi giorni del 2011 ad abbattere il regime benalista, mancando però dell’organizzazione e della forza politica per toccare nel profondo il sistema di potere tunisino.

Infatti nel giro di qualche mese, nonostante il tentativo di riprendere le proteste e nonostante le diverse crisi attraversate dal Paese, la fase post-rivoluzionaria si risolve in una transizione controllata, i cui risultati sono un allargamento del campo politico agli islamisti moderati di Ennahdha e la costruzione di un sistema liberal-democratico, garante dei diritti civili e politici ma poco impegnato nell’allargamento dei diritti economico-sociali, nonostante il dettato progressista della nuova Costituzione del 2014. Quest’ultima, frutto di un delicato compromesso tra le posizioni presidenzialiste dei partiti liberali e nazionalisti e quelle parlamentariste di Ennahdha, stabilisce un sistema semipresidenziale in cui i confini tra le diverse istituzioni appaiono poco chiari e che viene completato da una legge elettorale proporzionale che garantisce ampia rappresentanza ma anche forte frammentazione nell’Assemblea legislativa.
In questo quadro inizia il percorso della “nuova” Tunisia liberal-democratica. Un percorso che al vertice politico vede il susseguirsi di governi di grande coalizione, unica possibilità di fronte alla frammentazione partitica e giustificati in nome dell’unità del Paese. Nei pochi anni che seguono la rivoluzione, tra governi balneari, di transizione e rimpasti, cambiano centinaia di ministri e sottosegretari, dando l’impressione che il sistema politico abbia prodotto una vasta élite, rapace e disinteressata alle problematiche della popolazione. Ad aumentare il senso di collusione del sistema è anche la discrepanza tra una retorica politica che continua a giocarsi sul clivage identitario tra islamisti e anti-islamisti e una pratica di governo votata al compromesso costante.
Le grandi aspettative di giustizia sociale iscritte nella rivoluzione si scontrano così con l’inerzia di un sistema politico che fa da contraltare alle crescenti disuguaglianze, ereditate dal periodo pre-rivoluzionario ma approfondite dagli shock esterni (attentati terroristici, covid) che mettono in ginocchio anche i settori più solidi dell’economia tunisina: il turismo e l’industria leggera. La disoccupazione cresce ad ogni rilevazione ed è stimata attualmente al 18% per la popolazione generale e al 40% per gli under 29 mentre l’ingresso nel mondo del lavoro passa nella stragrande maggioranza dei casi attraverso il settore informale e la sottoccupazione. Ma ad aggravare ulteriormente la situazione è la costante inflazione, sempre superiore al 5% annuo a partire dal 2012 e il crollo del dinaro nei confronti dell’euro (valuta necessaria per pagare l’importazione di molti beni essenziali) che porta ad una crescita del numero dei lavoratori poveri. Lo stipendio medio in Tunisia, stimato intorno ai 640 dinari mensili (poco più di 200 euro) a fronte della crescita dei prezzi dei beni al consumo non permette ormai altro che la sussistenza.
La crisi del 25 luglio
Non stupisce dunque l’elezione di Saïed alla presidenza della repubblica nel 2019, sulla base della sua fama di incorruttibile e di un programma di riforme istituzionali volte ad avvicinare il corpo elettorale alle istituzioni. Mentre l’elezione di Saïed veniva festeggiata in avenue Burghiba, nel centro di Tunisi, come l’inizio di una nuova tappa della rivoluzione, dalle contemporanee elezioni parlamentari (il presidente non ha un partito di riferimento in parlamento) usciva un risultato nuovamente frammentato e poco chiaro, che ha portato ancora una volta a governi di grande coalizione.
Nell’anno e mezzo trascorso tra le ultime elezioni e gli eventi di questi giorni la Tunisia, come il resto del mondo, è stata assorbita dalla pandemia e dagli sforzi per la sua gestione. Se nel corso del 2020 il Paese e il suo ceto politico è sembrato all’altezza della sfida, riuscendo a mantenere il contagio sotto controllo e a disporre dei piccoli assegni sociali per le persone costrette all’isolamento, negli ultimi mesi la gestione della pandemia è stata il terreno su cui si sono potute misurare le disuguaglianze strutturali e contingenti del Paese. Se la lentissima campagna di vaccinazione (ad oggi è vaccinato l’8% della popolazione, mentre ad esempio in Marocco i vaccinati sono il 27%) ha mostrato la disorganizzazione e l’inefficienza dell’amministrazione statale, gli effetti della quarta ondata sul settore ospedaliero pubblico sono stati devastanti, con un’insufficienza cronica di letti e terapie intensive. Il diritto alla salute è diventato, ancor più chiaramente di quanto non lo fosse in precedenza, una questione di prezzo, come quello dei concentratori d’ossigeno, venduti sul mercato privato anche a 7.000 dinari, o come quello di un ricovero di due settimane in una clinica privata, con fatture che superano i 30.000 dinari, quasi 50 volte uno stipendio medio.
Nell’ambito di questa crisi socio-sanitaria, Saïed, che continua a porsi come un outsider nel campo politico, ha deciso di risolvere il lungo stallo parlamentare e il fallimento governativo azzerando il sistema. A creare l’occasione adatta sono state le proteste del non meglio noto “movimento del 25 luglio” che in concomitanza con la festa nazionale per la proclamazione della repubblica ha organizzato cortei in molte città del Paese, prendendo d’assalto le sedi di Ennahdha, considerato dai manifestanti l’epicentro del sistema di corruzione politica. In serata il presidente Saïed ha parlato al Paese, annunciando l’attivazione dell’articolo 80 della costituzione che in caso di una “situazione eccezionale” di pericolo per il Paese permette al presidente della repubblica di adottare le “misure necessarie”. Molti osservatori concordano nel considerare le misure adottate da Saïed non giustificate dalla situazione e contenutisticamente molto al di là del perimetro costituzionale. In particolare, la decisione di bloccare i lavori parlamentari per un mese (quando lo stesso articolo 80 prevede la convocazione dell’Assemblea in sessione permanente) e di togliere le immunità parlamentari (prerogativa non dell’esecutivo ma del potere legislativo) confermano la forzatura indotta da Saïed.
Mentre le cancellerie straniere esprimevano dunque tutte le loro preoccupazioni, chiedendo un ritorno alle regole democratiche, concepite sempre e solo da un punto di vista della formalità procedurale, nella materialità delle strade tunisine le reazioni erano di segno opposto. Sin dai minuti successivi al discorso di Saïed le strade delle principali città del Paese si sono riempite di una folla di persone festanti per l’allontanamento delle élite corrotte. Reazioni a caldo e che comunque vedono escluse una parte significativa della popolazione tunisina (Ennahdha è dal 2011 il primo partito del Paese e il più organizzato), ma indicative delle aspettative e speranza ancora insaziate di una gran parte della popolazione.
In queste ultime ore, ancora non sufficienti per sviluppare un giudizio sulla traiettoria degli eventi, Saïed ha dato segnali contrastanti. Da un lato l’irruzione delle forze di polizia nella sede di Al-Jazeera, gli stringenti controlli a cui sono sottoposti i giornalisti esteri, le epurazioni nell’amministrazione, il divieto di riunione in pubblico in più di 3 persone (formalmente per fermare il contagio) e le indiscrezioni su una prossima indagine per corruzione che coinvolgerebbe molti deputati, specie dei partiti di maggioranza, hanno effettivamente destato preoccupazioni per un utilizzo politico delle forze armate e del potere giudiziario che non può non ricordare i regimi del passato tunisino. Al tempo stesso però, il tentativo di abbassare i toni dello scontro politico e di coinvolgere i maggiori organismi della società civile protagonisti della rivoluzione (l’Ugtt, maggior sindacato tunisino, l’ordine degli avvocati, la lega dei diritti umani e l’associazione delle donne democratiche) mostrano un Saïed conscio dei suoi limiti e attento a preservare alcuni canali di dialogo con le forze politiche e sociali.
Alcuni esiti possibili per il breve e medio termine
Per ciò che riguarda l’esito di questo scontro politico e istituzionale, le tre ipotesi messe sul tavolo da Vincent Geisser sembrano attualmente le più plausibili: la trasformazione dell’azzeramento del sistema in un ritorno all’autoritarismo sostenuto dai militari (poco presenti nella vita politica tunisina) e dalle forze di polizia (vero pilastro del benalismo); una deriva plebiscitario-presidenzialista del sistema democratico tunisino; il semplice cambiamento dei rapporti di forza politici nel corso della legislatura, con la formazione di una maggioranza parlamentare riunita intorno al presidente e libera dai condizionamenti di Ennahdha.

Al netto delle possibili soluzioni politico-istituzionali della crisi, quello che ci restituisce il torrido luglio tunisino con le sue preoccupazioni e le sue speranze è l’impossibilità di funzionamento di un sistema democratico solo da un punto di vista formale e non materiale. Le contraddizioni e le disuguaglianze del Paese sono profonde e non risolvibili nel giro di pochi anni, basti pensare al differente sviluppo delle regioni costiere comparate a quelle dell’interno, alla disoccupazione endemica, alla crescente povertà lavorativa, agli squilibri commerciali. Inoltre, il grande debito accumulato dal Paese (30 miliardi di dollari verso l’estero) e la pressione al deprezzamento del dinaro stanno costringendo a concordare con l’Fmi il quarto prestito in dieci anni, lasciando poco spazio per immaginare nel breve futuro politiche economiche diverse dall’ortodossia neoliberale. Tuttavia, i/le tunisini/e scesi/e in piazza dopo le parole di Saïed hanno posto con forza una questione di metodo, prima ancora che di risultati. Un metodo che non è quello del formalismo elettorale e procedurale ma quello concreto della giustizia sociale. Riesumando gli slogan di dieci anni fa, primo tra tutti il celebre “dégage”, hanno manifestato contro un sistema parlamentare diventato nella narrazione comune l’apice di un modello d’ingiustizia e di prevaricazione.
Se la mossa di un Saïed, rischiosa e non scevra da grandi problematicità, si risolverà in un nulla di fatto, in un accrescimento dell’autoritarismo in Tunisia o se invece sarà l’inizio per una seconda fase della rivoluzione, centrata sulla garanzia dei diritti economico-sociali è presto per dirlo. Quello che è certo è che in questo luglio i/le tunisini/e hanno ripreso ad appropriarsi della politica come non facevano dai tempi della rivoluzione, dimostrando che, indipendentemente dagli esiti imprevedibili, quest’ultima rimane un cantiere aperto. Che non necessita di lezioni da parte della sponda nord del Mediterraneo.
(Foto di copertina Middle East Monitor)